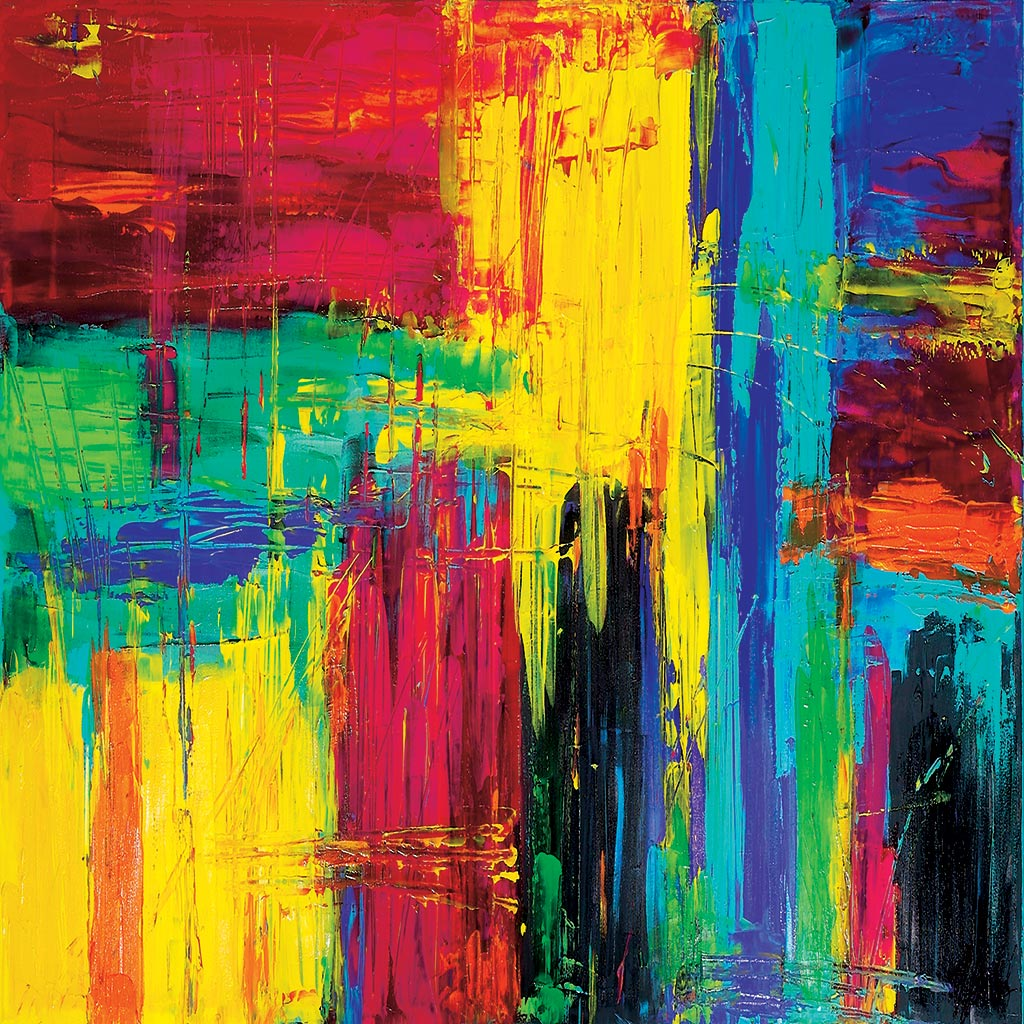Caro Damiano,
ho appena finito di rileggere le tue Storie, che gentilmente e con gratuità mi inviasti alcuni mesi fa. Vorrei ricambiare la tua fiducia con una serie di appunti e riflessioni che non vogliono essere veramente una recensione, ma piuttosto una sorta di dialogo o scambio a distanza.
Il tuo è un libro che non mi ha lasciato indifferente – devo dire anzi di averci avuto un rapporto conflittuale, e questo aver smosso le acque potrebbe essere un bene. Da un lato, ammiro l’operazione che vi ho intravisto, e sulla quale tornerò nei paragrafi successivi. Dall’altro, la poetica che mi sembra sottenderla (e che forse è costitutivamente legata al tipo di operazione che hai svolto) è agli antipodi del mio modo di volere e intendere la poesia. Questi due aspetti si richiamano come due facce della stessa medaglia, e pertanto cercherò di intrecciarle nella mia argomentazione, seguendo le suggestioni e le tematiche dei tuoi testi. C’è parecchio da dire, e spero di farlo in maniera non troppo disorganica.
Già il primo testo mette in scena un io poetico indebolito, recipiente della forza perlocutoria di un “tu” imprecisato ma che possiamo dedurre intimo. L’io si comporta come un riccio – il suo attacco è la difesa, è l’evasione nella storia e negli studi (Costanza d’Altavilla) contro un esterno che arriva nella forma mediata della semiosi piuttosto che nella cruda esperienza. Il vecchio Montale scriveva che il male degli altri non ci riguarda (cito a memoria), e qui l’io non fa mistero del proprio voler essere lasciato in pace in una sorta di ovatta. Stessa attitudine – ma più spavalda, più proattiva – si ritrova nel testo di p. 33 (mi secca, me ne infischio). C’è quindi il tema della non-comunicazione, che però non viene dall’impossibilità di capirsi ma dalla scelta di non ascoltare, o meglio di non “connettersi” (protezione dal bombardamento di informazioni inutili o egoismo utile a una propria sopravvivenza?).
Dunque quello che scrive Gezzi nella prefazione – il fatto che non ci sono ammiccamenti, almeno formali, alla prosa – io lo estenderei alla mancanza di ammiccamenti nei confronti del lettore: l’io poetico non sembra infatti avere intenzione di piacere al lettore. Anzi, come dirò più avanti (ed è questo il nodo di ammirazione-rifiuto cui accennavo prima) nemmeno si tratta di un io poetico, ma piuttosto di un “io sovrapersonale” che è somma di atti o riflessi quasi involontari, dove non trovano posto né la volizione né – il che è forse lo stesso – la voglia di riscatto simbolico. Ecco, questa è parte dell’operazione che esteticamente apprezzo per il fatto di servirsi di uno stile apparentemente autobiografico, confessionale, per in realtà scansarne l’egocentrismo. La dichiarazione di poetica di Storie sta forse tutta in questo verso, soprattutto nell’avverbio che lo chiude: parlano di dolore, impudicamente (p. 36), e in effetti la grotta sanguinante della stessa poesia forse simboleggia (uno dei pochi simboli dell’intero libro) un proprio apprendistato poetico di marca eccessivamente lirica, che ora si rinnega per azione uguale e contraria. Un’operazione, inoltre, che spesso insegue un vagheggiato grado zero della scrittura (nessuno scarto del lessico in alto o in basso, assenza dell’ipotassi, chiarezza estrema delle poche metafore, e così via). Questa operazione mi sembra erodere gli istinti più espressivi dell’io enunciante proprio come, all’opposto, uno stile ipertrofico e massimalista tenderebbe ad enfiarli con risultati talora drammatizzanti e talaltra ridicoli. Quello a cui tu sembri voler rinunciare è l’idea di idioletto, di stile sociologicamente atto a identificare un parlante specifico. Se questa mia tesi tiene, mi è difficile non postulare un certo tuo fastidio nei confronti dell’equazione a tre termini stile=espressione=personalità, avversata a carte più scoperte e con maggiore veemenza nelle operazioni sperimentali di un Broggi o di un Ramonda. Ecco, è proprio contro questa sottesa poetica anti-romantica (che percepisco come rinunciataria e deterministica), che io dirigo tanto la mia pratica poetica quanto quella critica.
Dopo questa digressione – ma centrale per il mio argomento – torno ad altri temi, ad altri testi. Pratichi una poesia anti-simbolista ma a tratti, forse, persino anti-introspettiva, quasi un referto di cronaca. Non posso non prendere a esempio il testo a p. 35, proprio perché la sua occasione-spinta è simile a quella che generò un mio testo (nel mio caso, fu un lapsus, ma legato alla malattia terminale di un mio zio). Qui esponi con brutalità quell’esperienza che altrove era mediata dalla semiosi, dai mezzi di comunicazione-connessione. Però scegli di farlo mediante una presa esterna – extradiegetica – e quindi sta al lettore trarre un insegnamento dalla parabola, piuttosto che soffermarsi sul sentimento di colpa verosimilmente provato dall’io poetico. L’io è dunque ridotto a un riflesso o a un elemento di uno sfondo, o quando è presente lo è in modalità “stand-by” – il sogno, per esempio, quasi a rimarcare l’impossibilità o persino la poca augurabilità dell’azione, verbale o fisica che sia. Non è un sogno, scrivi a p. 14, ma in realtà lo sembra – un sogno ad occhi aperti, in dormiveglia forse, ed è anche impossibile non interpretare la negazione come una affermazione più forte, come quando Sereni scrive non era un sogno, vi dico (La speranza). Speculare a questa è la poesia a p. 25, dove però il sonno fa emergere empatia nei confronti del tu (non a caso la poesia è nella sezione aperte), e quella a p. 41 che ha una grazia orientale (non solo per l’aggettivo tibetano).
Per aperte si apre (perdonami il poliptoto!) un discorso a parte, giacché per questa sezione il mio giudizio è più positivo. Non solo perché più lirica – e quindi più sostanziata da un’esperienza che dice più dell’interiorità di chi scrive piuttosto che inseguire una sorta di datità depersonificante – ma anche perché la mancanza di punti a fine verso, che secondo me rende talora meccanica la lettura delle altre sezioni, mette proprio meglio in evidenza l’idea e la pratica del verso-frase. Il verso ne sono passati di mondi sotto l’acqua (p. 26) ha una dizione mossa, latamente esclamativa e che è chiave d’accesso verso il sentimento di chi strive; riuscito lo scrambling, o permutazione, dell’espressione idiomatica “ne è passata di acqua sotto i ponti”, e quindi sottotraccia c’è il topos del tempo che scorre, del tempo fatto acqua (Montale). L’esotismo di questi nomi slavi e balcanici (Bratislava, Zlotogrod) da un lato richiama l’idea delle mappe e la poesia a p. 14 e i meridiani della già citata poesia a p. 25; dall’altro, la dislocazione sa più di apertura al cambiamento che di fuga o evasione, come accadeva invece con Costanza d’Altavilla.
Bella, nella poesia a p. 34, la polivalenza che leggo in quel ci tocca iniziale (“ci tocca sopportare” oppure, al contrario, “ci tocca, ci commuove”, quindi portando a compimento la tensione fra indifferenza e volontà di contatto che c’è nel libro) e l’inattesa impennata lirica del finale (bevendo la luce del mattino) che è – forse ironicamente, o per pudore? – affidata ai manichini anziché ai personaggi in carne e ossa delle altre poesie. O anche, per ordine marcato dei costituenti sintattici e quindi per l’ordo sereniano, il verso le razze è stato un brivido toccarle appena (senza contare che “razza” appare in Un posto di vacanza). E il finale della poesia a p. 29, per l’esattezza concettuale dell’immagine – mentre trovo un po’ canzonettistico il finale della poesia a p. 28 (c’è freddo anche dentro l’amore).
Vorrei concludere con la poesia che a mio avviso è probabilmente la migliore – o la più importante, e per me qualità e sostanza spesso coincidono – del libro, per rivendicare anche la direzione che sempre secondo me andrebbe intrapresa con più vigore nelle opere future. Mi riferisco alla poesia a p. 18. Qui, senza tradire la matrice di contingenzialità effimera e la debole testimonialità dell’io (di cui è spia, fra l’altro, quell’immagino che a camminare fossero in tanti, modalità epistemica tipica dei testimoni insicuri o trasognati), si apre una semi-allegoria, quella dell’onda di protesta che forse scava in profondità. C’è un fantasma, ma presente, di collettività e riscatto; qui non sembra speso invano il nome di Fortini. Infine, fra parentesi, aggiungo che quel bel verso passano le macchine, anch’io di tanto in tanto sembra riprendere l’Apollinaire del Ponte Mirabeau nella traduzione di Sereni: i giorni vanno io non ancora.
Davide Castiglione, 3 aprile 2016
Caro Davide,
ti ringrazio per la tua lettura e accurata scheda. Mi conforta sapere che il libro sia arrivato in mano a una persona così sensibile, e anche se non c’è affinità – come giustamente dichiari fin dal principio – ciò non toglie che si possa ragionare intorno a diverse idee di poesia. Sul tuo gusto quindi non posso discutere, sì invece sugli aspetti che tendi a focalizzare o a mettere ai margini.
Se non sbaglio, il tuo giudizio nasce da questa polarità: da una parte apprezzamento per lo stile apparentemente autobiografico ma non egocentrico; dall’altra insofferenza per la bassa espressività e per il sotteso antiromanticismo. Inoltre, tra gli aspetti negativi, parli di una “poesia anti-simbolica” e “anti-introspettiva”, con un io debole e refrattario. Se il riassunto è corretto, provo a dialogare su questi punti. Parto dall’apprezzamento, per poi dare più spazio alle critiche.
Io cerco di fissare sulla carta alcuni stati d’animo sfuggenti che attraverso la poesia diventano trasparenti, meglio percepibili. La sfida è dare concretezza agli stati d’animo, in modo che si irradino attraverso una situazione. L’andamento narrativo è necessario, perché il trasformarsi di una situazione mette in combustione uno stato emotivo e una comprensione del mondo. Cerco di evitare il cronachismo: raccontare un fatto non mi appassiona, ma se attraverso la sua angolatura riesco a cogliere una certa luce, o dare voce ad alcune sensazioni, perché rinunciare?
Il soggetto di questi testi non è un io che si impone con scelte nette: è al centro di una rete di eventi e situazioni più che il loro motore. Però da quel centro cerca di mettere ordine, di introdurre una forza che nasce dalla sua immaginazione e dai suoi sogni. Non è un io spavaldo, semmai qualche volta irritato. C’entra un po’ di tutto, con i lati luminosi e umorali. Considero invece superficiale affermare che ci sia un rifiuto della comunicazione: nella poesia su Costanza d’Altavilla vengono offerte delle scuse. Non ci sono fughe, semmai attrazione per le vite che sono passate, per le storie che sono accadute in questo spazio che anche noi attraversiamo per poco; in esse il centro non è l’io, ma gli altri, che hanno speso le energie in una vita che ci ignora e dalla quale siamo tagliati fuori, ma che da lontano possiamo ammirare e provare a ricostruire.
Sulla lingua avrei molte cose da dire, ma mi limito a citare alcune metafore a me care, come la “farfalla della perspicacia”, il “brillio di una postuma adolescenza” o “l’irrinunciabile occhiale della chiarezza”. Sono momenti-chiave dove la lingua non si impenna ma trova la sua vocazione attraverso l’inventività. Invece in molte poesie la lingua è piana, ma fluisce mescolando richiami interni e scendendo verso il finale, che è come il bersaglio verso il quale sfreccia ogni parola, anche se prima di arrivarci né io né il lettore lo potevamo prevedere.
Mi pare di aver dato una mia versione dei fatti, rispondendo con simmetria variabile a molte tue questioni. Il tuo approccio critico – ineccepibile, e non lo dico per piaggeria – ci ha condotto a leggere il libro da alcune angolazioni come l’io, la piattezza o lo scarto dello stile, il lirismo o il cronachismo; chissà che altre non ne vengano fuori, e nel caso sarei di nuovo felice di tornare a conversare.
Damiano Sinfonico, 25 aprile
Caro Damiano,
è sempre istruttivo e avventuroso entrare nel laboratorio di scrittura di un autore consapevole – e questa tua bella e articolata risposta, oltre a dimostrarlo, consente anche a me di misurare le sovrapposizioni e gli scarti tra ricezione e congettura (dal mio lato) e produzione e intenzione (dal tuo lato).
Mi interessa, tra gli altri punti che tocchi, l’importanza direi sia etica sia funzionale della narratività – questo è un tema che vorrei affrontare in un saggio, mettendo a fuoco diverse ma convergenti strategie narrative negli autori delle ultime generazioni e non solo. In effetti, le tue storie non possono certo essere ridotte a cronache (e mi scuso se certe mie formulazioni l’hanno lasciato intendere), ma al tempo stesso non si ergono a parabole (da cui il tuo comprensibile rifiuto nel mettere in scena un io “esemplare”). Restano anche sopra e oltre l’aneddoto, in una via di mezzo che fa forse leva su un sommerso emotivo che sta al lettore dedurre, partendo dal contesto tratteggiato dall’emerso del testo – come in certa narrativa americana cui accenni, del resto. Forse il tipo di fruizione che auspico per me stesso è più concettuale, e quindi attratto dalla possibilità di allegorie, come appunto mi è sembrato di intravedere nella poesia di p. 18 cui facevo prima riferimento. Ma non c’è dubbio che l’operazione che persegui si attaglia benissimo all’intenzione e alla poetica (e, prima ancora, al sentire) che ti sono propri, e che sono contento di aver còlto nelle sue linee generali.
Il tuo “non è un io che si impone con scelte nette: è al centro di una rete di eventi e situazioni più che il loro motore”: non potevi esprimere meglio quello che io mi sono limitato a catalogare come io debole o passivo. Credo che qui conti l’orizzonte, l’aspettativa con cui ci si accosta a un’opera; quando penso a un “io” forte nel testo lo intendo a livello più che altro di voce e tonalità percepita – del resto, nemmeno sono attratto dall’io-personaggio attivo e tratti violento di certa poesia confessionale. O forse è perché prediligo un io che in qualche misura è moralista o giudicante (preferisco Leopardi a Pascoli, Fortini a Penna, Auden a Heaney per dire; e di gran lunga il Sereni dialettico degli Strumenti a quello un po’ pastello di Frontiera), cioè che faccia pesare maggiormente il proprio esserci e dire.
Devo inoltre darti ragione sull’imprecisione (o approssimazione) della mia caratterizzazione stilistica della tua opera – normalmente mi dilungo più sullo stile che sulla poetica di un autore, ma in questo caso l’urgenza del dire apparteneva al secondo fronte. Quelle metafore che citi problematizzano certo l’ascrizione di un grado zero della scrittura, fermo restando il fatto che tu persegui una chiarezza comunicativa, una trasparenza del mezzo che si pone agli antipodi dell’opacità di sovrastruttura di certi sperimentalismi – per inciso, io mi sento a metà strada, distante da entrambi i poli (in lotta con entrambi?), e anche su questo vorrei fare, in futuro, qualche riflessione.
Di una cosa sono certo: è proprio confrontandosi con autori dal percorso diverso dal proprio, e al tempo stesso persone aperte e intelligenti, che si perviene a una migliore conoscenza o consapevolezza di sé proprio tramite lo sforzo di comprenderli. Il tuo mi sembra proprio uno di questi casi! Grazie per il bel dialogo.
Davide, 30 maggio
Caro Davide,
è interessante lo spettro lessicale in cui ci muoviamo: cronache, parabole, aneddoti, storie. Ho scelto come titolo l’ultima parola perché è meno definitoria rispetto alle altre e nello stesso tempo contiene un’idea aperta di sviluppo narrativo. E tengo a questa forma poetica perché mantiene un legame con la realtà, non può essere uno scivoloso innamoramento di parole. Più che aleggiare in un empireo, vorrei che le poesie trovassero il buco attraverso cui entrare nelle nostre giornate. Altrimenti, chiuso un libro di poesia, ne possiamo fare a meno.
Il rischio, per ogni persona che si mette a comporre versi, è quello di aprire la cassetta degli attrezzi e muoversi nel noto. Non esistono istruzioni per l’uso, ma a me piace, per esempio, chi scrive per raccontare una bella o brutta giornata, mettendoci un qualcosa per cui questa giornata possa essere letta ancora dopo cent’anni con la stessa brillantezza. Quel qualcosa cambia tutto, come quel non so che che usavano i romantici.
Vorrei salutarti condividendo una poesia di Ermanno Krumm, che mette insieme eleganza, precisione e slancio:
Alla mia destra
A letto ti voglio sempre dallo stesso lato
non perché sia quello che preferisco
del corpo o del volto ma perché
come i rami di un vegetale
pendo verso la luce da quella parte
e a vederti mi sporgo
con gli occhi della giovinezza.
Damiano, 9 giugno
Caro Damiano,
ti ringrazio per aver ripreso il filo (il nodo?) della narratività, che è fra quelli che più mi interessano. Quello che dici conferma in un certo senso l’eticità della scelta narrativa, che mette un argine agli svolazzi egotico-retorici dell’io che altrimenti (specie in Italia, forse) è sempre a un passo dal pontificare.
Ti ringrazio anche per la bella poesia di Krumm, che non conoscevo e che con molta grazia coniuga inventività analogica e dolcezza amorosa. È senz’altro una poesia che dimostra (e io qui sono d’accordo con te) che un libro di poesia non debba essere una cassetta degli attrezzi, o meglio, almeno per me: anche laddove gli attrezzi siano visibili o perfino vistosi, essi dovrebbero essere diretti verso una esperienza condivisa o condivisibile in potenza, meglio se ancorata a un mondo più o meno riconoscibile e nostro. Eppure, oggi leggiamo con più freschezza un Wallace Stevens rispetto a un Ezra Pound, benché il mondo poetico del secondo stia tra gli uomini e i loro rapporti economici e sociali, mentre quello del primo in una sorta di eremo rarefatto ed enigmatico… ciò che conta allora, forse, è la tensione verso una qualche trascendenza (l’eredità romantica che citi nell’ultima risposta, e che certo apparteneva anche a Stevens), calata o meno nel quotidiano.
La provocazione con la quale vorrei chiudere, allora, è questa: sarà possibile per noi autori rendere condivisibile una qualche forma di sublime (senza scadere nel ridicolo del neo-orfismo), senza al tempo stesso feticizzare l’esperienzialità del quotidiano, il culto dell’immanenza che rischia (come in molta letteratura americana) di darsi come unica pietra di paragone della realtà? È insomma possibile rendere sensuale o amichevole un concetto astratto, o una teoria fisica? Chi scrive oggi, ai lettori futuri dovrebbe richiedere rispecchiamento o esigere un conflittuale avvicinamento?
Davide, 14 giugno