«Speri che arrivi una guerra o un terremoto. Un’invasione di cavallette. Le cavallette o qualcosa tipo cani randagi pustolosi, rabbia e peste, che ci contagiano con un morso, ci contagino tutti. Le cavallette devono essere grandi. E i cani, molto feroci».
La Sardegna è terra esplosa, sismica, cataclismatica. Attira nelle sue pietre immote le energie magnetiche di un’apocalisse canina, ferina. L’umanità ridotta a bestialità, una vocazione che trova la congiuntura di un’infezione micidiale, una pandemia insulare, una biblica ribellione dei cani e un rosario di attentati dinamitardi per dominare il mondo, o almeno, la terra sarda. Ma da questa rovina secolare sorge una specie di nucleo resistenziale, una banda di personaggi che in un modo o nell’altro si ritroveranno al seguito di una coppia, una rinnovata comunione edenica coi progenitori di lusso Adamo ed Eva. Insomma, una famiglia.
«Perché sono qui?
Cosa cerchi? Dice il cane nero mentre salta un’altra cagnetta.
Chi è Maria?
Hai sentito il vento?
Sì.
Maria è quello che cerchi.
Una donna.
O una cagna. Quando la troverai, saprai»
È indubbio il dispiegamento di forze messo in campo da Gianni Tetti in questo suo Grande nudo, che in qualche modo riprende temi e ambientazioni – seppur non presentandosi come un figlio diretto – dei precedenti romanzi I cani là fuori (2010) e Mette pioggia (2014), editi, come questo, da Neo. Edizioni.
E per forze s’intendono proprio sbocchi d’energia da faglie testuali. Il testo. Già, il testo con la prosa di Tetti si disarticola, cessa di accordarsi a una sintassi narrativa, una diegesi d’eventi e di ‘discorso’ per divenire flusso, musicalità tribale e selvaggia. Tutti quanti siamo gettati nel flusso, nello stream e Grande nudo è un incessante catalogo di efferatezze e orrori, una mostra delle atrocità lasciata scorrere in uno streaming infinito appunto. Un flusso sempre più insostenibile, sempre più urgente, proibito, senza tregua, che, come nelle meditazioni-narrazioni di Moresco, cessa di scioccare il lettore per divenire ripetizione.
Ripetizione. Il fraseggio dello scrittore è frammentario, sincopato. Brevi periodi che fanno della ripetizione e della ripresa il principio musicale e compositivo della partitura. Ma forse il termine non è esatto. Quella di Tetti non è la sconvolgente e lì sì ‘religiosa’ ossessione per la replica che guida il cammino di David Peace. Nelle pagine dello scrittore inglese si assiste alla straordinaria e coraggiosa ripresa puntuale, con minime variazioni, d’inserti di prosa. Stralci e brani di già-detto per invocare la rivelazione del dio. La ierofania – che nel caso di Peace è sempre nera – giunge proprio da questo tessuto invariabile. È invocazione pascaliana: intanto prega, poi la divinità arriverà.
Per Tetti, invece, di altra ossessione si nutrono le sue pagine. È la messinscena di uno sfascio molto più morale, molto più terragno, sebbene bordate di sfiducia cosmica sommergano le pagine. Il cosmo c’entra, sì, ma come ordine di grandezza. Ciò che interessa a Tetti – e che, purtroppo, limita l’ampiezza del romanzo – è l’uomo, nel suo adoperarsi vano per civilizzare la scimmia che porta sulla propria schiena (ma qui lo splatter è fumettistico, non lisergico, è Hostel più che Burroughs). Il consorzio umano, del quale ci vengono presentati alcuni personaggi emblematici, come Signor Mario, nominato con questa dizione ‘assoluta’, ovvero nell’agglutinata necessità di presentarlo come se fosse una maschera (appartiene a questa categoria di personaggi «signora fiori secchi», che sta ovviamente per ‘la signora con i fiori secchi’), quasi con una prosopopea.
L’umanità, si diceva. Criminale, violenta, bestiale, spietata. Capace di nefandezze inenarrabili: solo che la voce narrante, le voci narranti, il coro polifonico di questa sorta di registrazione rupestre, ecco questi testimoni attivi e passivi le narrano. Si chiudono gli occhi e s’arresta il respiro in gola quando si legge del destino cieco e regressivo che tocca a Maria, angelo del sacrificio, vittima designata, puro corpo martoriato dalla bizzarra disposizione di una possibilità. L’essere umano è peggio di un cane, infatti i cani risparmiano i bambini e mangiano le facce degli umani e un «cane nero» (come quello che alita sulle pagine del romanzo, come quello che compare fin dalle prime pagine, fin dall’allucinazione del primo omicidio primordiale) – è l’apparizione di uno spirito dionisiaco. L’uomo è peggio di un cane in quanto capace di tutto quello che il suo desiderio impone. Gli strali anticattolici (ma anche qui è satira più che denuncia) si fanno mimesi di un desiderio castrabile:
La vostra superiorità risiede in questo. Desiderare vi rende normali, uguali ai comuni mortali. Vade retro, corpo maledetto. Non siete comuni mortali. Il cilicio è una soluzione, certo, la fustigazione, sì, anch’essa una soluzione. L’ho praticata con profitto ed ora eccomi, forte e vincitore. Poenitentiam agite, appropinquabit enim regnum caelorum. Ripetiamo insieme. Poenitentiam agite, appropinquabit enim regnum caelorum. Il superiore alza le braccia. Ripetiamo! Poenitentiam agite, appropinquabit enim regnum caelorum. E voi ripetete. Più volte. Le parole si perdono, si confondono nel loro riverbero.
Nelle sue parti migliori questo ponderoso romanzo (più di 600 pagine fitte) è una riflessione sulla libertà dell’uomo. Ma la frammentazione, che disincaglia la sintassi da un ordito altrimenti tradizionale, è di servizio a un tono troppo apologetico. Non c’è rottura di una superficie omogenea, attraversamento della soglia – come accade invece nelle prove migliori del magistero che presiede questa opera: Antonio Moresco, appunto. Mancano gli spazi bianchi in questo romanzo. Come un Apuleio crudele e gore anche Grande nudo è sulla via della metamorfosi. L’uomo-cane. È quella la sua aspirazione baconiana, deleuziana: farsi reale, inudibile, slogare il linguaggio dalla verticalità, accedere alla sorgente stessa della slogatura, dove le enormi tensioni gravitazionali piegano le parole fino a farle combaciare con se stesse. Non si può rimanere indifferenti di fronte a questo coraggio – eppure più volte si ha l’impressione che i materiali siano stridenti: tutto è accelerato fin da subito, col rischio di saturazione.
Uno dei bersagli preferiti dell’autore è la televisione. È dalle nefandezze catodiche che nasce il corpo tumefatto all’inverosimile, martoriato e picchiato, violato, vilipeso, maltrattato, stuprato, sul quale la disinvolta sete di carne e sangue del suo aguzzino si è accanita, il corpo di Maria. Sangue di Cristo. Chi si ricorda del Siero della vanità di Alex Infascelli (soggetto di Niccolò Ammaniti)? Quel dispetto tragico, quell’accanimento darwiniano viene da lì. Da quelle turpitudini sembra che Tetti abbia immaginato la sua resa dei conti tanto letterale da essere appunto favolistica. E di nuovo, forse, lo sforzo non basta. Forse questi interregni infernali hanno bisogno di un afflato diverso, tragico e distanziato per essere efficacemente rappresentati.
Sono molti però i personaggi memorabili di questo girotondo della devastazione. Signor Mario, su tutti: miserabile e spietato. Don Casu, pervertito e coraggioso. Maria Domini, madre e cagna, centro linguistico di tutto il romanzo. Candida, paralitica e desiderata, che s’intrattiene con volontari e a parecchi fa girare la testa, soprattutto a Valentino, «infermiere. Gi-go-lò», come lo additano le vecchie beghine. E poi lei, bellissima, la bambola Camille, così reale che i soldati quando la trovano si concedono – a turno, come le gerarchie militari impongono – una scopata come dio comanda. Personaggi di carne pesante così come c’era Metallo Urlante (con il quale Tetti sembra avere alcuni debiti).
L’umanità è fertilizzante, ormai. Lo sguardo dello scrittore rimane ad altezza uomo, sebbene in quell’universo faccia irrompere cani che parlano, profezie, perversioni così fantasiose da essere, ça va sans dire, più vere del vero.
Tutto il romanzo è percorso da profezie da elementi linguistici. Il riferimento continuo a un «Libro», che ripercorre la cronologia degli attentati che fanno saltare il centro di questa isola maledetta. Ma rientrano in questa galassia linguistica anche i racconti uditi al bar da Signor Mario o le leggende.
Insomma, Grande nudo ambisce ad essere un racconto liquido dell’età contemporanea, un canovaccio aggiornabile con materiali spuri: il «Libro», di fatto, è un regesto di documenti e testi che provengono da regioni letterarie ‘differenti’ e anche da regioni non-letterarie, compreso dalla ‘glossolalia’ dei social.
Gianni Tetti arde la sua terra sarda, la fa reagire con un Fedro scuoiato da Eli Roth, una favola che non teme l’inferno in terra, le profondità umane, morali, terrestri, che abbuia la scena per trovare un varco della luce – metodo moreschiano, di nuovo – ricerca l’oralità tribale del linguaggio globale, per essere ancor più sul pezzo del tempo presente.
Sbalordisce la forza di certi passaggi, con un uso epistemologico dell’oscenità. Il calvario di Maria, ad esempio, o la perfetta corporalità di Camille sono stradari di conoscenza, disegnano mappe di dolore e ridisegnano il mondo su queste nuove coordinate.
L’inferno messo in scena – e in terra – da Gianni Tetti vi aspetta, dunque.
L’isola la conoscete.
Molte volte ci siete stati in vacanza.
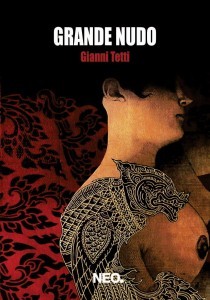 Gianni Tetti, Grande nudo, Neo. Edizioni, 688 pagine, € 17,00
Gianni Tetti, Grande nudo, Neo. Edizioni, 688 pagine, € 17,00
Immagine: Edvard Munch, Il sole, 1909.