Luciano Funetta ha esordito nel 2016 con il meritatamente fortunato romanzo Dalle rovine. Quando il libro uscì, ne scrissi una breve recensione per Carteggi Letterari; recensione che, tuttavia, è stata cancellata dal sito per ragioni indipendenti dalla mia volontà. In quella nota di lettura, notavo due cose che mi sembrano vere ancora adesso: la prima, che avremo il privilegio di morire solo quando riusciremo a renderci conto di essere già morti (e questo è vero sia a proposito di Dalle rovine che della vita in generale); la seconda, che il libro di Funetta, che pure mi era piaciuto molto per il tipo di narratore che impiegava (una spettrale prima persona plurale) e i temi che ingaggiava, tendeva a ridursi quasi del tutto a un esercizio di atmosfera, e non riusciva a creare una vera tensione narrativa: lo scioglimento del libro mi sembrava più prevedibile e meno interessante del dovuto.
Questo giudizio che avevo dato mi si è riaffacciato alla mente leggendo Il grido, il nuovo romanzo di Funetta (Chiarelettere, 2018). Il grido è ambientato in una città misteriosa e senza nome, in completo disfacimento, senza più sistema di trasporti e popolata di tossici, sbandati, e figure inquietanti. Una città fantasma sia nel senso più immediato di città deserta, spopolata, sia perché agisce proprio come fantasma, perché la sua geografia fallata e le sue strutture in abbandono infestano la vita dei protagonisti e la minacciano. Il romanzo segue la storia di Lena, impiegata in una ditta di pulizia come tutte le altre ragazze cresciute nell’orfanatrofio delle Dame e perseguitata da cupe allucinazioni; e non è facile parlare di trama, per questo libro fatto di un susseguirsi di scene lugubri e squallide, e di aneddoti di un passato difficile da raggiungere. Come in Dalle rovine, è attivo (benché più diluito) anche ne Il grido il modello di Bolaño, nella rappresentazione di una città illimitata e incontrollabile, dove le donne sono in costante pericolo.
Non si può dire che Il grido sia un brutto libro: Funetta ha una prosa evocativa e ricca (Lena ha fumato, e «l’hashish le aveva riempito la scatola cranica di nebbia e limatura di piombo», p. 103; «Alhambra sembrava un’alga albina», p. 136). Allo stesso modo, le atmosfere di degrado e minaccia della città senza nome sono costruite con eleganza: Funetta è sempre molto attento a non spiegare troppo, a lasciare il più possibile dei dettagli indeterminati, in modo da accrescere l’interesse del lettore, che non vede la geografia fantastica della città ridotta a una piantina turistica. In questo senso, Il grido vale la pena di essere letto, perché non è frequente trovare in Italia narratori con questa sicurezza nei propri mezzi espressivi. Allo stesso modo, nel libro ci sono anche delle intuizioni molto felici, come le passeggiate nella foresta che Lena fa usando una simulazione virtuale governativa – il che permette a Funetta tanto di rimarcare l’abbruttimento urbano quanto di dilungarsi in belle descrizioni di questa ricostruzione (e delle sue discrepanze, come scopre il lettore addentrandosi nel testo).
D’altra parte, così come un film non si riduce alla qualità della sua fotografia, un libro non è fatto solo dalla sua prosa – o dalla sua atmosfera; e la vaghezza del romanzo di Funetta confina pericolosamente con la sconclusionatezza. Ci manca il sangue, come diceva Caligola. I tre tronconi principali della narrazione (il recupero del cadavere dell’amica in una città in cui i cimiteri sono visitabili soltanto via internet; le passeggiate nei boschi virtuali; e l’infestazione spettrale dell’orfanatrofio) sono accostati in maniera posticcia, e finiscono per creare un catalogo di esercizi di spettralità variamente ripresi dall’immaginario del gotico contemporaneo – spettri del passato e del digitale, della violenza del capitale e del degrado urbano, e così via. Il finale ad effetto, in cui si uniscono le passeggiate virtuali di Lena e la minaccia che viene dalla sua infanzia, è lirico e pittoresco, ma risulta artefatto, frettolosamente preparato, e non pare unire in maniera significativa le due parti della storia. In altre parole, Il grido finisce per essere una somma di aneddoti più o meno inquietanti e suggestivi, che non collimano in una sintesi efficace.
Come molti recensori e saggisti hanno avuto modo di notare, ci troviamo in un momento di grande fioritura per il fantastico italiano. Ha scritto Giuseppe Carrara che «sembra stia emergendo […] una corrente tellurica nella letteratura recente che non è più soddisfatta con le rappresentazioni e le convenzioni realistiche (di cui nel 2008 si salutava finalmente il ritorno)». Ne sono rappresentanti autori come Mauro Tetti, Orazio Labbate, Francesco D’Isa, Luca Bernardi, Andrea Morstabilini, e così via, fino al caposcuola (al capobastone?) Antonio Moresco – e ne sono naturalmente artefici Vanni Santoni e Andrea Gentile rispettivamente per Tunué e Il Saggiatore. Quest’ultima si è esercitata anche in operazioni mirate di riscoperta di grandi classici dell’horror, ripubblicando Le montagne della follia di Lovecraft nella bella traduzione di Andrea Morstabilini, e portando finalmente Thomas Ligotti all’attenzione del pubblico italiano.
Si tratta di una moda (un modo) letterario che non si può non salutare con entusiasmo, soprattutto in un Paese, quale è l’Italia, in cui per lunghissimo tempo si è guardato al fantastico letterario come a soprannaturalismo reazionario. Prova ne sia l’impressionante bibliografia commentata radunata da Stefano Lazzarin e dalla sua equipe, Il fantastico italiano: un’impresa monumentale che copre però la storia letteraria solo a partire dal 1980, anno prima del quale era virtualmente assente un dibattito sul fantastico in generale e sull’horror e sul gotico in particolare. La stessa parola “fantastico” è una parola alta, che viene da Todorov e Ceserani, e dunque da critici accademici che hanno sempre mantenuto, nei loro studi sul genere, un atteggiamento non privo di distacco e diffidenza. Ha scritto Fabio Camilletti nel suo recentissimo Italia lunare (Berna, Peter Lang 2018):
Impostasi nel dibattito critico sull’onda del celebre saggio di Tzvetan Todorov sulla littérature fantastique, uscito nel 1970 ma tradotto in italiano nel 1977, l’idea di fantastico italiano tuttora prevalente viene di fatto elaborata in un quinquennio – tra il 1983 e il 1988 – in cui «tre modelli teorici […] risultano atti a saldarsi reciprocamente, formando un amalgama di abbagliante prestigio»: «il fantastico “colto” e mainstream» di Enrico Ghidetti e Leonardo Lattarulo, che nel 1984 danno alle stampe i due volumi di Notturno italiano; il «fantastico “intellettuale”» teorizzato da Italo Calvino in vari saggi e conferenze; e il «magico-surreale “intelligente” e “ironico”» antologizzato da Gianfranco Contini in Italie magique (1946), che proprio nel 1988 viene per la prima volta riproposta in lingua italiana. Modelli prestigiosi, certo: ma forse proprio per questo particolarmente invasivi, nell’aver imposto un’immagine del fantastico italiano che resta in larga parte infondata da un punto di vista storico, viziata da quello ideologico e restrittiva da un punto di vista critico. Il fatto è che questo fantastico esclusivamente letterario e “alto”, intellettualistico e razionale, taglia precisamente fuori – e l’elisione non è innocente – la contaminazione con altri codici e la cultura “popolare”, il manieristico e l’irrazionale: e si può, certo, ammonire di non mescolare la letteratura fantastica «con una quantità di altri prodotti letterari, anche della letteratura più bassa e di consumo» che ne inquinerebbero una presunta “identità”; ma con la consapevolezza, così facendo, di perdere di vista la complessità di un fenomeno caratterizzato proprio dal suo costante muoversi tra “basso” e “alto”, nutrendosi di suggestioni esterne anche, e spesso, delle più triviali (pp. 8-9).
Non è un caso, in effetti, che a “fantastico” si vada sostituendo come termine pigliatutto “weird” (“weirdness”, secondo Alcide Pierantozzi; ma non capisco perché): una parola in grado di descrivere un’appropriazione alta, colta, consapevole di un genere che nasce invece e si sviluppa come popolare (e non a caso il termine è mutuato dal lavoro di China Miéville e Jeff e Anne VanderMeer, fondatori del cosiddetto New Weird).
Per questa ragione, se si legge a proposito del fantastico in Italia, si finisce quasi sempre non per leggere saggi sulla sua manifestazione più genuina e di largo consumo (come la grande stagione dell’horror italiano del tridente Bava-Argento-Fulci, o di prodotti inclassificabili come Dylan Dog, o la diffusione dell’occultura di cui parla Fabio Camilletti), bensì sui suoi recuperi alti, ironici, superciliosi. Ma davvero, per l’horror italiano, o meglio, per la fortuna dell’horror italiano e la sua diffusione presso il pubblico, Calvino e Landolfi sono più importanti di Dario Argento? Weird è probabilmente la parola giusta per definire i romanzi degli autori che menzionavo prima, perché è aggiornata al presente, e perché questi romanzi non si possono propriamente dire né horror né gotici – e tuttavia, si tratta di un termine che nasce esplicitamente da un rifiuto di apparentarsi al mainstream letterario.
Per tornare a Funetta, il sospetto è che la vaghezza che, a mio avviso, costituisce la parte più debole del suo romanzo, sia eredità diretta di questa diffidenza verso il fantastico popolare, di ampio consumo: si tratta di uno stile che si sforza di farsi carico di un bagaglio letterario necessariamente “alto”, che accoglie la letteratura di genere solo quando il tempo ha dimostrato che può essere letta senza vergogna anche fuori dalla cerchia degli appassionati (si vedano i summenzionati Lovecraft e Ligotti, o si veda l’atteggiamento paraculo e l’entusiasmo di chi ha appena scoperto l’acqua calda con cui, qualche anno fa, Nicola Lagioia ci suggeriva di leggere IT). In una tipica classifica natalizia, Orazio Labbate consigliava la sua top-six horror del 2017 – di cui un libro era dell’immancabile Ligotti, e gli altri invece Ceronetti, Canetti, il fantasy di Vanni Santoni L’impero del sogno, l’epistolario di Poe, e Il soprannaturale letterario di Francesco Orlando, che, per tutto il rispetto che posso nutrire verso Orlando e tutto il bene che voglio per chi ha curato questo volume, difficilmente può considerarsi horror. Nel 2017, ricordiamolo, è uscito l’ultimo King, Sleeping Beauties, e la Indipendent Legions ha pubblicato la riedizione dei Vangeli di sangue di Clive Barker e la prima edizione italiana del monumentale La casa a Nazareth Hill di Ramsey Campbell, probabilmente una delle migliori storie di case infestate mai scritte.
Sono sospetti confermati anche dai recensori di Funetta. Nicola H. Cosentino scrive che Il grido sono «165 pagine di espressionismo alto, [che] non rinuncia a riferimenti che rimandano al, diciamo, pulp, al B-qualcosa…»: in altre parole, Funetta è un uomo di lettere come noi, ma si degna comunque di fare qualche safari nel popolare – che coraggio! Di Dalle rovine, Alcide Pierantozzi scriveva che «è uno strano romanzo, scritto da un ragazzo pugliese di trent’anni che ha passato gran parte della vita a guardare i film di Tod Browning e a leggere Juan Rodolfo Wilcock»: e, per quanto io ami Wilcock, per quanto Wilcock mi diverta, forse non è il più significativo dei numi tutelari sotto cui porsi per cominciare a esplorare le province del fantastico…
Occorre tirare le somme. Come ho scritto sopra, Luciano Funetta ha tutto il mio rispetto, e, benché non interamente riusciti, i suoi libri rappresentano non soltanto operazioni coraggiose di recupero di un materiale narrativo storicamente bistrattato, ma anche lucidi esercizi di atmosfera in una prosa sapientemente evocativa. Allo stesso tempo, però, non posso non pensare che questa rinnovata fortuna del weird in Italia, inteso in senso ampio, di cui Funetta è senz’altro l’esponente più interessante, corra inevitabilmente il rischio, per i modelli che si sceglie e l’atteggiamento con cui guarda alle manifestazioni più genuine del fantastico letterario, di restare un’operazione di nicchia e decisamente libresca. Volendo proprio dare un consiglio non richiesto, meno Wilcock, nonostante il mio amore per Wilcock: più Clive Barker.
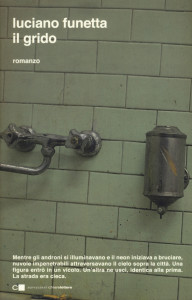 Luciano Funetta, Il grido, Chiarelettere, Roma 2018, 176 pp. 16€
Luciano Funetta, Il grido, Chiarelettere, Roma 2018, 176 pp. 16€