William Minor nella sua camera del manicomio criminale di Broadmoor, nella cittadina di inglese di Crowthorne; Aby Warburg in quella della clinica di Bellevue, a Kreuzlingen, in Svizzera. William Minor che scruta con attenzione maniacale (aggettivo infelice) innumerevoli libri per estrarne citazioni utili a un nascente dizionario; Aby Warburg che prepara una conferenza basata su una sua spedizione fatta vent’anni prima in un gruppo d’indiani d’America. William Minor che – pare – trae giovamento e una relativa serenità da quel lavoro certosino; Aby Warburg che sa che dall’andamento di quella conferenza e della sua preparazione dipenderà la durata del suo soggiorno in quella clinica; William Minor che, da quella camera (o meglio chiamarla cella?), contribuirà in maniera determinante alla grande impresa dell’Oxford English Dictionary; Aby Warburg che, in quel “sanatorio” concepisce uno studio fra i più vertiginosi della sua rivoluzionaria produzione: Il rituale del serpente. Una relazione di viaggio.
Minor e Warburg: cos’hanno in comune questi due personaggi vissuti fra Ottocento e Novecento? Quanto è utile, o sensato, separare la loro storia clinica dal loro contributo intellettuale? Qual è l’apporto delle loro vicende all’idea di tragicità, e al rapporto fra tragicità di un testo e tragicità di una vita? Quello che segue è un accostamento operato sulla base di una caratteristica comune delle due figure in questione (e i casi possibili sono tanti): da una parte, trovarsi in un manicomio e, dall’altra, offrire da lì un importante contributo al sapere. Da capire è come le due cose stanno in rapporto fra loro.
La vicenda di William Minor è raccontata da un libro ora riportato in libreria da Adelphi: Il professore e il pazzo, di Simon Winchester, nella traduzione di Maria Cristina Leardini. Il libro era stato già pubblicato in Italia da Mondadori nel 1999 con il titolo L’assassino più colto del mondo. Anche il titolo inglese è cambiato: prima era The Surgeon of Crowthorne: A Tale of Murder, Madness and the Love of Words, poi è diventato The Professor and the Madman: A Tale of Murder, Insanity, and the Making of the Oxford English Dictionary. Tale cambiamento è avvenuto in corrispondenza con l’annuncio dell’imminente (pare) trasformazione del libro in film: regia di Farhad Safinia, Mel Gibson nel ruolo di James Murray («il professore») e Sean Penn in quello di James Minor («il pazzo»).
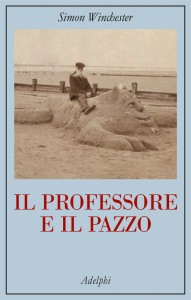 Il libro di Simon Winchester intreccia più biografie, grosso modo nella seconda metà dell’Ottocento: quella di William Minor, di James Murray, di George Merrett (la povera vittima casuale di William Minor) e quella dell’Oxford English Dictionary. È infatti attorno alla nascita e alla lavorazione di quest’ultimo che si dipanano le vicende di questa storia.
Il libro di Simon Winchester intreccia più biografie, grosso modo nella seconda metà dell’Ottocento: quella di William Minor, di James Murray, di George Merrett (la povera vittima casuale di William Minor) e quella dell’Oxford English Dictionary. È infatti attorno alla nascita e alla lavorazione di quest’ultimo che si dipanano le vicende di questa storia.
A James Murray venne affidata la guida di questo ambizioso progetto, nato in una fase storica in cui, per esempio, un decano di Westminster, che era convinto, come gran parte dei membri della Philological Society di cui faceva parte, che l’espansione dell’egemonia della lingua inglese nel mondo fosse frutto della volontà divina, in un’orazione disse: «quanto più inglese si parlava nel mondo, tanto più timorati di Dio sarebbero stati i popoli». Pare che, a proposito di timore di Dio, le ultime parole pronunciate sul letto di morte da un altro membro di quella società e collaboratore del dizionario in questione, il trentunenne Herbert Coleridge, furono: «Domani devo cominciare con il sanscrito». Una bella idea d’aldilà, tutto sommato.
Per intenderci, Murray era uno che da giovane tentò d’insegnare alle mucche del posto dove viveva di rispondere ai suoi richiami in latino. Più tardi avrebbe svolto uno studio lessicale comparativo sulla conta delle pecore degli indiani Wowenoc del Maine e quella dei contadini delle brughiere dello Yorkshire. Sempre di dotte questioni bovine e ovine si trattava (e questo ci fa rivalutare l’insulto classico di Vittorio Sgarbi: «Capra! Capra! Capra!»).
Ricevuto l’incarico di guidare l’impresa dell’imponente Oxford English Dictionary, James Murray fece stampare duemila copie di un annuncio di richiesta di aiuto a lettori volontari, che avrebbero potuto compilare schede lessicali traendo frasi dai libri che avrebbero letto, così da poter includere quegli esempi nei singoli lemmi. Un’operazione che oggi avremmo forse chiamato crowdsourced: con un inglesismo, appunto. Da quei volontari arrivarono più di sei milioni di schede.
In ogni caso, quel volantino venne distribuito nelle librerie d’Inghilterra e uno finì nel paesino nebbioso di Crowthorne, nella contea del Berkshire, e più in particolare nel manicomio criminale di Broadmoor, e, ancora più in particolare, fra le mani di uno dei suoi ospiti: l’americano William Minor, medico, reduce di guerra e uccisore del londinese George Merrett, che ebbe la sfortuna di essere scambiato per qualcun altro (chi, non si sa, e probabilmente non lo sapeva neanche l’omicida).
William Minor si rivelò il collaboratore volontario più assiduo dell’Oxford English Dictionary; sviluppò un metodo di catalogazione delle frasi e dei lemmi tutto suo. La sua meticolosità e la sua efficienza non cessavano di sorprendere i redattori di stanza a Oxford, che Minor non lo incontrarono mai, a parte James Murray, dopo molti anni.
Simon Winchester sceglie di costruire la suspense della sua narrazione assecondando per tre quarti del libro una storia falsa – o fake news, tanto per aggiungere un altro inglesismo – raccontata da un giornalista (una mossa piuttosto ambigua, ma tant’è), e che riguardava il primo incontro, dopo molti anni di collaborazione per corrispondenza, fra James Murray e William Minor.
Per Minor, darsi da fare per quelle schede aveva un effetto “tranquillante”, forse perfino terapeutico. Con quel lavoro a cui pensare, la sua residenza nel manicomio scorreva relativamente più serena. Un particolare non di poco conto: molti dei libri che Minor scandagliava glieli portava in manicomio la vedova della sua vittima, in occasioni delle sue frequenti visite. A ognuno le sue forme di elaborazione del lutto.
Nel caso di Aby Warburg, invece, nessuno ha ucciso nessuno. Il suo soggiorno in clinica (e il pudore e la “rispettabilità” dei suoi ospiti suggerisce di non aggiungere a “clinica” l’aggettivo “psichiatrica”) si è svolto pochi decenni dopo quello di Minor, e fu di tutt’altra natura.
Warburg fu un grande storico dell’arte, uno di quelli capaci di mostrarci come, attraverso la lettura delle immagini, sia possibile leggere tanto intere collettività sociali quanto intere individualità psicologiche, o quantomeno molti dei loro aspetti. Della storia dell’arte, Warburg ampliò i confini, fino a includervi l’antropologia e altre scienze sociali: non a caso, oggi sono certi antropologi ad assumerlo, forse più di tutti, come riferimento fondamentale dei loro studi (penso per esempio a Carlo Severi, autore de Il percorso e la voce. Un’antropologia della memoria).
Figlio di una dinastia di banchieri – rinuncerà alla sua parte di eredità in cambio di un accesso illimitato alle risorse familiari per l’acquisto di libri e altre spese di ricerca – Warburg creò per esempio una biblioteca, ancora esistente nell’istituto a lui intitolato a Londra (anche se ora minacciato di chiusura), in cui i volumi sono catalogati e collocati secondo criteri di accostamento pensati dallo stesso Aby e che riflettevano il suo sguardo sugli oggetti dei suoi studi.
(A proposito: sarebbe bene che un qualche editore italiano riporti in libreria l’Atlas Mnemosyne, grazie).
Aby Warburg era soggetto a crisi nervose che rendevano necessari – secondo i medici del tempo – ripetuti soggiorni in clinica, quella del sanatorio Bellevue di Kreuzlingen, in Svizzera. Durante uno di quei soggiorni, nel 1923, decise di dover convincere il direttore della clinica di essere guarito e pronto a uscire. Per dargli una prova di quella situazione di salute, Warburg disse al direttore – ex assistente di Jung, assiduo corrispondente di Freud – che avrebbe preparato e tenuto una conferenza proprio lì nella clinica, di fronte a medici e pazienti. L’accordo fu che, se fosse riuscito in questa impresa, non molto tempo dopo sarebbe potuto uscire dalla clinica, dove risiedeva da circa due anni.
È così che nacque la conferenza sul rituale del serpente, tenuta a Kreuzlingen il 21 aprile 1923 e poi pubblicata nel 1939 nella rivista del Warburg Institute, e poi in Italia da Adelphi con il titolo Il rituale del serpente. Una relazione di viaggio (traduzione di Gianni Carchia e Flavio Cuniberto).
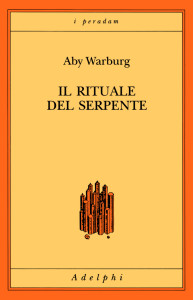 Possiamo anche concederci di figurarci la scena di Aby Warburg a tenere la sua dotta e appassionata (e per certi versi complicata) conferenza, che includeva anche la proiezione di numerose diapositive, di fronte a un pubblico che non sarà difficile immaginare – con rispetto parlando – come il cast di Qualcuno volò sul nido del cuculo. A proposito di quel pubblico, nella nota di accompagnamento al testo, gli editori rivista del Warburg Institute nel 1939 avrebbero scritto che la conferenza era stata pronunciata «davanti a un pubblico non specialistico»…
Possiamo anche concederci di figurarci la scena di Aby Warburg a tenere la sua dotta e appassionata (e per certi versi complicata) conferenza, che includeva anche la proiezione di numerose diapositive, di fronte a un pubblico che non sarà difficile immaginare – con rispetto parlando – come il cast di Qualcuno volò sul nido del cuculo. A proposito di quel pubblico, nella nota di accompagnamento al testo, gli editori rivista del Warburg Institute nel 1939 avrebbero scritto che la conferenza era stata pronunciata «davanti a un pubblico non specialistico»…
A inizio Novecento, Warburg fece una breve spedizione fra gli indiani Pueblo, che vivevano nella zona del New Mexico, negli Stati Uniti. Lì, si trovò ad assistere a un rituale: il rituale del serpente. Nel descriverlo e analizzarlo, Warburg innesca una serie di riflessioni che, a catena, lo spingeranno a interrogarsi sui caratteri iniziali del paganesimo e del pensiero magico, con un passaggio dal dettaglio etnografico alla genealogia storica e di significato tipico del procedimento analitico dell’antropologia. Ecco insomma che la descrizione di un rituale di un piccolo gruppo sociale sperduto (e minacciato) nelle grandi pianure americane e focalizzato sulla figura del serpente finirà – attraverso le «onde mnemiche dal passato» di cui parla Warburg – per essere accostato alla storia del serpente di Mosè nel deserto, al serpente del Laocoonte dei musei Vaticani, a varie altre rappresentazioni medievali e rinascimentali, a foto dalla spedizione fra i Pueblo, e così via, in una serie di accostamenti e collegamenti tanto vertiginosi quanto necessari, se davvero vogliamo tentare di cogliere le basi lontane e profonde del nostro modo di stare al mondo e, aggiungerebbe forse Warburg, di vedere e costruire quel mondo anche attraverso le immagini e le rappresentazioni.
La conferenza andò bene e, una volta uscito, Warburg regalò al suo medico e direttore della clinica Bellevue di Kreuzlingen una stampa di Rembrandt, Cristo guarisce gli infermi. Non dovette essere una scelta casuale.
Ad accomunare Warburg e Minor è l’elemento di tragicità alla base delle loro storie, e qui il termine “storie” è da intendere secondo molteplici significati: la loro storia in senso biografico, la loro storia clinica o patologica (e terapeutica?), e infine la Storia con la S maiuscola di cui sono stati vittima e che ha avuto un ruolo decisivo nella loro presenza in quei “manicomi”: Warburg era molto vulnerabile alla pressione che gli sconvolgimenti politici, sociali e bellici del tempo stavano esercitando su di lui, oltre alle sue difficoltà nel rapporto con la sua identità ebrea; di Minor si disse invece che fosse rimasto traumatizzato durante il suo lavoro di medico durante la guerra civile americana, durante la quale visse situazioni da cui non si sarebbe più ripreso, benché sia fuorviante stabilire troppo sbrigativamente un nesso di causalità univoca fra quegli episodi e la sua situazione clinica.
Nella sua preziosa postfazione a Il rituale del serpente, Ulrich Raulff scrive: «Nella nota a margine che accompagna questo programma terapeutico – al tempo stesso individuale e universale – Warburg nega che l’umana sofferenza possa essere sanata con e nella cultura. (…) [Warburg] resta fedele a un paganesimo tragico-pessimistico. La conquista dei simboli e la precarietà di tale vittoria: è questo il dramma terribile di fronte al quale ci pone Warburg, in un testo in cui lo sfondo autobiografico è ancora ben presente. (…) La conferenza di Kreuzlingen non ci offre solo una visione tragica del destino culturale dell’uomo, è essa stessa un testo tragico». Visto in questa prospettiva, l’Oxford English Dictionary appare anch’esso un testo tragico.
Ma la domanda principale che ci lasciano Il professore e il pazzo e, in modo diverso, Il rituale del serpente è probabilmente un’altra, una che va al di là della questione del novero delle possibilità del tragico. Ovvero: ne è valsa la pena? O meglio: se, come le loro vicende suggeriscono, i diversi contributi al sapere offerti da Minor e Warburg sono così legati alla loro esperienza della malattia mentale e al loro vissuto in istituzioni quali i “manicomi” nelle loro diverse forme (peraltro proprio in questi giorni ricorre il quarantesimo anniversario della legge Basaglia), cosa si è perso e cosa si è guadagnato in quelle vicende?
Ci sono saperi che, in maniera diretta o indiretta, la comunità umana ha acquisito anche attraverso la sofferenza psichica – e la sofferenza tout court – di alcuni dei loro membri, se non proprio attraverso le diverse forme e livelli di tragicità delle loro vite. Rimane da capire se un sapere frutto di una vita tragica conserva nelle sue profondità una dimensione di tragicità, come fosse un rumore di fondo legato alle sue condizioni di produzione e mai più dissociabile da quel sapere in sé. Se così fosse, no, non ne sarebbe valsa la pena, perché nessuna stilla di sapere in più vale neanche un minuto di sofferenza umana.
È così? La difficoltà nel capirlo è quella di riuscire a concentrarsi per riflettere, perché si è continuamente distratti da un certo rumore che ci circonda, a volte fastidioso e a volte assordante. Cosa sia a provocarlo non lo si capisce con certezza. Ma un sospetto ce l’ho: che sia un agglomerato sonoro dei tanti rumori di fondo tragici che accompagnano – contribuendo a plasmarlo – quel sapere umano, proprio in quanto umano, troppo umano.
Simon Winchester, Il professore e il pazzo, Adelphi, Milano 2018, 262 pp. 18€
Aby Warburg, Il rituale del serpente. Una relazione di viaggio, Adelphi, Milano 1998, 112 pp. 14€

William Minor