[Una prima versione di questo pezzo, che pubblichiamo in due parti, è uscita sul numero 1-2 della rivista «Il Ponte» (gennaio-febbraio 2018)]
Io ho visto e conosciuto bene un bambino geloso: non parlava ancora e già guardava livido, con occhi torvi, il suo fratello di latte.
(Agostino, Confessioni)
1.
Nella prima edizione della Frantumaglia Elena Ferrante, rispondendo a un questionario dell’«Indice dei libri del mese», racconta un ricordo d’infanzia a Napoli con la madre come protagonista. La piccola Elena convince una delle sorelle minori a chiudersi nello sgabuzzino, luogo dove si addensano i mostri infantili che la terrorizzano, in modo da sbarazzarsi di lei perché è una presenza troppo rumorosa, piccola, invadente. Subito dopo Elena, terrorizzata dalla possibilità che un mostro dentro lo sgabuzzino possa uccidere e dilaniare la sorellina, la tira via appena prima che quella si chiuda la porta alle spalle e la fa piangere, causando l’intervento della madre. Prima che Elena riesca a spiegarle che, in realtà, ha salvato la sorella e non le ha fatto del male (come invece potrebbe sembrare dall’esterno), la madre la punisce con uno schiaffo. Nelle parole dell’autrice adulta, è lì che nasce l’odio per una punizione ingiusta: un odio, nella percezione sempreverde della bambina perduta, che non osa dire il suo nome e ribolle sotto la coltre di una coscienza razionale e giudicante. Ferrante ricorda:
Mi sembrò presto di essere una belva che si finge domestica, in ogni umano rapporto vedevo solo catene di colpe, una somma infinita di ragioni per rispondere al male col male, l’innocenza non la vedevo. Però spesso ragionavo sul riscatto[1].
È nello schiaffo proveniente dalla persona più amata che sta la radice dell’interminabile catena di ingiustizie e amori, intrecciati fra loro, che compone l’esistenza degli individui per Elena Ferrante. Non solo: la punizione conferisce all’autrice una ragione ambivalente, da un lato, per smettere di sentirsi in colpa per il sentimento distruttivo verso la sorella, dall’altro per alimentare questo sentimento che guida in segreto tutte le sue azioni:
Perciò alla lunga finii per apprezzare lo schiaffo di mia madre. Quella punizione a vanvera mi sembrò la realtà di tutte le punizioni. Era servita a pareggiare i conti del male già fatto, a restituirmi motivatamente all’odio per mia sorella e alla legittimità del desiderio di ucciderla. (FR, 109)
Il pareggiamento di conti è però tutt’altro che pacifico. Non riesce a sedare l’inquietudine di Elena, anzi, la getta in uno spaesamento identitario che tornerà ripetutamente nei romanzi («Ero allora l’innocente che si sacrifica per redimere la colpevole? O ero la colpevole che si sacrifica per redimere la vittima?»), insieme all’astio insopprimibile per non essere l’unica destinataria dell’amore per la madre, a cui è riservata la devozione che si tributa alle divinità vendicative. Non sorprende perciò che, nella stessa lettera all’«Indice», torni l’immagine, già evocata in Agostino, della fame per il latte materno, venata di ferocia: «Io e l’altra sorella guardavamo perse come la piccola si attaccava alla carne di mamma, avidamente, e succhiava senza mai smettere. Aspettavamo che si stancasse ma non succedeva, lei restava attaccata fino a che si sfiniva» (FR, 110).
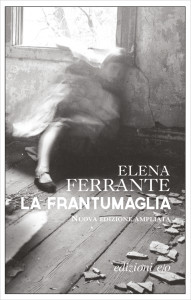 Ci sono scrittori che imperniano ossessivamente tutta la loro scrittura intorno a due o tre concetti-chiave per nulla astratti, bensì radicati a fondo dentro le ragioni della biografia, che li usano per puntellare i loro universi di finzione rendendoli asfittici, magari fastidiosi, ma veri e riconoscibili. Elena Ferrante fa parte di questa genealogia di scrittori, con il suo mondo narrativo che, sempre di più col passare delle opere (fino alla tetralogia dell’Amica geniale) è composto di donne oppresse, schiacciate, abbandonate, vampirizzate da altre donne (le madri, le figlie nella Figlia oscura, l’amica-totem Lila) e ancor più dal dominio maschile. Le sue protagoniste cercano di sopravvivere alimentandosi di un odio inconfessato che determina le loro azioni, permette loro di andare avanti e non essere sopraffatte da una Storia che le vede invariabilmente perdenti. L’odio dà linfa ai loro pensieri e fornisce loro le parole per interpretare il tempo in cui vivono: caratteristica, quest’ultima, palese nel trattamento della “quinta teatrale” dell’Italia postbellica su cui si muovono i personaggi dell’Amica geniale. L’odio non ammesso e onnipresente, che chiunque abbia letto una delle sue opere è abituato a riconoscere, può essere definito con Max Scheler risentimento, e se, com’è naturale, non esaurisce in una formula quella che è forse la più grande scrittrice italiana vivente, ne chiarisce alcuni tratti profondi che, nonostante le studiate ritrosie di Elena Ferrante, riemergono con prepotenza non solo nei romanzi ma anche e soprattutto in un testo di poetica come La frantumaglia, aiutandoci perciò anche a decifrare meglio il personaggio dell’autrice. Ha scritto Scheler:
Ci sono scrittori che imperniano ossessivamente tutta la loro scrittura intorno a due o tre concetti-chiave per nulla astratti, bensì radicati a fondo dentro le ragioni della biografia, che li usano per puntellare i loro universi di finzione rendendoli asfittici, magari fastidiosi, ma veri e riconoscibili. Elena Ferrante fa parte di questa genealogia di scrittori, con il suo mondo narrativo che, sempre di più col passare delle opere (fino alla tetralogia dell’Amica geniale) è composto di donne oppresse, schiacciate, abbandonate, vampirizzate da altre donne (le madri, le figlie nella Figlia oscura, l’amica-totem Lila) e ancor più dal dominio maschile. Le sue protagoniste cercano di sopravvivere alimentandosi di un odio inconfessato che determina le loro azioni, permette loro di andare avanti e non essere sopraffatte da una Storia che le vede invariabilmente perdenti. L’odio dà linfa ai loro pensieri e fornisce loro le parole per interpretare il tempo in cui vivono: caratteristica, quest’ultima, palese nel trattamento della “quinta teatrale” dell’Italia postbellica su cui si muovono i personaggi dell’Amica geniale. L’odio non ammesso e onnipresente, che chiunque abbia letto una delle sue opere è abituato a riconoscere, può essere definito con Max Scheler risentimento, e se, com’è naturale, non esaurisce in una formula quella che è forse la più grande scrittrice italiana vivente, ne chiarisce alcuni tratti profondi che, nonostante le studiate ritrosie di Elena Ferrante, riemergono con prepotenza non solo nei romanzi ma anche e soprattutto in un testo di poetica come La frantumaglia, aiutandoci perciò anche a decifrare meglio il personaggio dell’autrice. Ha scritto Scheler:
Il risentimento è un autoavvelenamento dell’anima con cause e conseguenze ben determinate. È un atteggiamento psichico permanente, che nasce da una inibizione sistematica dello sfogo di certi moti dell’animo ed affetti, che in sé stessi sono normali e che appartengono alla struttura di fondo della natura umana: tale repressione ha come effetto certe permanenti disposizioni a determinate specie di illusori scambi di valori e ai pregiudizi relativi. I moti e gli affetti che in primo luogo si offrono all’osservazione sono: senso e impulso di vendetta, odio, cattiveria, invidia, gelosia, malizia[2].
Il risentimento, in una prospettiva simile, è frutto di un’inibizione, causata nel caso dei personaggi di Ferrante da varie ragioni, anzitutto storiche e di genere. La protagonista femminile media dei suoi romanzi, costretta di solito a porsi al servizio di figli, familiari, mariti e amanti, subordina la propria individualità a loro, subisce una sequela ininterrotta di discriminazioni e atti volti a sminuirla: ma in questa condizione, imposta, di minorità, essa trova ciò che le dà forza e concede legittimità alle sue parole. Il discorso femminile diviene lo strumento per analizzare le ipocrisie di una Storia architettata con dolo dagli uomini, a danno di tutti, senza possibilità di redenzione. Come si vede dall’Amica geniale, in cui ai mutamenti politici e sociali fanno da contraltare le costanti immutabili di storie private[3] composte di sopraffazioni domestiche, torti dati ma soprattutto subìti e rancori che non invecchiano mai, a dispetto delle conquiste apparenti dell’ultimo sessantennio di storia italiana la donna ha raggiunto una parità soltanto formale: in realtà, essa continua a essere ostacolata e combattuta da uomini che, nei libri di Ferrante, sono invariabilmente eterni bambini avidi e feroci, capaci di sopravvivere meglio delle donne proprio in virtù della loro totale mancanza di empatia.
La misandria di Ferrante non è sempre, necessariamente, un difetto: costituisce uno dei suoi grandi punti di forza, arrivando a toccare tutti gli strati sociali e i tipi di rapporti interpersonali per svelarne il sottofondo di sopraffazione. Gli amanti sono, quando va bene, uomini fragili e indecisi (come nei Giorni dell’abbandono). Nei casi più negativi, sono dei veri e propri mostri sotto falso nome, che incarnano, nella loro identità di genere, l’idea della catastrofe civile italiana, buoni solo a soddisfare ossessioni passeggere, ingravidare e scappare via dopo aver addossato alla controparte ogni dolore e responsabilità: tutti aspetti condensati dall’eroina abbandonata per antonomasia, Didone, che torna spesso nella Frantumaglia, ma soprattutto, simmetricamente dal personaggio di Nino Sarratore[4] che, nel giro dei quattro volumi dell’Amica geniale, è prima bambino affascinante, timido e scaltro, poi militante comunista e seduttore incallito, poi parlamentare socialista e traditore seriale della protagonista Elena, infine berlusconiano cinico e devastato, ridotto a fare battute di cattivo gusto al funerale della propria madre. I padri sono assenti, o violenti (come nell’Amore molesto). Persino i figli sono propaggini fastidiose, quando pure ci sono: la maternità, difatti, è nell’opera di Ferrante una questione strettamente femminile e riguarda per lo più madri e figlie. I maschi, da parte loro, non possono che accodarsi alla stupidità e alla violenza dei loro antenati. Lo illustra perfettamente nell’Amica geniale Rino, primo figlio di Lila: pur cresciuto con cura e attenzione dalla madre, diventa ottuso, eroinomane, infine parassita alle spalle della madre e incapace di esprimere affetto, solo di attrarlo (ne è prova la duplice seduzione delle figlie di Elena in Storia della bambina perduta). Nella sua monocromia, Rino è l’unico rappresentante, eloquente, del figlio maschio nell’intera opera della scrittrice.
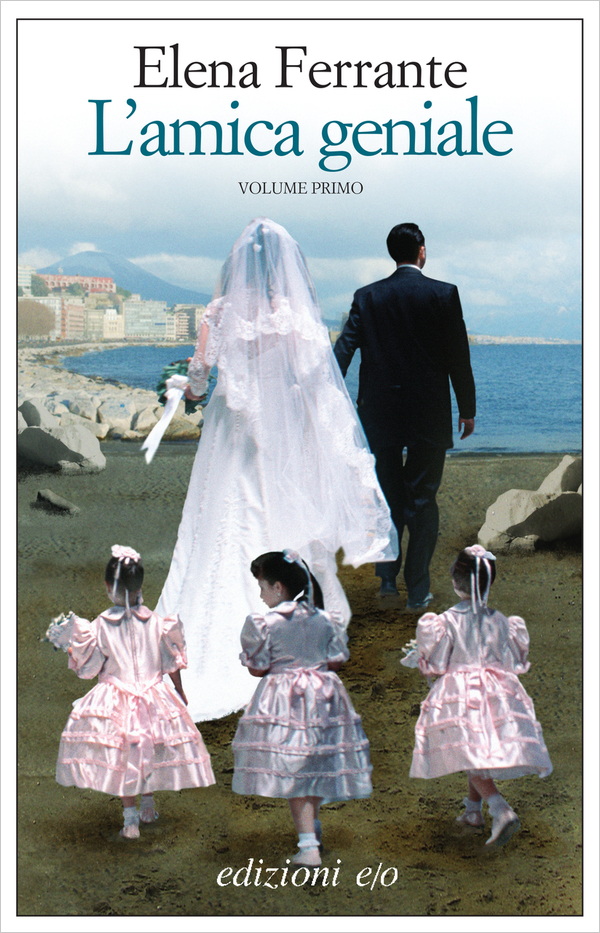 Oltre al risentimento di genere, cioè principalmente quello delle donne verso gli uomini, alimentato dalla coscienza sotterranea che l’uguaglianza femminile è ancora, dopo anni di lotte, un risultato più sbandierato che sostanziale, c’è un altro tipo di risentimento, in mostra nel passo già citato della Frantumaglia: quello della figlia verso la madre o, più in esteso, della donna più debole e incerta verso una donna più forte, autorevole, capace. La seconda è per definizione un fantasma sfuggente, di cui è impossibile afferrare l’identità e comprendere le ragioni: se fosse possibile, infatti, essa perderebbe la sua aura affascinante e sarebbe ridotta a essere una persona come tutte. Importa, invece, che questa donna-totem stia sempre a distanza, in modo da essere adorata e tenuta a riferimento irraggiungibile, motore immobile di tutte le azioni della figlia. Già evidente nell’Amore molesto, strutturata come un’indagine caotica, con venature di ghost story, di una figlia quarantenne sulle ragioni del suicidio della madre odiata e amata, la dinamica è vista nel suo rovescio nella Figlia oscura (la madre che sparisce è la protagonista e io-narrante Leda), e poi perfezionata nell’Amica geniale. Alla base della tetralogia, infatti, sta l’amicizia fra Elena e Lila, che inizia nell’infanzia a Napoli, negli anni ’40, e prosegue per circa sessant’anni alimentandosi del risentimento inesauribile di Elena, rosa dal senso di inadeguatezza e dal desiderio frustrato di riuscire appieno in qualche campo, per Lila, la vera e propria «amica geniale» ai cui pensieri, sempre coerenti ed estremamente lucidi, seguono immancabilmente azioni coerenti e ammirate da tutto il rione da cui entrambe provengono. Elena sintetizza: «[…] ho fatto molte cose nella mia vita ma mai convinta, mi sono sempre sentita un po’ scollata dalle mie stesse azioni. Lila invece aveva, da piccola […] la caratteristica della determinazione assoluta»[5]. Più in generale, Elena e Lila sono costruite da Ferrante secondo un principio di specularità di simmetria allucinante. Elena riesce a riscattarsi dal rione e dalla famiglia umile, ma lo studio che lo porta prima alla Normale di Pisa e poi a diventare una famosa scrittrice, lontano da Napoli, non è in fondo che un’impostura intellettuale, una patina con cui coprire l’inadeguatezza: e di ciò Elena per prima si rende conto nei lunghi e volutamente prolissi monologhi che intervallano la narrazione degli episodi della sua vita attraverso i decenni. Ne diventa consapevole proprio confrontandosi con Lila, come se l’amica, con la sua intelligenza demistificatrice e non ancora corrotta dagli inganni della cultura borghese, funzionasse da pietra di paragone per svelare la falsità delle sovrastrutture (la politica, la letteratura, il matrimonio, la trasgressione erotica) a cui Elena crede, ogni volta sbagliando, di affidare la propria salvezza. Tiziana De Rogatis ha giustamente rilevato:
Oltre al risentimento di genere, cioè principalmente quello delle donne verso gli uomini, alimentato dalla coscienza sotterranea che l’uguaglianza femminile è ancora, dopo anni di lotte, un risultato più sbandierato che sostanziale, c’è un altro tipo di risentimento, in mostra nel passo già citato della Frantumaglia: quello della figlia verso la madre o, più in esteso, della donna più debole e incerta verso una donna più forte, autorevole, capace. La seconda è per definizione un fantasma sfuggente, di cui è impossibile afferrare l’identità e comprendere le ragioni: se fosse possibile, infatti, essa perderebbe la sua aura affascinante e sarebbe ridotta a essere una persona come tutte. Importa, invece, che questa donna-totem stia sempre a distanza, in modo da essere adorata e tenuta a riferimento irraggiungibile, motore immobile di tutte le azioni della figlia. Già evidente nell’Amore molesto, strutturata come un’indagine caotica, con venature di ghost story, di una figlia quarantenne sulle ragioni del suicidio della madre odiata e amata, la dinamica è vista nel suo rovescio nella Figlia oscura (la madre che sparisce è la protagonista e io-narrante Leda), e poi perfezionata nell’Amica geniale. Alla base della tetralogia, infatti, sta l’amicizia fra Elena e Lila, che inizia nell’infanzia a Napoli, negli anni ’40, e prosegue per circa sessant’anni alimentandosi del risentimento inesauribile di Elena, rosa dal senso di inadeguatezza e dal desiderio frustrato di riuscire appieno in qualche campo, per Lila, la vera e propria «amica geniale» ai cui pensieri, sempre coerenti ed estremamente lucidi, seguono immancabilmente azioni coerenti e ammirate da tutto il rione da cui entrambe provengono. Elena sintetizza: «[…] ho fatto molte cose nella mia vita ma mai convinta, mi sono sempre sentita un po’ scollata dalle mie stesse azioni. Lila invece aveva, da piccola […] la caratteristica della determinazione assoluta»[5]. Più in generale, Elena e Lila sono costruite da Ferrante secondo un principio di specularità di simmetria allucinante. Elena riesce a riscattarsi dal rione e dalla famiglia umile, ma lo studio che lo porta prima alla Normale di Pisa e poi a diventare una famosa scrittrice, lontano da Napoli, non è in fondo che un’impostura intellettuale, una patina con cui coprire l’inadeguatezza: e di ciò Elena per prima si rende conto nei lunghi e volutamente prolissi monologhi che intervallano la narrazione degli episodi della sua vita attraverso i decenni. Ne diventa consapevole proprio confrontandosi con Lila, come se l’amica, con la sua intelligenza demistificatrice e non ancora corrotta dagli inganni della cultura borghese, funzionasse da pietra di paragone per svelare la falsità delle sovrastrutture (la politica, la letteratura, il matrimonio, la trasgressione erotica) a cui Elena crede, ogni volta sbagliando, di affidare la propria salvezza. Tiziana De Rogatis ha giustamente rilevato:
A Ferrante non interessa l’incontro tra due soggettività che si rappresentano come disincarnate e sovrane, e racconta invece l’amalgama terribile di invidia e riconoscimento elettivo da cui l’amicizia tra due donne, due dominate in cerca della loro emancipazione, inevitabilmente è costituita[6].
Lila tuttavia, per quanto rimanga ostinatamente per tutta la vita nella classe dei dominati, dato che non si emancipa grazie allo studio e rimane per tutta la vita confinata nel rione, è in realtà la vera dominante fra le due, l’origine non troppo nascosta delle scelte di Elena, che constata: «Il mio diventare era diventare dentro la sua scia» (SFR, 316, corsivo nell’originale). Permeata da un fascino non umano che affiora a tratti facendone una specie di Erinni[7] vendicativa e inafferrabile, Lila è la divinità d’elezione di Elena, che la sceglie per sostituirla alla madre[8], una popolana zoppa percepita come insufficiente per alimentare il suo terrore di devota:
Qualcosa mi convinse, allora, che se fossi andata sempre dietro a lei, alla sua andatura, il passo di mia madre, che mi era entrato nel cervello e non se ne usciva più, avrebbe smesso di minacciarmi. Decisi che dovevo regolarmi su quella bambina, non perderla mai di vista, anche se si fosse infastidita e mi avesse scacciata. (AG, 42)
Il sentimento di amicizia è inseparabile, o più probabilmente ingenerato, dal risentimento per la genialità senza sforzo che Lila rinfaccia al mondo:
È probabile che questa sia stata la mia maniera di reagire all’invidia, all’odio, e soffocarli. O, forse, travestii a quel modo il senso di subalternità, la fascinazione che subivo. Certo mi addestrai ad accettare di buon grado la superiorità di Lila in tutto, e anche le sue angherie. (AG, 42)
Ma Lila è fatta per non essere raggiunta da nessuno. La sua superiorità è data da un insieme di sottrazioni drammatiche: non istruita, non soggetta al dominio maschile (non si concede a nessuno dei suoi spasimanti, il che aumenta a dismisura il suo potere sugli uomini), non scrittrice (la sua storia infantile La fata blu, di cui non si conservano tracce, è naturalmente superiore a qualsiasi cosa Elena potrebbe mai scrivere), non madre (dato che sua figlia sparisce misteriosamente nel nulla in Storia della bambina perduta, strozzando la sua maternità ma anche, in modo ambivalente, chiudendola nella perfezione di un vuoto). Ogni azione di Elena finisce così per essere un’aggiunta innecessaria, un agitarsi a vuoto che la porta, in vecchiaia, a essere una scrittrice sola, con una vita devastata, tre figlie distanti che non capisce e un passato di fallimenti a cui non vuole ripensare. Mancando continuamente il bersaglio che la porterebbe a superare Lila, o quanto meno a raggiungerla, il risentimento di Elena aumenta ogni volta che Lila si sottrae al suo sguardo, al suo giudizio: «Dal sentimento caotico che avevo dentro stava risbucando il desiderio che Lila fosse malata e morisse. Non per odio, le volevo sempre più bene, non sarei mai stata capace di odiarla. Ma non sopportavo il vuoto del suo sottrarsi» (SFR, 309). Si tratta di un vincolo impossibile da spezzare, rinsaldatosi con l’ultima azione di Lila che, in un movimento circolare, dà l’avvio alla storia di Elena. Lila, ormai ultrasessantenne, sparisce, portandosi dietro con un fantasmatico coup de théâtre vagamente fantastico ogni documento che la riguardi[9]. Elena, frustrata dall’assenza definitiva che le impedisce una volta per tutte di mettersi a pari con l’amica, decide di scriverne la storia per evocarne, con un gesto sciamanico, la figura. È dunque l’atto stesso della scrittura il simbolo perfetto del risentimento della protagonista, che rievoca, con inadeguatezza inevitabile, la figura elusiva dell’amica: come ogni gesto risentito che si rispetti, va a vuoto. Anche dopo che Elena ha finito, in Storia della bambina perduta, di raccontare la loro amicizia, Lila non ritorna, lasciando la narratrice sola con la sua storia lunga e inconsistente. L’ultima parola se la prende Elena ma è Lila, col suo silenzio, a vincere per l’ennesima volta. La tetralogia dell’Amica geniale può essere letta anche come esplicita messa in figura, sfaccettata e a più livelli, di un risentimento inestinguibile.
[1] Elena Ferrante, La frantumaglia. Nuova edizione ampliata, Roma, e/o, 2016. D’ora in avanti, per non appesantire questo intervento di note, i rimandi sono a testo, seguiti dalla sigla FR e dal numero di pagina.
[2] Max Scheler, Il risentimento nella edificazione delle morali, a cura di Angelo Pupi, Milano, Vita e Pensiero, 1975, p. 31.
[3] «I personaggi crescono, si evolvono, si trasformano; ma in un certo senso la loro è la storia di una coazione a ripetere, in cui, sotto il mutare delle superfici, torna sempre la stessa sostanza», Raffaele Donnarumma, Il melodramma, l’anti-melodramma, la Storia: sull’Amica geniale di Elena Ferrante, in «Allegoria», XXVIII, 73, gennaio/giugno 2016, p. 141.
[4] Lo sintetizza la giovane Silvia, messa incinta proprio da Nino, in una confessione a Elena: «Un maschio, a parte i momenti pazzi in cui lo ami e ti entra dentro, resta sempre fuori. Perciò, dopo, quando non lo ami più, ti dà fastidio anche solo pensare che una volta l’hai voluto. Io sono piaciuta a lui, lui è piaciuto a me, fine. A me succede molte volte al giorno che qualcuno mi piaccia. A te no? Dura un poco, poi passa. Solo il bambino resta, è una parte di te; il padre invece era un estraneo e torna un estraneo», Elena Ferrante, Storia di chi fugge e di chi resta, Roma, e/o, 2013, p. 73 (d’ora in avanti SFR).
[5] Elena Ferrante, L’amica geniale, Roma, e/o, 2011, p. 30 (d’ora in avanti AG).
[6] Tiziana De Rogatis, Metamorfosi del tempo. Il ciclo dell’Amica geniale, in «Allegoria», XXVIII, 73, gennaio/giugno 2016, p. 123
[7] «[…] c’era uno sguardo che pareva non solo poco infantile, ma forse non umano», AG, 44. Oppure, fra i tanti esempi:
«si era illuminata come una santa guerriera», AG, 48.
[8] Su questo, nota Gambaro: «In questa prospettiva, la figura di Lila non rappresenta solo la sorte che sarebbe toccata a Elena nell’ordine consueto degli eventi, bensì la sua stessa matrice. Nella teleologia implacabile di Ferrante, il fondo buio da cui la narratrice attinge è il materno, con la sua folla di fantasmi ferali», Elisa Gambaro, Splendori e miserie di una duplice affabulazione, in «Allegoria», XXVIII, 73, gennaio/giugno 2016, p. 160. Cfr. anche Tiziana De Rogatis, art. cit., pp. 124-5.
[9] «Ho scoperto che non ho niente di suo, non un’immagine, non un biglietto, non un regalino. Mi sono sorpresa io stessa. Possibile che in tutti questi anni non mi abbia lasciato niente di sé, o, peggio, io non abbia voluto conservare alcunché di lei? Possibile», AG, 17. E subito dopo: «Sparite le scarpe. Spariti i pochi libri. Sparite tutte le foto. Spariti i filmini. Sparito il suo computer, anche i vecchi dischetti che si usavano una volta, tutto, ogni cosa della sua esperienza di strega elettronica che aveva cominciato a destreggiarsi coi calcolatori già sul finire degli anni Sessanta, all’epoca delle schede perforate», AG, 18.