È il 1940. Orson Welles è al lavoro su Citizen Kane (Quarto potere) negli studi della RKO; da qualche parte, altrove, Francis Scott Fitzgerald sta scrivendo The Pat Hobby Stories, una raccolta di racconti sul mondo di Hollywood. Proprio quel mondo in cui Welles aveva fatto ingresso circa un anno prima e in modo clamoroso. Non era mai successo, infatti, che la RKO lasciasse così tanta libertà creativa a un solo uomo. Appena ventiquattrenne, tra l’altro. E poi un uomo eccentrico, tanto testardo, imprevedibile e sicuro delle proprie idee da suscitare contemporaneamente ammirazione e paura. Basti pensare alla beffa collettiva con cui due anni prima, nella notte di Halloween, aveva trasformato l’adattamento radiofonico della Guerra dei mondi di Herbert G. Wells, in un’allarmante diretta radiogiornalistica a cui tutti avevano creduto. Un visionario, dice qualcuno: un pazzo a cui, ora, la RKO ha dato il timone!
Così, mentre Welles lavora a Citizen Kane, Fitzgerald decide di dedicargli un racconto in cui le parole, messe in bocca a Pat Hobby, affermano più o meno questo:
«Signor Marcus, non sarei stupito se Orson Welles fosse la più grande minaccia caduta su Hollywood da sempre. Potrebbe essere così estremista da farvi rifare tutte le apparecchiature e ricominciare tutto da capo, come è avvenuto nel ’28 col sonoro.»
Ecco, sì. Estremista è la parola giusta. Un artista che concepisce la propria arte come un’impresa assoluta ed è pronto a realizzarne ogni dettaglio senza mediazioni, ma, soprattutto, a qualunque prezzo. Citizen Kane in effetti smuoverà la penna di geni come Borges («Nulla è più terrificante di un labirinto senza centro. Questo film è esattamente quel labirinto»), ma non l’entusiasmo del pubblico. La nave, insomma, scricchiola e l’equipaggio di Hollywood inizia a temere che il capitano Welles sia attratto dalle tempeste e dai disastri del mare aperto. Il naufragio avverrà, da lì a poco, con The Magnificent Amberson (L’orgoglio degli Amberson). È il 1942 e la RKO licenzia Welles.
Da qui in poi, ogni lavoro di Welles susciterà i brividi (e le chiacchiere) dell’impresa. Chi lo guarda da fuori, non sa se aspettarsi un capolavoro o il più fragoroso dei fallimenti. Chi si imbarca con lui, sa che lo fa a proprio rischio e pericolo e di certo, come all’avvio di ogni impresa che si rispetti, sa che dovrà affrontare i moniti di chi gli si farà appresso per dirgli:
ELIA: Avete già navigato su quella barca?
ISHMAEL: Ho appena firmato il contratto.
[…]
ELIA: Be’, ormai sarà quel che sarà, ma d’altro canto forse non sarà nemmeno. E ci sarà pure qualche marinaio che partirà con lui, che Dio abbia pietà di loro!
Moby Dick – Rehearsed è l’impresa a cui Orson Welles lavora nel 1955 chiudendosi in teatro di Londra. Ed era davvero necessario che la casa editrice Italo Svevo ne pubblicasse la bella traduzione di Marco Rossari, con introduzione di Paolo Mereghetti. Non solo perché il testo (anche per i non appassionati di teatro) è letterariamente bellissimo, ricco e costruito per essere letto come si legge un testo narrativo, senza dover impazzire per seguire didascalie e indicazioni sceniche. Ma anche perché, per tutto quanto detto finora, la storia di Moby Dick è imprescindibile per capire Welles, ponendosi quasi come momento sospeso, di autoriflessione artistica.
Questa volta non può farcela, disse allora qualcuno. Siamo realisti, commentò qualcun altro, stiamo parlando di un testo totale, esorbitante come l’Iliade o la Divina Commedia. Poi c’era chi, più concretamente, si chiedeva come Welles avrebbe reso su un palcoscenico una baleniera che fa naufragio e, ovviamente, lei: la Balena Bianca.
Insomma, le circostanze sono sempre le solite: c’è Welles che vuole fare qualcosa e c’è qualcun altro che gli dice che è una follia. Ma la mossa di Welles, stavolta, è mettere in scena questa stessa circostanza, facendone lo sfondo narrativo di Moby Dick. Quando la sera del 16 giugno 1955 si spalanca il sipario del Duke of York’s Theatre di Londra, il pubblico non vede balene né navi. Non c’è nemmeno una scenografia che riproduca un fondale marino. Sulla scena c’è un uomo, con un normalissimo cappotto, che prova a ripetere il monologo di Ishmael, mentre il direttore di scena gli chiede: «Come ti suona?».
Sono attori che interpretano attori, perché Moby Dick – Rehearsed non è direttamente una storia di balenieri, ma quella di una compagnia teatrale che sta per mettere in scena il Re Lear di Shakespeare, se non fosse che il suo folle impresario (non a caso interpretato da Welles) ha avuto la bella idea di usare le pause tra le prove per abbozzare un adattamento di Moby Dick.
La scena metateatrale scelta da Welles risolve con uno stratagemma (apparentemente) semplice tanti dei problemi che pubblico e critici si aspettavano. È un Welles che gioca in difesa, utilizzando i dialoghi tra i personaggi per provocare l’opinione dei detrattori:
VECCHIO PROFESSIONISTA: È un peccato che non andiamo avanti con il Lear, almeno quella è una vera pièce teatrale, una cosa che si può recitare.
GIOVANE ATTORE: Anche del Lear, i critici dissero che non si poteva recitare.
Un Welles che mette al centro della narrazione se stesso nell’atto di correre un rischio e cerca di farsi coraggio ricordando che tanti, prima di lui, hanno fatto qualcosa che nessuno voleva facessero, qualcosa che, nelle previsioni di molti, sarebbe stato la loro tomba, ma che infine non lo è stato. Successe a Melville. E alla sua creatura, Ishmael. Prima di loro a Shakespeare. Per non parlare di come andò all’antenato più originario e antico di Moby Dick: Giona, il cui peccato, come padre Mapple ricorda al pubblico «è stato la deliberata disobbedienza agli ordini di Dio». Viene voglia di rileggerla, la storia di Giona. In effetti, proprio come Ahab e Ishmael, la sua disobbedienza di profeta che fugge da Dio si concretizza nell’imbarcarsi e nel salpare, gesto che causerà la tempesta e, poi, il famoso pesce che lo inghiotte per tre giorni. Interessante che Giona si salvi parlando: prima dicendo ai marinai (pagani) di essere la causa della tempesta, poi, quando si trova nelle viscere buie del pesce, parlando schiettamente a Dio. Alla fine della parabola, la sua parola disobbediente (così brusca e riluttante da diventare comica!), avrà salvato l’equipaggio e la città di Ninive. Quel che è più buffo è che, inavvertitamente, li avrà pure convertiti. Come a dire che un atto di disobbedienza, se accompagnato dalla parola che lo spiega, finisce per rovesciarsi nella più sorprendente delle salvezze. Ed è così che si salva Welles: facendo della parola la protagonista della sua, ennesima e testarda, disobbedienza artistica.
Come Giona, quello di Moby Dick è un Welles sempre brusco:
IMPRESARIO: Noi siamo servi del pubblico! Nient’altro che questo: servi. Santo cielo, a voi piacerebbe ascoltare lezioncine edificanti dal vostro cuoco?
Ma è anche un Welles fragile che, mentre rischia, dà alla parola il compito di spiegarlo e aiutarlo ad affrontare gli spettatori:
IMPRESARIO: Rimediate coi vostri pensieri alle nostre imperfezioni: pensate, quando parliamo di baleniere, balene e oceani, che li state vedendo, perché saranno i vostri pensieri adesso a dover adornare il nostro palcoscenico…
La vera sorpresa sta nell’improvvisa esplosione di potenza creatrice della parola di Welles, che dopo essere entrata in scena in punta di piedi, come metateatro e autoriflessione, finisce per imporsi come forza motrice di un teatro di narrazione, orchestrando luci e coreografie sempre più evocative, ma sempre dipendenti dalla parola che narra e spiega. Alla fine il mare c’è, ci sono gli spruzzi della balena bianca e ci sono le scialuppe che si gettano al suo inseguimento, c’è la lotta tra le onde e lo schianto del Pequod. La parola ce li fa vedere. Quando il mare si richiude, e con esso il sipario, è chiaro a tutti, detrattori e scettici compresi, che Welles ce l’ha fatta. Si è salvato. Ha sorpreso il pubblico, lo ha portato in mare, lo ha abbandonato alla follia di Ahab e alla furia cieca della natura. Poco importa se, qualche mese dopo, fallirà il progetto di trasformare Moby Dick – Rehearsed in uno sceneggiato per la CBS. Quella sera, al Duke of York’s Theater, la parola è stata così magica che ha consentito a Welles di essere contemporaneamente se stesso, un impresario di teatro, padre Mapple e Ahab. Vale davvero la pena leggerla.
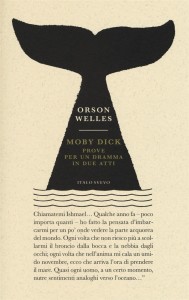 Orson Welles, Moby Dick. Prove per un dramma in due atti, traduzione di Marco Rossari, Italo Svevo 2018, pp. 96, € 13,50.
Orson Welles, Moby Dick. Prove per un dramma in due atti, traduzione di Marco Rossari, Italo Svevo 2018, pp. 96, € 13,50.