C’è un tabù nella poesia contemporanea. La maggior parte dei poeti oggi ritiene che la lirica amorosa non sia nient’altro che il sintomo di un’espressività debole o dilettantesca e perciò tende a non praticarla. La stessa poesia del secondo Novecento ha consegnato il canzoniere amoroso ad una facile eutanasia, abbandonandone la pratica (che affiora solamente in alcuni rari casi tra cui Raboni e Pagliarani). È infatti un’acquisizione solida del contemporaneo poetico l’idea che la poesia, nonostante continui a confrontarsi con l’interpretazione della realtà e dei sentimenti, non debba necessariamente esprimere i propri argomenti attraverso forme effusive, legate all’interiorità o ad una sensibilità personale. Insomma, la poesia evita il cosiddetto poetico, consegnato invece alla vulgata delle didascalie dei social e ai sempiterni Baci Perugina. Di questo poetico sono spesso impregnati gli esordi, che molte volte mancano di esercizio o non filtrano l’esperienza attraverso letture, alla luce di un codice, di una tradizione (beninteso, anche attuale), restando dei banali diari sentimentali.
Se prendiamo tutti gli ingredienti appena elencati e li mescoliamo insieme, non potremo che ottenere un libro a forte rischio, diviso tra inattualità e mediocrità. Eppure, Vera deve morire (Interlinea edizioni, 2018) di Julian Zhara evita in maniera originale di incappare in questi aspetti.
In primo luogo l’esordio di questo poeta veneto – ma di origini albanesi – è tale solo sul cartaceo; Zhara è infatti presente sulla scena poetica italiana da molti anni, nei quali si è affermato come poeta orale e performer, dedito a quella forma di poesia concentrata sulla rappresentazione sonora del testo, attraverso musica e metrica, di cui dà un’ottima panoramica Paolo Giovannetti nel suo ultimo libretto La poesia italiana degli anni Duemila (Carocci, 2017). Vera deve morire, come annuncia l’autore stesso in una nota in calce alla raccolta, segna quindi una svolta profonda nel percorso poetico di Zhara, non solo per la forma, ma anche per i temi. Poeta sempre attento ai fenomeni politici e sociali della propria epoca, Zhara compone un libro che invece racconta una vicenda privata, la fine di un amore, e per fare questo recupera proprio la forma del canzoniere.
Del canzoniere, Zhara riprende una dimensione narrativa sfilacciata, qui ridotta al minimo – quasi inesistente; Vera deve morire dipinge solamente il momento di un abbandono, segmentandone la complessità emotiva in molteplici istantanee che fotografano diversi momenti di questa disperazione. Non c’è tanto una progressione (se non forse nel cupio dissolvi finale) quanto un moto frenetico e inconcludente nella mente del soggetto. Il titolo è a sua volta legato a questo aspetto: oltre a rappresentare la canonica “uccisione del reale” che permette di creare la figura letteraria dell’amata; Vera deve morire anche nella psiche del protagonista, per permettere l’elaborazione dell’accaduto e dare spazio a un futuro a cui il soggetto aspira, ma che è impedito dall’ingombrante presenza mentale della donna.
Sotto il profilo tematico il tentativo, il recupero della forma-canzoniere non si ferma ad una riproposizione stantia del già noto né al recupero di una posa petrarchesca che risulterebbe quantomeno ridicola quando sottoposta all’evoluzione odierna della tradizione. Se – seguendo la lezione di Agamben – il contemporaneo coincide con l’inattuale, che non aderendo perfettamente al proprio presente ne coglie gli angoli bui e li interroga, ecco che il canzoniere di Zhara, fatto transitare attraverso la modernità, diventa una finestra attraverso cui provare a rispondere a specifiche domande. Che fine ha fatto il linguaggio amoroso in poesia? Cosa parliamo quando parliamo d’amore (direbbe Carver)? Ma c’è di più. Cosa vuol dire parlare d’amore in poesia oggi?
Questi sono solo alcuni tra gli interrogativi che emergono da una lettura attenta e che portano a un’unica risposta: parlare d’amore, oggi, diventa parlare di un problema, anche sociale. Fin dall’esergo, che recita «il nostro sogno vile | amarsi senza dolore», è chiara l’intenzione di presentare l’esperienza amorosa come qualcosa di filosoficamente complesso. L’amore viene esposto come un’esperienza al negativo, come decostruzione del sé, evitando anche in questo caso lo scivolamento insipido in una rappresentazione posticcia e nichilista del sentimento:
La nostra condanna sta proprio qua:
nel vederci chiaro in assenza della vista,
delle parole sapere solo lo scarto,
e quanto di noi due, soltanto la distanza.
O ancora
Ché l’amore è una bolla di plastica
tra due corpi si installa, li inchioda […]
A distanza di tempo la bolla,
si trasforma in una palla medica,
ideale per fare lo stretching
ma unità che misura il divario
Tutt’altro che solipsistica, l’esperienza amorosa viene recuperata nella sua dimensione conflittuale, condivisa. L’amore non è neppure il canonico gioco di illusioni che delude e fa soffrire, ma è un ring, una lotta aperta e quotidiana con ciò che l’altro è e che io non sono. Quella amorosa diventa per eccellenza l’esperienza di confronto col diverso, con l’estraneo che mi sta accanto. Una dimensione scevra di ogni orpello, basata sull’effettiva complessità che sta alla base della relazione comunicativa con l’altro da me, dimostrando come un rapporto proceda essenzialmente per tentativi e incomprensioni. L’amore non è altro che una parentesi di dialogo frammentaria (secondo la lezione di Barthes), incespicante, incompleta, che si può dare solo a brani e che trova la propria unità nel sentimento immateriale e afasico il quale però deve necessariamente essere oggetto di interpretazione e decifrazione.
È a questo punto che entriamo nell’altro polo con cui interagisce la poesia di Zhara: la lingua. Concepito così l’amore, diventa centrale il nodo della comunicazione e delle sue possibilità. Vera deve morire si configura quindi anche come un’indagine sulla capacità di “dire/nominare” i moti dell’interiorità, sulle potenzialità del significante quando si applica a un significato muto e ingombrante, temi – questi sì – di una tradizione così antica che potremmo far risalire a Catullo o prima:
Nella lingua dei tuoi antenati
la parola amore se esiste è letteraria,
in mezzo ai campi si fa altro, in amore
è la patata che si squaglia, un raccolto
impazzito, è in amore un uomo che sbanda,
il bestiame che non obbedisce;
bastava allora il voerse ben.
Nella lingua dei miei antenati,
preti, ufficiali e mercanti,
l’amore viene versato altrove
e se avanza, all’amata – bisogna quindi disporne;
e ridiamo di quanta zavorra e detriti
trascina dietro di sé la parola amore.
Per sottolineare ulteriormente questa difficoltà a concretizzare nella lingua l’ineffabilità del discorso amoroso, Zhara presenta anche casi di diglossia nei quali si verifica l’intrusione della lingua “madre” dell’autore – l’albanese – che crea, in momenti di onirismo febbricitante, un suppletivismo linguistico intenzionato ad accrescere la frizione espressiva:
Nel sonno mi dici un po’ dopo, parli tanto
e che dico? Chi ti capisce, parli albanese […]
Parli un tono più giù, tra un mese kam frikë
me kupton, po ti? Continuare così non ha senso
se jeta eshte varrë, resto ancora qualche giorno […]
Ma se il problema dell’amore è innanzitutto un problema di lingua, esso allora è anche un problema poetico. A partire dagli anni ’60, la necessità di un rinnovamento linguistico è passata e passa tutt’ora attraverso il rinnovamento delle forme, con buona pace di sonetti e canzoni, conducendo a soluzioni più disparate. La rinascita della poesia dialettale, il linguaggio “dimesso” della linea lombarda, la decostruzione della Neoavanguardia, il vorticare della sintassi zanzottiana, sono risposte alla stessa ricerca che fanno però dell’abbandono della metrica tradizionale un punto comunemente assodato.
In questo ambito Zhara si muove in maniera personale, seppur non ignorando la lezione di maestri come Frasca. Raccogliendo la sfida della lingua che non si scompone in brani e lacerti, che non esplode, ma che trattiene la sua coesione di senso e suono, l’autore tenta un recupero delle strutture metriche come mezzo di produzione del testo e punto di partenza a cui affidare la strutturazione del contenuto. L’unità minima dell’intera raccolta torna ad essere così il verso – scelta tradizionale – il quale però si discosta dall’endecasillabo per virare su forme meno usate (decasillabo/tridecasillabo) – scelta antitradizionale. Il dialogo che s’instaura con l’oralità del libro – cara all’autore – si concretizza nella rivalutazione del ruolo della forma come chiave per la composizione testuale. Ecco allora che nella raccolta compaiono la sestina, il poemetto, la villanelle ecc alla cui polimorfia corrisponde l’unità del tema. Un buon esempio di questo processo è il testo a pagina 37 in cui la versificazione crea il singhiozzo disperato del soggetto, perfettamente resa qualora letta ad alta voce:
[…]
lavorare sfinisce poi sfibra poi uno diventa il prologo triste
dello stipendio
che il vino a un euro a bicchiere contiene solfiti rimbomba
in testa per mezza giornata
che ho litigato con tutti, divento intrattabile, mi accendo
con poco lo so, mi prometto ogni volta, eppure non riesco,
qua manchi tantissimo manchi davvero le notti combatto
coi muri di giorno col tempo che scivola addosso e chi lo
trattiene […]
Riassumendo, Vera deve morire si relaziona con la tradizione in maniera bifronte e proprio in questo aspetto risiede il suo valore. Da un lato la tematica tradizionale viene completamente riletta alla luce delle sue implicazioni attuali, diventando ben altro rispetto ad un’ipotetica ripetizione di moduli stanchi o ad una sterile cronaca sentimentale; dall’altro le forme contemporanee della composizione poetica vengono escluse dalla raccolta in favore di un recupero della tradizione metrica che diventa elemento sostanziante del testo. Ed è in questo rapporto complesso col passato che Zhara dimostra di avere strumenti per scansare le falle potenziali in agguato dietro a un esordio come questo. Il moto biunivoco che Zhara imposta tra passato e presente, tra riformulazione della tradizione e suo utilizzo consapevole, la rilettura di forme e moduli caduti in disuso e la loro vivificazione, dimostrano una nuova possibilità di indagine per il canzoniere amoroso e il suo portato, abilmente colta all’interno del contemporaneo, riconfermando ancora una volta la poesia come luogo privilegiato per l’esplorazione di tensioni e contraddizioni estreme che regolano il nostro stare al mondo.
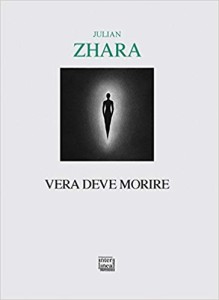 Julian Zhara, Vera deve morire, Interlinea edizioni
Julian Zhara, Vera deve morire, Interlinea edizioni
60 pp, 10 €