William T. Vollmann è quell’autore che per scrivere un libro fa un viaggio al Polo Nord, dà fuoco al suo sacco a pelo e ci rimette le sopracciglia. Il libro in questione è I fucili, pubblicato in America nel 1992 e finalmente arrivato nelle librerie italiane grazie a minimum fax. Fucili fa parte di un ciclo di Sette Sogni attraverso i quali Vollmann cerca di raccontare la storia della colonizzazione americana. Ma storia, in questo caso, non è termine particolarmente adeguato. È lo stesso autore a dichiarare che «il mio obiettivo con i Sette Sogni era di creare una storia simbolica, ovverosia un racconto di origini e metamorfosi che spesso è falso, se rapportato ai fatti reali così come noi li conosciamo, ma la cui inesattezza disvela un più profondo senso di verità». E l’unico modo per descrivere Fucili, forse, è proprio questo.
Si tratta, infatti, di un testo che allude a molti dei generi classici delle narrazioni occidentali, ma per trascenderli tutti. Romanzo storico, racconto di viaggio, fiaba, memoir, inchiesta etnografica e antropologica, mito, sono sottoposti a una torsione tale da rendere Fucili un testo inclassificabile. A prima vista abbiamo di fronte un romanzo che segue parallelamente il racconto della spedizione del capitano Franklin alla ricerca del Passaggio a Nord-Ovest e il resoconto del viaggio del narratore, intento alla ricostruzione della storia del trasferimento forzato degli Inuit. Due vicende tenute insieme dal tentativo di mettere in luce come l’introduzione delle armi da fuoco e dell’imposizione di una economia capitalista abbiano modificato le fondamenta stesse della società Inuit.
Ma i piani si sovrappongono fin da subito e la massa di documenti storici riportati sembra, paradossalmente, quasi esporre l’impossibilità di creare senso a partire da una quantità informe di dati. È lo stesso autore a mettere in dubbio il ruolo dell’archivio: «presa in sé», ci dice in una nota alle lunghe appendici del testo, «la vasta massa di informazioni disponibili è inutile come un ponte incompiuto che non conduce dall’altra parte del fiume». In questo senso è solo l’attività artistica di riscrittura della storia che è in grado di generare un senso, delineare i contorni di un significato che comunque rimane sempre sfuggente.
La penna di Vollmann, così, mescola i piani e le storie e il personaggio del capitano Franklin si sovrappone a quello del narratore/autore (chiamato Sottozero), al punto tale che la temporalità collassa e spesso è impossibile distinguere il racconto della vicenda dell’uno da quella dell’altro: ci troviamo all’interno di una narrazione allucinatoria in cui il viaggio diventa quasi una ricerca esistenziale dell’ignoto. Anche la geografia diventa lo spazio dell’insondabile, impossibile da cartografare: i luoghi del sogno si sovrappongono a quelli della realtà e il continuo muoversi, spostarsi, camminare conduce paradossalmente a un delirio di immobilità, alla sensazione di non essere in un nessun posto preciso.
Una logica della reversibilità, dunque, sembra informare le pagine di Vollmann, per cui ogni caratteristica del suo universo narrativo è in continua relazione e confusione con le altre. Non a caso lo stesso narratore ammette di non sapere «descrivere niente se non in rapporto a qualcos’altro». Così storie, luoghi e tempi si sovrappongono per dar vita a una storia simbolica dell’uomo: «perché dovete capire che all’epoca lui stava componendo una serie di Sette Sogni per capire la vita».
Si tratta, insomma, di far collassare il tempo e lo spazio per individuare e indagare delle costanti del comportamento umano, che vengono certamente messe alla prova delle determinazioni storiche, ma rappresentano, allo stesso tempo, uno sforzo di individuazione di unità significanti attraverso le quali indagare il senso dello stare al mondo.
Questa strategia di reversibilità è perseguita, sul piano formale, anche attraverso una confusione pronominale per cui “io” “lui”, “noi”, “tu” si alternano incessantemente per narrare la storia dei due protagonisti. A uno stesso processo sono sottoposti gli altri personaggi che arrivano talvolta a confondersi o a incarnare archetipi della cultura inuit. Per cui racconto storico e racconto simbolico si fanno tutt’uno per mettere in scena la difficoltà della ricerca storiografica, ma soprattutto per farsi allegoria e mitologia di una vicenda universale di socialità umana. In Fucili, infatti, ritroviamo moltissimi dei temi cari a Vollmann e che diventano modi attraverso cui indagare l’identità del singolo e i suoi modi di interazione con l’altro – un’alterità indifferentemente umana e non umana. Ritroviamo così la tematica del colonialismo, dei rapporti di dominio e di potere, la questione ambientale, la trasformazione del paesaggio, il rapporto fra civiltà e capitalismo, il senso e il ruolo della violenza, l’interazione umana, l’indagine sui sentimenti, l’incontro con l’altro, la riflessione sull’amore e la sofferenza. «Voleva disperatamente essere amato», la ricerca e l’indagine delle relazioni interpersonali diventa sin dall’inizio uno dei motivi del testo, analizzato in tutte le sue declinazioni e problematiche contraddizioni: «In quel momento gli sembrava che al mondo tutti volessero soltanto affetto. Perché darlo e riceverlo costava così tanto?». O ancora:
Sottozero ebbe così modo di avvertire una disgustosa ondata di libidine maschile, la stessa che Reepah doveva aver sentito da lui – non che la libidine sia o debba essere per forza disgustosa, ma il bisogno è degradante in qualunque forma, per questo i mendicanti suscitano disprezzo, e Sottozero, che di norma avrebbe tollerato la presenza di quell’uomo, quel giorno provò un senso di sporcizia; quell’uomo era il suo riflesso in uno specchio incrostato.
Attraverso il racconto della storia con Reepah, che è contemporaneamente il corpo d’indagine delle condizioni di vita di una donna Inuit e incarnazione della dea della fertilità, Vollmann mette in scena una topica delle relazioni interpersonali senza risparmiare nulla: dalla dinamica servo-padrone alle problematiche della monogamia, passando per la gelosia, la maternità, la difficoltà a comunicare e l’aspirazione a un amore totalizzante: «Se davvero volevi l’amore eterno, se volevi davvero trasformarti e dare e divorare senza tregua, allora posso quasi perdonarti perché l’amore è necessario quanto crudele».
Il legame fra necessità e crudeltà torna spesso sottotraccia in queste pagine per mostrare che azioni necessarie alla sopravvivenza spesso si inseriscono all’interno di un meccanismo di causa-effetto per cui la necessaria salvaguardia di un modo o di un mondo significa anche la crudele condanna a morte di altri mondi, di altre possibilità. Ma Fucili è anche, e forse soprattutto, un romanzo sul senso e sulla costruzione dell’identità: «tu volevi possedere altre personalità per poter essere io e l’altro. Avendo tripartito la tua natura più o meno alla stressa stregua di Dio, potevi travasarti da un flacone spirituale all’altro con infinita tensione erotica». Investendo sul proprio corpo altre storie, altre persone, altri immaginari, Vollmann compie anche un lavoro di ricerca e costruzione del sé, una riflessione sulle modalità in cui l’incontro con l’alterità plasma la propria autocoscienza e il proprio sguardo sul mondo, ma anche un tentativo disperato di abbattere le barriere e i confini fra l’io e l’altro, fra l’io e il mondo, attraverso una scrittura che nasce «per amore, o forse per risolvere i problemi del mondo […], per risolverli esattamente come un’equazione differenziale, evitando nel frattempo la soluzione dei propri».
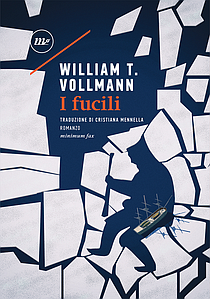 William T. Vollmann, I fucili, trad. C. Mennella, minimum fax, Roma 2018, 498 pp. 19,00€
William T. Vollmann, I fucili, trad. C. Mennella, minimum fax, Roma 2018, 498 pp. 19,00€