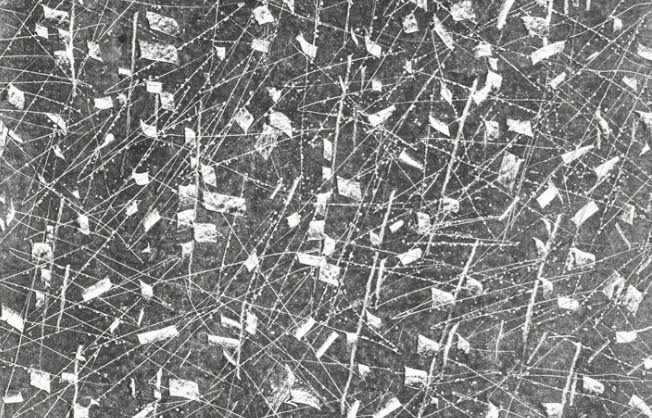Mark Tobey, “Number 15”, 1970 (particolare)
È possibile considerare la traduzione di un testo letterario come un evento, o meglio, come una festa? Certamente, se il testo in questione è Finnegans Wake di James Joyce, e se la traduzione italiana dei suoi libri finali (J. Joyce, Finnegans Wake. Libro III, capitoli 3 e 4. Libro IV, tr. it. e a c. di E. Terrinoni e F. Pedone, Mondadori, 2019) rappresenta il momento apicale di un’impresa epica: una sfida ingaggiata con un libro licenziato nel 1939, aperta più di trent’anni fa e conclusa precisamente ottant’anni dopo la sua pubblicazione.
Veniamo invitati a partecipare a questa festa da un commensale d’onore. Anthony Burgess, nel 1965, scrisse un libro (Re Joyce, purtroppo mai tradotto in italiano) tuttora efficacissimo per accompagnare un lettore, giocoforza quantomeno disorientato, nel cosmo joyciano. Ponendosi nella prospettiva di chi commenta – invece di ostinarsi a sovrainterpretare un libro che, «vicinissimo a un’opera della natura»[1], sfugge per definizione a qualsiasi tentativo di decifrazione esatta – rovescia ogni pregiudizio di inaccessibilità del Joyce estremo, ammonendoci che i suoi labirinti testuali (Ulysses e, appunto, Finnegans Wake) non sono «una giungla di liane in cui rimanere intrappolati»[2]; casomai una fitta foresta, intricata tanto quanto la vita umana, e tutta da percorrere. Burgess ci dice infatti che cominciare un libro di Joyce è un «rituale gioioso [joyful]» da celebrare «solennemente ma senza solennità»[3]: a tutti gli effetti una vera festa.
Doppia, nel nostro caso, perché in concomitanza della traduzione joyciana uno dei suoi estensori, Enrico Terrinoni, ha rilasciato un contributo personale: Oltre abita il silenzio. Tradurre la letteratura (Il Saggiatore, 2019), ibrido saggio in cui annota, nella forma libera di un quasi-zibaldone, tutte le implicazioni di quel «viaggio nello spazio-tempo» (p. 143) che è l’interpretazione, ovvero la traduzione, anche quando tende verso i limiti del possibile come nel caso del tardo Joyce.
Entrambi i risultati del lavoro di Terrinoni e colleghi (traduzione e saggio sulla traduzione) si allineano al proposito, caro a Burgess, di sfrondare la giungla di qualche liana senza però deforestarla, e di aprire invece al lettore molti sentieri, non solo per interpretare la scrittura joyciana, ma soprattutto per goderne. Accettiamo l’offerta e scegliamo, per magnificare quest’opera, di percorrere una pista laterale e poco battuta.
Sebbene Burgess sostenga che la trama di Finnegans Wake sia essenzialmente musicale, legata alla voce e al canto, al punto da sostenere che «ritrovi i suoi colori e le sue forme nei suoni»[4], è innegabile che Joyce, con il passaggio dalla scrittura al segno («Il grafo proteiforme è in sé poliedro di scrittura [The proteiform graph itself is a polyhedron of scripture]»[5]) non si limiti a sublimare il visibile nell’acustico. Le caratteristiche della sua scrittura, polisemica e sfaccettata come un prisma, chiamano in causa tutte le dimensioni della percezione («Io, un sé di segno [I, a self the sign]», FWTP, pp. 22, 23), non solo riassumendole in un unico «ammirevole pre-sentimento verbovocovisivo [an admirable verbivocovisual presentment]»[6], ma mettendole in gioco l’una con l’altra in una continua interazione sinestesica.
Può risultare utile, dunque, accostare questo testo dal lato del visibile e, più precisamente, leggere cosa ne hanno scritto – in un momento cruciale della storia della cultura: la svolta modernista – due importanti critici dell’arte: Harold Rosenberg e Clement Greenberg. Il punto di vista di due specialisti della riflessione sull’immagine, e non di ermeneuti della parola, può illuminare Finnegans Wake dall’alto e con luce nuova, e darne (come si è soliti dire) un’immagine complessiva (un’«innagine [imnage]»[7], come direbbe Joyce, che unisce icona e testo con il fasto dell’inno).
Harold Rosenberg, che dagli anni Cinquanta diverrà famoso per gli scritti sulla pittura d’azione e per l’invenzione della nozione stessa di Action Painting, imbastisce la sua teoria dell’immagine modernista come gesto (precipitato del processo creativo dell’artista) spendendo parole anche sulla crisi d’identità che investe i personaggi del dramma e del romanzo d’avanguardia. Finnegans Wake è il paradigma del romanzo che, con un meccanismo quasi autodistruttivo, non svuota soltanto di senso la sua essenza, ma dimostra anche quanto la stessa processualità che lo sviluppa sia, essenzialmente, un continuo divenire: «La struttura circolare di Finnegans Wake, di Joyce, è un’altra dimostrazione di come il dinamismo dell’atto sia stato sostituito coi ritmi del processo organico. Non solo l’inizio e la fine scorrono insieme nel fiume della prosa che ritorna su stessa, ma la metamorfosi degli episodi è così rapida e continua da disintegrare l’identità dei protagonisti i cui atti potenziali finiscono per essere svuotati da continui aggiustamenti linguistici e psicologici»[8]. Come spesso accade, nel libro di Joyce si trovano le parole perfette per dire qualsiasi cosa; non stupisce dunque l’apparizione del pensiero precedente, incarnato nel testo: «Un essencor in ancor divenir [A being again in becomings again]» (FWTP, pp. 38, 39).
Nel suo scritto forse più celebre, Clement Greenberg fa cadere il romanzo di Joyce in un discorso tutto dedicato a circoscrivere le caratteristiche della nuova pittura astratta dopo la rivoluzione delle Avanguardie storiche: «Così questi pittori rendono equivalente ogni elemento, ogni parte della tela; e allo stesso modo tessono l’opera d’arte in una stretta maglia il cui principio di unità formale è contenuto e riepilogato in ogni filo, così che l’essenza dell’opera intera si ritrova in ognuna delle sue parti (per un parallelo in letteratura, si vedano Finnegans Wake di Joyce o Gertrude Stein). Ma questi pittori vanno persino al di là […], rendendo le loro variazioni sull’equivalenza così sottili che a prima vista nei loro dipinti potremmo vedere non equivalenze, ma un’uniformità allucinata»[9].
Se altrove il critico aveva denunciato un’incompatibilità di fondo tra il quadro modernista (portatore di un’integrità formale in tutto autosufficiente) e il romanzo modernista (necessariamente legato alla referenzialità, a prescindere dal grado di sperimentazione), suggerisce qui che Finnegans Wake possa dirimere, proprio in virtù di un trattamento formale sovversivo, gran parte dei problemi relativi alla forma testuale. La forma del romanzo viene a tal punto degerarchizzata da mostrarsi in ogni parola; ogni parola di Finnegans Wake può essere letta infatti come un romanzo, appunto perché non ha mai un referente preciso. La croce del traduttore diviene così delizia del lettore, che non solo spazia tra infiniti significati, ma legge effettivamente infiniti romanzi in uno.
Che cosa differenzia allora la figura che, a prescindere dagli scopi, si ritrova a dovere in qualche modo fissare una traduzione, a stabilire un testo a partire da un altro? I testi tradotti, si è detto, non sono altro che testimoni del «continuo processo traduttivo a cui ci sottopone l’esistere, in tutte le sue forme» (p. 13, con una formula che sintetizza la processualità di Rosenberg e la tessitura formale di Greenberg). Per rispondere alla domanda Terrinoni mette significativamente in campo – e lo fa spesso, spargendole in vari punti del suo libro – metafore iconiche. Un esempio efficace: «La traduzione come interpretazione è infatti un prisma. Ma il prima può essere di vetro, e un vetro può diventare specchio o finestra. Alcune finestre sono pure specchi incerti, in cui la nostra immagine si riflette male poiché frammista a ciò che è al di là. Tuttavia, la cosa interessante degli specchi e delle finestre è il fatto che abbiano delle cornici, cornici che involontariamente delimitano la nostra capacità visuale» (p. 84). L’ultima immagine è eloquente: chi traduce testi scritti ha in più, rispetto al lettore e all’autore, l’onore e l’onere di circoscriverli. Gli spetta un ruolo simile a quello della cornice per il quadro: soglia che ne delimita i confini, invitando però al contempo a oltrepassarli di continuo, perché siano sempre messi in discussione.
Anche in questo caso, è lo stesso Joyce (insieme a Terrinoni e Pedone) a suggestionarci massimamente, grazie a uno dei tantissimi momenti metaletterari del suo libro, in cui la scrittura fa parlare la scrittura stessa e chi non può fare a meno di tradurla: «Il prouts che colà inventerà una scrittura è in fine il poeta, ancor più erudito, che colà in principio rintrazziò la lettura. È questo il punto dell’escatologia che il nostrucido libro di chill sa raggangere in contrappante parole [The prouts who will invent a writing there ultimately is the poeta, still more learned, who discovered the raiding there originally. That’s the point of eschatology our book of kills reaches for now in soandso many counterpoints words]» (FWTP, pp. 20, 21).
Come giustamente sostiene Terrinoni, nessun libro è intraducibile e, fortunatamente, dove c’è testo è sempre consentito combinare o stravolgere contrappunti di parole. Il caso di Finnegans Wake spesso è apparso ai limiti del possibile perché, come puntualizza Burgess, non si tratta di «letteratura in stato di veglia» ma di un «libro di sogno»[10]. È occorso tanto sforzo per tradurlo dato che l’impresa è paragonabile a una trascrizione di segni nel sonno, che può far brancolare nel buio; perciò bisogna ringraziare chi l’ha permessa come fosse un celebrante, festeggiare e non smettere mai. Altrimenti «che babeltìo statico è questo, dicci? [or what static babel is this, tell us?]» (FWTP, pp. 54, 55).
James Joyce, Finnegans Wake. Libro III, capitoli 3 e 4. Libro IV, tr. it. e a cura di E. Terrinoni e F. Pedone, Mondadori, Milano 2019, LXXII-686 pp. 24,00€
[1] A. Burgess, Re Joyce (1965), Norton, New York-London 2000, p. 185.
[2] Ivi, p. 24.
[3] Ivi, p. 17, 26.
[4] Ivi, p. 29.
[5] J. Joyce, FW 107 [t.n.]. Vista l’impossibilità di escludere, citando Finnegans Wake, la lezione originale, scioglieremo in nota i riferimenti alle parti del testo joyciano non comprese nel volume Mondadori con traduzioni nostre, accompagnate dai numeri di pagina dell’edizione completa di FW (che per consuetudine e comodità rimangono inalterati ogni volta che lo si ristampa integralmente). Le citazioni dalla traduzione Terrinoni-Pedone saranno invece indicate tra parentesi, aggiungendo alla sigla FWTP i numeri di pagina del volume Mondadori.
[6] J. Joyce, FW 341.
[7] J. Joyce, FW 82.
[8] H. Rosenberg, “L’atto dimezzato” (1970), in Id., Scritti sulla pittura d’azione, tr. it. e a c. di M. Cianchi, Maschietto, Firenze 2006, pp. 153-162, qui p. 157.
[9] C. Greenberg, “La crisi della pittura da cavalletto” (1948), in Id., L’avventura del modernismo. Antologia critica, tr. it. di B. Cingerli, Johan & Levi, Monza 2011, pp. 78-81, qui p. 80.
[10] A. Burgess, Re Joyce, cit., p. 264.