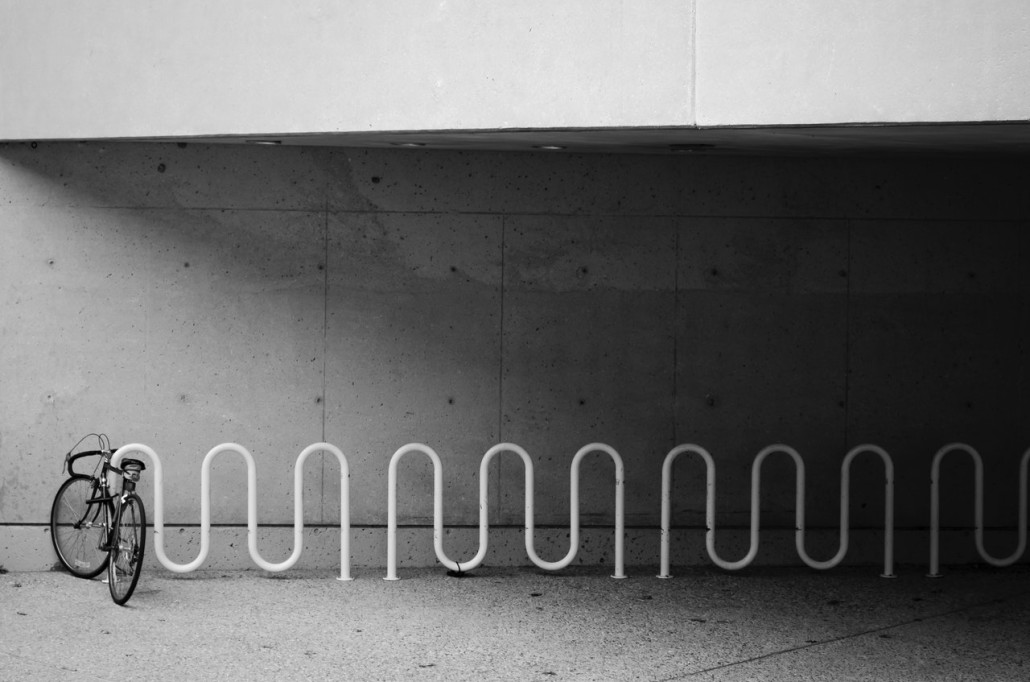Folla delle vene (Corsiero, 2018) è il sesto libro del poeta pistoiese (fiorentino d’adozione) Paolo Fabrizio Iacuzzi, un titolo che lega i due fili principali dell’opera: comunità e interiorità. Chi abbia seguito finora l’arduo sentiero poetico di Iacuzzi avrà imparato a riconoscere ai lati della strada il ritmo insistente di alcune ossessioni faticosamente ammaestrate che si ripresentano senza preavviso sul maxischermo del poema, sotto forma di figure affettive più ingombranti del previsto. Tra fiori, calzature e cibarie (oltre ai biscotti, al “pane e aglio”[1] e ai simbolici “sformati”[2] preparati dalla madre, difficile togliersi dalla mente il “pesce finto” di Jacquerie[3]) nell’inventario affettivo/infettivo di Iacuzzi spicca da sempre la bicicletta, apparsa “bianca” la prima volta in Magnificat[4] e ora trasfigurata in oggetto bifronte, a metà tra la cyclette e la bici “high tech” dei velocisti.
Al di là delle figure, si assiste invece a una successione di eventi atemporali: lampi di memoria intima e familiare sotto forma di quadri e fotografie, sconfinamenti improvvisi nella “poesia d’arte” e reperti (cog-)nominali rinvenuti sotto le frane della biografia in forma di una singola vocale (la “I” di Iacuzzi)[5]. Inoltre, una singolare connotazione cromo-simbolica di questi quadri poetici è garantita dai metodici e abbondanti conferimenti di colore del poeta ai propri libri: qui a prevalere è il rosa, ma le tinte sono di volta in volta selezionate da una palette ben descritta da Pasquale di Palmo nella nota critica («[…] il bianco del citato Magnificat, il blu di Jacquerie, il giallo di Patricidio[6], il Rosso degli affetti[7]»[8]).
Del resto, siamo autorizzati a parlare di “quadri poetici” da Iacuzzi stesso che – nel sottotitolo del libro Il museo che di me affiora, e nel titolo di sezione La vita a quadri – ci indica la legenda di un labirinto museale, il cui catalogo attinge da ogni possibile situazione offerta dalla realtà quotidiana e dalla memoria. Da Bricoland all’Arcadia, ci si muove sulle tracce di un umorismo plurilinguistico, preso in prestito da Giovanni Giudici ma sganciato dal cinismo, orientato piuttosto verso una totalizzante e ironica religiosità del reale: reattiva ai simboli, allergica alle censure. Assistiamo a una cordiale, nervosa visita guidata sul “tapis-roulant” della poesia (su questo si veda anche Monti su «Il Manifesto»), mentre inaspettatamente sotto ai piedi vediamo il pavimento crollare e mostrare una sterminata planimetria del dolore personale e universale: un mosaico complesso e delicato come quello di Aquileia, da osservare su piattaforme rialzate o da più lontano per non perdersi nel dettaglio, nella forma della singola tessera («Ma da quando siete venuti qui da lontano ancora / il lontano ha smesso di essere una minaccia vera»[9] confessa Iacuzzi nella sezione Il tempo degli amici ai traduttori venuti da Marsiglia per lo Scriptorium, un laboratorio internazionale di traduzione poetica).
Ma di quali folle parliamo? Passando rapidamente in rassegna i volti del corridoio vasariano di questo libro, riconosceremo il padre e la madre, Marco Pantani e Francesco Petrarca, i poeti amati Mario Luzi e Piero Bigongiari, la Vergine delle rocce di Leonardo, Chagall e Michelangelo, gli amici traduttori André, Valerie, Dominique, poi Frankenstein con Mary Shelley e Giuseppe Verdi, Edipo e l’imperatrice Teodora e molte altre figure più o meno spettrali, chiamate a puntellare i tratti somatici e i bivi esistenziali dello stesso Iacuzzi. Personaggi evocati, incontrati oppure dimenticati e riemersi, talvolta strappati alla loro solitudine e mescolati l’un con l’altro in un impasto mnestico tra realtà, sogno e ricordo (come Pantani e Petrarca in ascesa sul Mount Ventoux, con buona pace di uno scandalizzato Cesare Cavalleri su «Avvenire»). Siamo in uno spazio di contaminazione dove, a temperature altissime, il mito, il quotidiano, la cronaca e la Storia del Novecento possono fondersi con la storia familiare e formare un unico, spesso tragico racconto di speranza. Ciò che emerge è quindi un rovello che, pur dipanandosi lentamente, mantiene la tensione e la memoria dei nodi che lo hanno intrigato.
È stato già notato come, libro dopo libro, Iacuzzi abbia progressivamente socchiuso la soglia ermetica della sua poesia, diluendo la complessità senza però smarrire la riconoscibilità dello stile e l’intonazione della voce. Folla delle vene ci dà in effetti l’occasione di calarci nel preletterario di Iacuzzi, liofilizzato in poesie che, pur nella leggibilità, sono rese continuamente elettriche dal complesso rapporto tra l’io e il mondo, permeato da una ricerca inesausta e alimentato dal rifiuto categorico di un basso profilo esistenziale. Loretto Rafanelli su «SuccedeOggi» ha giustamente parlato di una «profonda urgenza, di una scarnificata verità, di insistenti oscurità, di rassegnazioni e possibili cauti slanci», elementi a cui io aggiungerei anche l’ostinazione del poeta nella ricerca di verticalità-ascensione e circolarità-compimento («Stanotte ti ho visto volteggiare in cerchi […]. Uomo / dentro l’asse della madre»[10]).
Se è vero che questa è la dinamo della bicicletta-poesia di Iacuzzi, è altrettanto vero che tale vertiginosa urgenza reca con sé l’effetto collaterale del terrore, quell’horror vacui di fronte all’insensatezza del dolore che ammutolisce la propria e altrui esistenza. L’horror vacui – che sia dall’alto di una “carrucola” o dalla cima del campanile di “Notre-Dame de la Garde” – viene combattuto, secondo una precisa definizione di Di Palmo, con l’horror pleni della pagina scritta, e spesso tramite il ricorso rigorosamente solo visuale alle forme metriche della tradizione. Esempio concreto delle dinamiche di scrittura di Iacuzzi è la Meditazione sopra la Vergine delle Rocce di Leonardo, opera pittorica in cui notoriamente l’autore utilizza la prospettiva aerea per ottenere una profondità illusoria: in questa scenografia fittizia (resa in poesia tramite l’uso di sei squadratissime strofe di cinque versi, struttura non comune nella tradizione metrica italiana) Iacuzzi dispone, come in un presepe, alcune figure capitali della propria infanzia, sovrapponendole a quelle dipinte nel quadro affinché il linguaggio dell’arte possa dar loro corpo e nuovo significato.
Nella poesia di Iacuzzi la frequente occorrenza della folla introduce il sospetto di un’agorafilia, degenerazione adulta del sentimento tipico dei bambini che, alle prese con un nuovo male oscuro e impossibile da debellare, cercano la presenza di figure care che possano condividere e sopportare una solitudine e una mancanza di senso per loro intollerabile. Questo tema non è risolvibile con parafrasi e modi di dire sul mal comune e il mezzo gaudio, ma richiede piuttosto che – senza ricorrere alla troppo comoda categoria della poesia civile – si inquadri la poesia di Iacuzzi in una non banale prospettiva etica: nel bailamme di un contemporaneo globalizzato fitto di messaggi incomprensibili, il poeta non aspira a un ruolo pubblico, bensì ricerca per sé il sollievo e la solidità di una comunità, di qualsiasi tipo essa sia.
Anche gli esclusivi legami filiali e coniugali rappresentano virtù e contraddizioni di una comunità, persino il rapporto con sé stessi può essere comunitario, se è vero che dentro di noi esiste una folla di vene da intrecciare e sciogliere continuamente nell’attesa dell’altro da sé. In fondo non è difficile stilare – come nel caso dei personaggi-solitudini – una lista di tutte le folle di Iacuzzi, implicite o meno. In primis, il gruppetto di amici traduttori provenienti da Marsiglia della sezione Il tempo degli amici, cronaca del tentativo che è la traduzione letteraria di “sposare” due lingue nella “babele di varianti”, in un pathos transnazionale (si veda Piersanti su «Pelagos») che interroga la possibilità di un’Europa della lingua e dell’umano, pur nella consapevolezza che «non c’è tempo amici per le cose», mantra anaforico in endecasillabi che scandisce le nove poesie della sezione.
Poi ancora: il corteo delle dame bizantine al seguito di Teodora, la “comunità di inermi”, la “folla di migranti” inscritta genialmente nel Tondo di Michelangelo, le spiazzanti parate carnascialesche, il manipolo degli apostoli, la “comunità fantasma” dei popoli antichi, il coro del teatro greco, la tragica folla dei deportati omosessuali con la stella rosa appuntata al petto, la “fossa comune”, la “folla rosa degli affetti”, dei “cari non ancora morti” (tra “genealogie” e “geniture”), la schiera di scolari riunita intorno alla maestra in gita a Ravenna, la calca di turisti sul battello a Venezia, il gruppo di ciclisti che segue Pantani in salita, la “folla di case” ecc.
Del resto, è il Baudelaire di Lo spleen di Parigi a rassicurarci di fronte a questa enorme marea di figure: «Il passeggiatore solitario e pensoso trae una singolare ebbrezza da quest’universale comunione. […] Egli fa sue tutte le professioni, tutte le gioie e le miserie che il caso gli presenta. Ciò che gli uomini chiamano amore è ben piccolo, angusto e debole, paragonato a quell’ineffabile orgia, a quella sacra prostituzione dell’anima che si dà tutta intera, poesia e carità, all’imprevisto che si mostra all’improvviso, allo sconosciuto che passa.» Evocando le case e le figure angeliche di Chagall, nell’ultima poesia del libro Iacuzzi congeda il lettore con una dichiarazione di poetica: «Folla è per te che io ho cantato / ma non so se questo canto ti piace / la voce che s’alza dal mio petto / è tutta un dolore e fa fatica»: resoconto sorprendentemente trasparente di un’impresa per certi versi dantesca, come rileva Aglieco sul suo blog di critica quando sottolinea l’evidente richiamo alla “Candida Rosa”.
Quello di Iacuzzi è in definitiva un canto intimo e universale che svela – nell’irrinunciabile quête ana/catabatica della poesia – il dolore più grande: è infatti nella sezione Salva con il cognome che il poeta cerca la ragione lettera per lettera del proprio nome, da sfogliare come i petali della “rosa pulita” di un amore inaspettato che fiorisce nell’ossario:
Non esiste il tempo dell’amore. Esisti solo tu in un ossario.
I: biondo. I: cenere. Salgono dal fiume in una folla rosa.
Piantate le fiocine! I: che sei corredo ai morti nel Ventoux.— Ci sarà una liana per te. Una rosa ti allaccerà di nuovo
alla vita. La ruota del mulino girerà inversa nel tuo fiume?
I: che dell’amore inverso già nel desiderio porti il segno.— Ora che l’amore è questa rosa pulita. Levigata ora
con tutti i pezzi del mio corpo. Minerali d’osso. Quarzi
impestati ma salvati! I: che nella pietra feci l’alchimia.[11]
Paolo Fabrizio Iacuzzi, Folla delle vene, Corsiero editore 2018, pp. 80, € 13.
[1] Folla delle vene, p. 41.
[2] Ivi, p. 52.
[3] Nino Aragno, 2000.
[4] I Quaderni del Battello Ebbro, 1996.
[5] Cfr. la sezione “Salva con il cognome”, in Folla delle vene (pp. 67-72).
[6] Nino Aragno, 2005.
[7] Nino Aragno, 2009.
[8] Postfazione a Folla delle vene, p. 77.
[9] Folla delle vene, p. 17.
[10] Ivi, p. 11.
[11] Ivi, p. 78.