Va detto che il jazz parte da una posizione piuttosto avvantaggiata: c’è sempre qualcuno pronto a dichiararlo morto. È una situazione decisamente invidiabile, perché quando non fanno altro che darti per finito non si ha più niente da perdere, nessuna pressione, solo sorprese. L’unica insidia è la retorica della rinascita, o del periodo d’oro, o della crisi, ma a eventuali domande su dove stia andando il jazz conviene probabilmente rispondere con le parole di Thelonious Monk: «Non so dove stia andando. Forse sta andando all’inferno. Non si può spingere nulla ad andare da alcuna parte. Ci va e basta».
In queste ultime settimane sono usciti due libri che potremmo piazzare convenzionalmente uno all’inizio e l’altro alla fine del jazz, facendo coincidere paradossalmente mito dell’origine e mito della fine, una delle magie storiografiche e critiche che il jazz permette. Il libro all’inizio è Mister Jelly Roll. Vita, fortune e disavventure di Jelly Roll Morton, creolo di New Orleans, «Inventore del jazz», di Alan Lomax (Quodlibet); quello alla fine è La musica del cambiamento. Jazz per il nuovo millennio, di Nate Chinen (Il Saggiatore). L’edizione originale del primo è uscita nel 1950, quella del secondo l’anno scorso.
Non sappiamo se oggi, una settantina di anni dopo quella celebre risposta di Monk, il jazz stia andando all’inferno. Ma questi due entusiasmanti libri ci confermano che, se anche così fosse, varrebbe la pena di seguirlo anche da quelle parti.
Alan Lomax, Mister Jelly Roll
 C’è per esempio quel bel libro a fumetti, Lomax. Ricercatori di folk songs (Coconino), di Frantz Duchazeau: racconta di John e Alan Lomax, padre e figlio, e delle loro peregrinazioni per le piantagioni e le cittadine degli Stati Uniti del sud, soprattutto nella zona del delta del Mississippi, dove fecero in presa diretta innumerevoli registrazioni di canti folklorici per conto della Biblioteca del Congresso americano. Concentriamoci su Alan, il figlio. È con lui che, il 21 maggio 1938, Jelly Roll Morton, pianista creolo di New Orleans, aveva appuntamento in un auditorium della Biblioteca del Congresso, a Washington. Doveva essere una semplice intervista, e invece diventò un soliloquio fiume durante infinite sessioni. Ne venne fuori il libro Mister Jelly Roll. Vita, fortune e disavventure di Jelly Roll Morton, creolo di New Orleans, «Inventore del jazz», libro pilastro della storia della musica, del 1950 e molto stranamente finora mai tradotto in italiano. Lo porta ora in libreria Quodlibet, nella traduzione di Giuseppe Lucchesini.
C’è per esempio quel bel libro a fumetti, Lomax. Ricercatori di folk songs (Coconino), di Frantz Duchazeau: racconta di John e Alan Lomax, padre e figlio, e delle loro peregrinazioni per le piantagioni e le cittadine degli Stati Uniti del sud, soprattutto nella zona del delta del Mississippi, dove fecero in presa diretta innumerevoli registrazioni di canti folklorici per conto della Biblioteca del Congresso americano. Concentriamoci su Alan, il figlio. È con lui che, il 21 maggio 1938, Jelly Roll Morton, pianista creolo di New Orleans, aveva appuntamento in un auditorium della Biblioteca del Congresso, a Washington. Doveva essere una semplice intervista, e invece diventò un soliloquio fiume durante infinite sessioni. Ne venne fuori il libro Mister Jelly Roll. Vita, fortune e disavventure di Jelly Roll Morton, creolo di New Orleans, «Inventore del jazz», libro pilastro della storia della musica, del 1950 e molto stranamente finora mai tradotto in italiano. Lo porta ora in libreria Quodlibet, nella traduzione di Giuseppe Lucchesini.
Morton arrivò in quell’auditorium del Congresso vestito in maniera sfarzosa, come al suo solito, con un orologio da tasca, vari anelli d’oro e un diamante incastrato in un dente. Si trovava lì perché Alan Lomax era interessato alla sua storia. E si trovava lì anche perché credeva fermamente di meritare un posto negli archivi del governo e nella storia, visto quel che affermava con sicurezza di aver fatto: inventare il jazz. «Lo senti questo riff? Ora lo chiamano swing, ma è solo una piccola cosa che ho inventato io un sacco di tempo fa».
Morton non era avaro di uscite del genere. Un discografico di Chicago racconta:
Un tipo entrò nel nostro negozio con un’ampia bandana rossa al collo e un cappello da cowboy da dieci galloni sulla testa, e gridò: “Ascoltatemi tutti! Io sono Jelly Roll Morton di New Orleans, l’inventore del jazz!” Parlò della propria bravura per un’ora intera senza fermarsi, poi sedette al pianoforte e dimostrò che era bravo proprio quanto aveva detto, anzi di più.
Alan Lomax diffidava del jazz. Come Theodor Adorno, vi vedeva l’espressione di una certa aggressività capitalistica. Cambiò idea. Eccome se cambiò idea. In quella intervista infinita, Morton sedeva al piano, raccontava la sua vita e la vita a New Orleans all’inizio del jazz, e intanto si accompagnava suonando, e ogni tanto si lasciava andare a brani interi, prima di riprendere la narrazione (le registrazioni sono peraltro tutte disponibili anche in streaming). Lomax su quei momenti: «I busti in gesso di Bach, Beethoven e Brahms guardavano in basso severamente, ma se Jelly li notò, probabilmente pensò che stavano imparando una o due cosette». Lomax poi trascrisse tutto quel che aveva raccontato Morton, vi aggiunse altre interviste con altri protagonisti dell’epoca, distillò il tutto in una prosa affascinante e divertente insieme, e nel 1950 ne tirò fuori questo capolavoro, Mr. Jelly Roll.
Quello di Jelly Roll Morton era un mondo di mâitresse,s di bordelli, delinquentucci, musica ovunque, bulli, di avidi discografici, un mondo in cui i gangster erano i mecenati più affidabili e costanti per i nuovi musicisti di jazz, un mondo in cui Louis Armstrong trasportava carbone e Buddy Bolden faceva anche il barbiere, tanto per prendere l’esempio di due trombettisti più noti della scena di New Orleans, «la Firenze degli Stati Uniti, la loro Parigi», una Firenze o Parigi dove «i creoli di pelle chiara finirono per incontrare i musicisti afroamericani, che lottavano per trovare una via d’uscita dal ghetto nero».
Oltre che per il suo valore come testimonianza di storia orale e il suo interesse musicologico, Mr. Jelly Roll è estremamente affascinante anche in termini stilistici e di costruzione del testo. A proposito delle questioni di scrittura, Lomax – che ci mise quattro anni a mettere su pagina le parole di Morton e quelle delle altre persone che aveva intervistato – osserva: «Le persone che incontravo alla fine dei miei viaggi, di città o di campagna, pronunciavano frasi che si snodavano sulla pagina come fiumi o come catene montuose. Jelly Roll parlava così».
E, oltre al grande fascino della narrazione, non mancano i passaggi da sbellicarsi, come quando si racconta di un certo locale, dove:
c’era un prosciutto appeso al lampadario, a un metro e ottanta d’altezza. Ogni donna che riusciva a dare calcio al prosciutto poteva portarselo a casa. Ne ho vista più d’una che si è fracassata il culo nel tentativo di riuscirci, ma a loro non importava, e certo a noi non dispiaceva guardar loro le gambe.
Jelly Roll Morton sarebbe morto in povertà. E, come lui, tanti altri grandi pionieri della storia della musica: «i neri che hanno creato il jazz per lo più sono morti al verde, oppure hanno dovuto abbandonare il jazz per non crepare di fame». Lavoratore molto più rigoroso e instancabile di quel che potrebbe emergere dal libro, Morton non riuscì mai a farsi riconoscere i diritti delle sue innumerevoli e fortunatissime composizioni:
Naturalmente il mio nome non c’è tra gli autori di quella canzone, ma io non sono geloso. Auguro a quei ragazzi di scrivere un milione di altri pezzi simili, ma dal momento che questo racconto è per l’Archivio, dove sei chiamato per documentare i fatti, la verità deve pur venire fuori.
La sua rovina arrivò con la crisi del 1929. E con quella rovina avevano anche a che fare quelle questioni razziali che Morton non aveva mai troppo sul serio. «Non esprimeva il lamento del blues, l’emarginato senza tetto». Aveva interiorizzato la propria subalternità razziale e, a differenza di molti suoi colleghi, non la metteva in discussione, fosse anche attraverso una certa inclinazione emotiva della sua musica. Come raccomanda un altro dei testimoni interpellati da Lomax:
Tieni un tempo vivace, ma metti il pianto dovunque ci sia l’occasione di farlo, così i tuoi ascoltatori potranno sì ballare, ma anche sentire le lacrime che ci sono dietro. È questa la formula principale del jazz: competenza mulatta stagionata nel dolore nero.
Il nutrito apparato critico del libro – la prefazione di Stefano Zenni, la nota di Claudia Sessa, la loro guida all’ascolto in appendice e la postfazione di Lawrence Gushee, insieme ai disegni di David Stone Martin – ci mettono al corrente degli studi che hanno ora smentito ora confermato quanto raccontato da Jelly Roll Morton e quanto distillato da Lomax. Quest’ultimo non si trattenne da alcune distorsioni, che avevano per lo più l’obiettivo di far apparire Morton come voleva Lomax, mosso da uno spirito romantico. Eppure, a lettura ultimata, l’impressione è forte: fu più Morton a cambiare Lomax che Lomax a dare un ritratto infedele di Morton.
In definitiva, Lomax decise di correre un rischio: puntare sulle avventure e sulla personalità di Morton accentuandone certi tratti, talvolta al limite del grottesco e rendendolo una figura mitica del firmamento, il tutto a scapito di una certa dose di rigore storiografico e musicologico («I musicisti jazz sono forti nel ritmo, ma deboli sulle date»). Lo fece apparire molto più sbruffone di quel che era nella realtà, per esempio. Ma la sua fu una scommessa vincente, e l’operazione di Lomax finì per offrirgli ciò che Jelly Roll Morton desiderava più di ogni altra cosa: un posto nella storia della musica. E questo libro gli assegna un posto – e un posto fra i migliori – anche nella storia della letteratura.
Nate Chinen, La musica del cambiamento
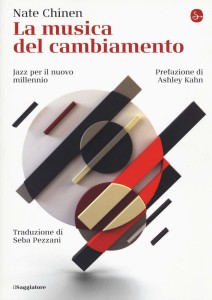 A una settantina di anni dal libro di Alan Lomax sull’“inventore del jazz”, eccone arrivarne uno sulle molteplici invenzioni del jazz di oggi.
A una settantina di anni dal libro di Alan Lomax sull’“inventore del jazz”, eccone arrivarne uno sulle molteplici invenzioni del jazz di oggi.
Nate Chinen è un critico musicale per «New York Times» e «Jazz Times», e ora in forza al settore jazz di NPR, la radio americana. Il suo fortunato libro, dall’ambivalente titolo originale Playing Changes, arriva ora in Italia per il Saggiatore nella traduzione di Seba Pezzani: La musica del cambiamento. Jazz per il nuovo millennio, con prefazione di Ashley Kahn.
Ognuno dei dodici capitoli del libro è dedicato a una diversa area di quel che di nuovo – effettivamente nuovo o solo relativamente nuovo – è emerso negli ultimi tre o quattro decenni nel panorama cangiante del jazz e delle sue molteplici e vitali intersezioni. Dalla restaurazione di Wynton Marsalis al successo controverso di Kamasi Washington e della sua cerchia; dalla scena avanguardistica newyorkese aggregata attorno a John Zorn o Dave Douglas a (ormai ex) young lions quali Brad Mehldau e Joshua Redman; da figure a loro a modo anomale quali Steve Coleman o Jason Moran a quelli che Chinen definisce «nuovi veterani» (Wayne Shorter, Wadada Leo Smith, e così via); da nuovi giganti quali Vijay Iyer ad agitatori elettro quali Flying Lotus. E così via. È una scena globale di musicisti, scrive Chinen,
cresciuti con un accesso senza precedenti alle informazioni, questi artisti rovistano nella stoia del jazz alla ricerca non di una narrazione lineare bensì di una rete di possibilità. Il loro schema di riferimento è sufficientemente ampio da incoraggiare ogni forma di ibridismo. Intendono il jazz come qualcosa di diverso da una categoria stabile.
In un libro del genere, la tendenza a compilare un proprio canone è inevitabile, un’impostazione che Chinen cerca di evitare. Ma, se anche fosse una piccola trappola in cui cade, il suo rimane eventualmente un canone a cui ci si affida volentieri, grazie alla capacità di raccontare i suoi entusiasmi musicali con uno stile mai sopra le righe, controllato ed equilibrato ma, allo stesso tempo, con una capacità di coinvolgimento non così diffusa fra gli autori di libri sulla musica, e in particolare sul jazz.
Fra i tanti pregi de La musica del cambiamento c’è quello di saper mettere in diretta relazione fra loro aree della musica di oggi – che vengano considerate parte del panorama jazz o meno – apparentemente lontane fra loro. E non lo fa tanto per una sorta di spirito ecumenico, ma in ragione di una profonda fiducia nella continuità creativa ed espressiva fra mondi musicali che sono prima di tutto mondi culturali, politici ed emotivi.
Nel compiere questa efficace mappatura, quello che fa Chinen non è semplicemente identificare e accostare i pezzi sparsi di una scena globale della musica – o comunque di una musica che condivide un certo approccio alla creazione artistica, che la si chiami jazz o meno –, ma proprio di farla esistere, quella scena. Oltre all’imprescindibilità che questa mappa tratteggiata con precisione dall’autore – nonostante alcune comprensibili lacune e alcune scelte che, in base ai propri gusti, non si condividerà – avrà per chi vorrà orientarsi nella musica di oggi, musicisti e critici compresi, La musica del cambiamento permette anche di osservare questi musicisti e musiciste dalle quinte, come se Chinen ci offrisse allo stesso tempo la possibilità di conoscere di volta in volta tanto una scena quanto i suoi retroscena. Intermezzano la prosa di Chinen estratti da interviste, aneddoti, conversazioni personali con i musicisti in questione, capitoli di taglio reportagistico. È un approccio molto efficace sia per trasmettere curiosità rispetto a un artista e alla sua musica, sia per raccontare ai lettori qual è l’humus in cui nasce una determinata scena musicale o un certo musicista o disco, incluse le complessità dietro al mondo professionale della musica di oggi.
Si finisce la lettura con foglietti ovunque con, appuntati, nomi di dischi che si ha voglia di ascoltare, oltre ai cinque che Chinen elenca alla fine di ognuno dei dodici capitoli e alla lista finale intitolata I 129 album essenziali del XXI secolo (finora). Ma, al di là di nomi di musicisti e nomi di album, quel che Chinen mostra con efficacia è quanto, riprendendo le sue parole, «la storia della musica, tuttora in corsa, sarebbe forse più comprensibile analizzandola come si analizzerebbe una situazione climatica: volatile, variabile, soggetta a forze invisibili al di fuori del controllo diretto di chiunque». Un libro di questo tipo, che si vuole cioè fotografia di una scena fatta di molteplici scene, nasce con la condanna a invecchiare presto o comunque a necessitare presto delle aggiunte e un aggiornamento a posteriori sulle tendenze descritte? È possibile, ma è ragionevolmente certo che il primo a sperare che sia così è l’autore stesso.
Chinen parla infatti «allineamenti contingenti dai contorni confusi», o «permutazioni illimitate senza parametri fissi»: è di fronte a constatazioni del genere che si capisce quanto l’atto di abbracciare il molteplice mondo del jazz significhi, forse oggi più che mai, assecondare e rafforzare la sua capacità d’insegnarci ad aprirci ad allineamenti contingenti e permutazioni illimitate nella nostra quotidianità, nel nostro modo di vedere il mondo e le relazioni attraverso le quali lo abitiamo e lo influenziamo. Il jazz, che da questo punto di vista ha forse più assi nella manica che altri generi e arti, si presenta allora come approccio etico e come forma di critica sociale che va ben al di là dei nostri gusti musicali.
Alan Lomax, Mister Jelly Roll. Vita, fortune e disavventure di Jelly Roll Morton, creolo di New Orleans, «Inventore del Jazz», a cura di Claudio Sessa, Quodlibet, Macerata, 2019, 368 pp. 25,00€
Nate Chinen, La musica del cambiamento. Jazz per il nuovo millennio, il Saggiatore, Milano 2019, 312 pp. 32,00€