Storie della farfalla (1992; 2019) seconda installazione della “Prostitution Trilogy” tra Whores for Gloria (1991) e The Royal Family (2000), è uno dei testi più emblematici della prima produzione di William T. Vollmann. Già pubblicato nel 2001 da Fanucci come Storie di farfalle e con una copertina deliziosamente pornografica, minimum fax lo ripropone con una nuova traduzione di Cristiana Mennella e una veste grafica ahimè un po’ più delicata. Romanzo semi-autobiografico, in cui la vita dell’autore e la forma del reportage vengono pervertiti e resi insieme grotteschi ed eloquentemente simbolici, Storie della farfalla non ha nulla delle complesse mitologie metatestuali che caratterizzano per esempio i coevi (e sempre pubblicati da minimum fax) La camicia di ghiaccio (1990) o I fucili (1994); e si apprezza dunque ancora di più l’accortezza della scelta operata dall’editore nel selezionare i titoli da proporre al pubblico italiano, che riescono a essere rappresentativi della sfaccettata produzione di un autore così prolifico.
La trama di Storie della farfalla, se confrontata anche solo con gli altri titoli pubblicati da minimum, è significativamente semplice e lineare, e ruota intorno a un protagonista innominato, un giornalista, e all’amore unilaterale che prova per diverse prostitute del Sud Est asiatico, in particolare una cambogiana di nome Vanna. Dopo due capitoli introduttivi dedicati alla sua infanzia e alla sua adolescenza, le storie di questo libro (perché l’andamento del romanzo, come spesso in Vollmann, è quantomeno aneddotico) sono dedicate alla permanenza del giornalista a Bangkok e in Cambogia con un fotografo (sempre senza nome, ma il personaggio è modellato su Ken Miller), al sesso non protetto che entrambi consumano con prostitute locali, e al progredire dell’innamoramento del giornalista per alcune di esse. Dopo il suo ritorno in America, il giornalista non riesce a riconciliarsi con la moglie e con la sua vita quotidiana, e cerca di alleviare le pene di un matrimonio che sente sempre più intollerabile in incontri insoddisfacenti con prostitute americane, in fantasie di infedeltà, e in tentativi vani di portare Vanna negli Stati Uniti. Infine, avendo scoperto di avere contratto l’AIDS, rientra in Cambogia per cercare di riunirsi a Vanna; nell’ultima scena del romanzo, lo vediamo dirigersi verso il confine tra Cambogia e Tailandia, incontro, verosimilmente, a una fine cruenta.
Benché effettivamente il romanzo si apra con scene dell’infanzia del protagonista, si entra nel vivo del racconto solo con il terzo capitolo, che si apre con l’incipit strepitosamente grottesco: «C’erano una volta un giornalista e un fotografo che partirono per l’Asia per andare a puttane. Il viaggio riuscirono a farselo pagare da una rivista di New York» (p. 57). E tuttavia, le prime due parti, con la loro insistenza sull’inadeguatezza del protagonista e sul suo bisogno disperato di amore, e soprattutto di un amore impossibile, non sono casuali, perché segnalano che, prima di essere un romanzo sulla prostituzione, Storie della farfalla è proprio un romanzo sull’amore – o meglio, su «quell’onestissima forma di amore chiamata prostituzione» (p. 11). La traduzione del titolo è abbastanza curiosa, perché personalmente avrei reso Butterfly Stories con Storie di farfalle, visto e considerato che le farfalle in questione sono proprio le prostitute di cui si innamora il giornalista (e il giornalista stesso da ragazzo è chiamato “bambino farfalla”); il termine, peraltro, compare spesso nella versione originare nell’espressione “butterfly someone” (sia sulla bocca del giornalista che delle sue accompagnatrici, intesa come il rifiuto della prostituta o del cliente di intraprendere una semi-relazione a pagamento, dileguandosi invece subito dopo il coito). In altre parole, le farfalle (uomini e donne, clienti e sex worker) abbondano in questo libro; mentre mi sembra di intuire che, traducendo al singolare in Storie della farfalla, Cristiana Mennella voglia sottoporre al lettore un gioco di parole abbastanza greve, e che trova scarsa eco all’interno del testo. Del resto, siamo onesti, si tratta di un’increspatura minima, per quanto in bella vista, nell’eccellente lavoro di traduzione di Mennella.
Una cosa che tuttavia si perde rendendo così il titolo (ma che, a onore del vero, si sarebbe persa in ogni traduzione italiana) è il richiamo alla Madama Butterfly di Puccini, di cui il testo, pur non riprendendola mai esplicitamente, rappresenta una sorta di doppio perverso. L’opera di Puccini, come è noto, racconta la storia della Geisha Chocho-san e del suo amore per il marinaio americano Pinkerton, che la sposa ma riparte per l’America dopo avere concepito un figlio con lei. Quando, tre anni dopo, Pinkerton rientra in Giappone dopo con una nuova moglie, e solo per prelevare il pargolo, Chocho-san, che lo aveva aspettato pazientemente per tutto quel tempo, si toglie la vita. La risonanza con Madama Butterfly, allora, si può interpretare come un’allusione parodica al puro amore disinteressato che il giornalista pare nutrire per le prostitute: come Chocho-san, il giornalista soccombe perché è troppo ingenuo per rendersi conto delle dinamiche che governano il commercio sessuale e che regolano le relazioni a cui si abbandona. Non è un caso, in questo senso, che Madama Butterfly abbia ispirato a David Henry Hwang lo straordinario dramma (poi trasposto in film da David Cronenberg) M. Butterfly, lontanamente ispirato a una storia vera. In M. Butterfly, il protagonista, il diplomatico francese Gallimard, intrattiene per anni una relazione con la cantante d’opera cinese Song Liling, alla quale confida riservatissimi segreti militari, senza rendersi mai conto che la cantante è, in realtà, un uomo. Hwang sfrutta un incredibile e paradossale fatto di cronaca per riflettere sui limiti tossici dell’orientalismo, nella forma dell’idealizzazione di Gallimard per Song Liling, completamente basata su un immaginario stereotipico e coloniale: Song Liling è una cantante lirica, e Gallimard si innamora di lei quando la vede cantare Madama Butterfly, e nelle scene finali del dramma e del film Gallimard tenta il suicidio vestito da geisha, indossando dunque non i panni della cultura cui Song Liling appartiene, ma quelli performativi e teatrali che corrispondono alla sua idea di quella cultura.
Come nel dramma di Hwang, nel romanzo di Vollmann, da un punto squisitamente narrativo, la vittima della storia non è né Vanna né le altre prostitute, bensì il giornalista, che finisce col perdere tutto in nome del proprio “amore” per Vanna; ma questo non significa altro che, come Gallimard, il giornalista è vittima delle proprie stesse visioni coloniali, e che finisce per soccombere a un mondo che non ha la forma delle sue fantasie, e che egli è incapace di interpretare e controllare. La stessa insistenza del romanzo su una connessione tra prostituzione e amore è piuttosto sospetta, dal momento che propone una visione romanticizzata e sentimentalizzata del commercio sessuale che, benché non intrinsecamente disapprovabile, è quantomeno curiosa se riferita a un Paese come la Tailandia in cui, alla fine degli anni Novanta, il numero di sex worker ammontava al mezzo milione, di cui larga parte non aveva scelto liberamente il proprio mestiere, con un numero sempre maggiore di minori coinvolti nell’industria e una spaventosa diffusione dell’AIDS, stimata fino al 24% nelle donne impiegate nei bordelli del Paese.
Perché, in effetti, per quanto il giornalista pretenda di essere innamorato, la verità è che tutte le donne che incontra gli appaiono (e appaiono a noi, perché la focalizzazione del racconto non permette altrimenti) stereotipate, cristallizzate in un’immagine di femminilità docile, entusiasta e passiva, mentre la distanza linguistica tra i personaggi (larghissima parte dei dialoghi del testo è svolta in un inglese improvvisato) impedisce ogni reale contatto. Oy, Joy, Toy a Bangkok, Vanna e Marina e poi di nuovo Vanna in Cambogia sono perfettamente interscambiabili, caratterizzate come sono esclusivamente dalla loro disponibilità a nutrire le fantasie sessuali e romantiche del protagonista – immagini vuote per desideri insaziabili. Similmente, il giornalista non pare mettere mai in relazione la disponibilità delle donne con la violenza che spesso vi sta alla base – prenda questa la forma della disuguaglianza economica locale o internazionale, della guerra del Vietnam che ha dato il via alla vocazione tailandese come meta di turismo sessuale, o degli orrori innominabili dei comunisti cambogiani sulla popolazione indifesa.
Il giornalista viene avvertito spesso di quello che è accaduto e continua ad accadere entro i confini cambogiani («Noi andiamo in Cambogia, disse il giornalista. Vuoi venire? / No. / Perché? / Smorfia di terrore. “Bang, bang”, sussurrò la ragazza», pp. 59-60); e tuttavia, benché durante la sua permanenza in Cambogia sia poi ospitato da capi militari e arrivi ad intervistare il fratello di Pol Pot (cosa che Vollmann ha effettivamente avuto il piacere di fare), non traccia mai una connessione tra la guerra e le circostanze che hanno portato le sue amate a darsi alla prostituzione. Del resto, perché sorprendersi della malafede del protagonista, dal momento che è sempre così pronto a beneficiare dei frutti della violenza coloniale? La sua iniziale riluttanza (un misto di perbenismo e codardia) a sfruttare questo mercato del sesso si tramuta presto in violenza, sia nella forma della malattia che trasmette indiscriminatamente, sia in quella, più immediata, della violenza fisica («Vede, dottore, mi sono scopato una puttana INCREDIBILE di sedici anni senza preservativo; in pratica l’ho dovuta stuprare», p. 131).
Paradossalmente (perché questo romanzo, come tutta la letteratura della falsa coscienza, è zeppo di paradossi), è proprio l’impossibilità di un incontro significativo e di un’unione soddisfacente a fare sì che il giornalista si innamori sempre di prostitute in generale e di prostitute del Sud-Est asiatico in particolare. È proprio, in altre parole, l’assenza di contesto e di conflitto fornita da queste donne perennemente a disposizione e orientalizzate che permette al giornalista di innamorarsene, in contrasto con le relazioni complesse e ponderose che ha invece con donne occidentali (delineate nei due capitoli iniziali e nelle poche scene con la moglie).
La relazione del giornalista con le prostitute è una versione parodica della tradizionale visione occidentale di un amore cortese, in cui l’eroe affronta ogni sorta di prove e umiliazioni per la donna che desidera: «per diventare più saggi degli altri bisogna fare cose anormali» (p. 217). Il giornalista, per esempio, lascia che Vanna lo umili e lo truffi in pubblico, ma, in generale, il suo abbandono del tetto coniugale, lo sperpero di denaro, i dettagli sordidi sulle sue malattie sessualmente trasmissibili («Ancora Benadryl») e infine l’infezione di HIV sono da interpretarsi in questo senso. Perché queste relazioni possano avere luogo, la donna deve essere distante – deve qualificarsi, in altre parole, come assenza di conflitto, di responsabilità, di resistenza. Il risultato di questo percorso non può essere che la morte, e la morte, effettivamente, è quello che il giornalista riceve. «Era stanco, voleva stendersi fra le braccia di Vanna e dormire per sempre» (p. 130), ci viene detto nella prima metà del romanzo; e il libro si chiude con il giornalista che si avvia verso il confine pattugliato dalle guardie Khmer, che gli urlano contro. «Presto avrebbe dormito per sempre al suo fianco» (p. 315).
In Storie della farfalla la focalizzazione è perennemente sul giornalista, e dunque i personaggi delle prostitute non possono apparire che strumenti di un desiderio distorto e narcisista. Tuttavia, sia la tragica fine del romanzo che i numerosi attacchi dell’autore contro il protagonista indicano che questo punto di vista è, in una certa misura, da criticare; allo stesso tempo, però, non si ha né un punto di vista differente, né alcuna critica esplicita di questa narrativa. Una simile ambiguità strutturale si può rinvenire nelle opinioni personali di Vollmann sulla prostituzione. Vollmann ha scritto in numerose occasioni in favore della prostituzione come professione rispettabile, e la sua ossessione per la figura della prostituta appare piuttosto evidente attraverso tutto il suo lavoro. Vale la pena di notare, peraltro, che tra il protagonista e Vollmann c’è più di un punto di contatto biografico, visto che entrambi vanno in giro per Tailandia e Cambogia come giornalisti e intervistano i capi militari – e visto che le illustrazioni del testo, in effetti, ritraggono Vollmann stesso, coi suoi inconfondibili occhiali.
Nella sua aneddotica e spesso sardonica fenomenologia della prostituzione, Vollmann difende la sua esperienza personale con le prostitute, sostenendo che quello tra cliente e sex worker non è un legame di sfruttamento, e che una prostituta può godere e beneficiare del proprio lavoro. Se una simile idea non è per forza moralmente sbagliata, visto e considerato che, a differenza di molto moralismo in materia, tende a riconoscere una certa agenza a chi pratica la prostituzione, Storie della farfalla mette bene in evidenza i rischi e le conseguenze di una simile posizione, se applicata indiscriminatamente. E in effetti, come è stato ampiamente sottolineato, l’idea che Vollmann ha di consenso è piuttosto ampia, e raramente prende in considerazione le circostanze in cui gli scambi effettivamente avvengono; ragion per cui, mentre Vollmann condanna ripetutamente, in maniera implicita ed esplicita, gli abusi, la cecità e la vanità del suo protagonista, questa visione romanticizzata della prostituzione non gli è troppo distante.
Storie della farfalla, del resto, è un libro profondamente ambiguo, che, con venticinque anni di anticipo sull’era del #metoo, mette in discussione l’omnipervasività del male gaze e il senso di entitlement degli occidentali, e che, allo stesso tempo, condivide alcune delle più spericolate convinzioni del suo protagonista. Ancora, per quanto paradossale (ma potrebbe essere diversamente?), Storie della farfalla è un grande libro sull’amore: su come cecità e auto-inganno siano parti integranti e necessarie all’innamoramento, e su come possano coesistere nello stesso istante purezza e impostura. In questo senso, Vollmann riesce nella non facile impresa di riuscire a fare empatizzare il lettore, se non con la sua strana fame, perlomeno con la criminale stupidità del suo protagonista, perché è quella (come accade del resto per una certa Emma) che non possiamo non rivedere in noi. Se Storie della farfalla difficilmente si può considerare il migliore risultato di Vollmann (ma più per l’eccellenza di altri suoi lavori che per la scarsa qualità di questo), è senz’altro uno dei testi più adatti a comprendere le contraddizioni profonde del lavoro del suo autore, e la problematicità dei suoi temi prediletti.
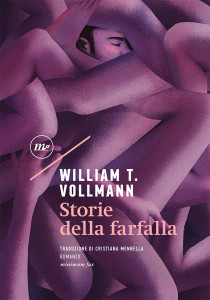
William T. Vollmann, Storie della farfalla, Minimum fax, Milano 2019 310 pp. 18,00 €