Proseguiamo la presentazione dei libri finalisti del Premio Narrativa Bergamo 2020. Gli incontri con gli autori, in ragione delle recenti ordinanze ministeriali, sono stati spostati alla fine di settembre (come potete leggere qui).
Ci sono artisti-anfibi che vanno incontro al proprio destino adottando da subito un’andatura obliqua, dividendosi cioè tra due vocazioni, chi invece trova davvero se stesso solo attraverso una mutazione: Marco Colapietro appartiene senza dubbio al secondo gruppo. Svestiti i panni dell’artista, ha trovato la sua versione più vera nel 1999, anno di nascita del suo alter ego: Tommaso Pincio, scrittore. L’identità autoriale di Pincio è stata, fin da subito, ancipite: onomasticamente diviso tra l’America e Roma, letterariamente Pincio si è mostrato aperto alle diverse sollecitazioni d’una cultura pervasa dal pictorial turn, pur non trascurando di costruire una voce narrativa dalla lingua duttile, stratificata, riconoscibile eppure diversa di libro in libro.
Forte della visione processuale dell’atto artistico ereditata dai suoi trascorsi in Accademia, Pincio non si è mai tirato indietro di fronte alla possibilità di sperimentare generi apparentemente inconciliabili: dal fototesto (Lo spazio sfinito) alla visione distopica (Cinacittà), dal memoir letterario (Hotel a zero stelle) agli scritti sulla pittura (Scrissi d’arte). Ma è Il dono di saper vivere (Einaudi, 2018, tra i finalisti del Premio Bergamo), l’ultimo libro pubblicato, l’impresa più ambiziosa tentata sin qui: come catturare in un’infilata di ritratti, veri e falsi al tempo stesso, l’imprendibile nucleo di chi per secoli è stato l’emblema dell’artista puro, ovvero Caravaggio? Pincio tributa un omaggio al “Gran Balordo” — questo l’appellativo che gli viene riservato nel Dono — a suo modo, scrivendo un libro che ne contiene tanti, forse troppi.
Libro sulla vita e sul mito di Caravaggio, autobiografia, metaromanzo: Il dono di saper vivere è allo stesso tempo tutto questo, non sempre riuscendo però a trovare un equilibrio convincente tra le sue componenti. Come in altri casi – basti pensare alle pagine di Gadda, pervase di luci ed ecfrasi caravaggesche –, la “funzione-Caravaggio” viene avvicinata secondo quella che Jean Starobinski aveva definito «intuizione identificante»: guardando cioè alla vita e alle opere del pittore per mettersi in scena, parlar di sé sotto mentite spoglie. È quello che succede nella prima parte del romanzo, dove un giovane ex gallerista di belle speranze parla agli «odiati muri» di un carcere aspettando la visita d’un lugubre avvocato che dovrebbe difenderlo dall’accusa di un omicidio che non ha nemmeno commesso.
Settanta pagine riuscite, che in una voce sulfurea ci presentano una porzione finora sommersa della vita dell’autore: gli esordi nella galleria di Gian Enzo Sperone, situata in Via di Pallacorda, proprio dove Caravaggio si macchiò dell’omicidio di Ranuccio Tomassoni. Il giovane Pincio scopre presto di non saper vendere i dipinti: gli manca «il dono di saper vivere», come scrisse Berenson a proposito di Caravaggio stesso. E al pittore, ai numerosi aneddoti di cui si ammantano i suoi luoghi (a pochi passi da Via di Pallacorda si trova Via dei Coronari, dove Merisi abitò per qualche tempo) l’aspirante gallerista farà riferimento per imbonire le star che raramente si affacciano in quelle stanze vuote. Ma l’arte del vampirismo inoculatagli dall’Inestinto — soprannome del fascinoso, soggiogante Sperone — non sarà mai davvero cosa sua, e a rivelarglielo una volta per tutte sarà naturalmente la superficie d’un quadro:
“Et in Arcadia Ego”, dice, scherzoso a sé stesso, il giovane mentre al puro scopo di ingannare il tempo, il suo tempo, osserva senza rapimento un dipinto appeso alla parete di fronte, un David con la testa appena mozzata di Golia, opera di Giuseppe Cesari, detto il Cavalier D’Arpino. [Fig. 1]
Ben altra impressione gli farà ammirare lo stesso soggetto, ma dipinto per mano di Merisi:
E nel ricordo sono uno giovane e uno no, uno vivo e uno no. Uno, il volto di Davide, osserva l’altro, il volto di Golia. L’altro, che non è più un viso in senso stretto ma una natura morta, una testa mozzata da poco, osserva senza vederlo il vuoto davanti a sé. Con la mano sinistra, Davide tiene sollevata per i capelli la testa di Golia e in questo gesto, nell’espressione compassionevole che dedica a quanto resta del nemico appena sconfitto, fa sembrare l’uccisore e il suo macabro trofeo un’unica entità, come se quel Davide e quel Golia non fossero due anime, ma soltanto due momenti distinti e lontani di una stessa persona, tornati tristemente a congiungersi, una storta di bivio al contrario, una y capovolta. Era questa comunione a turbarmi e che la mia età non mi consentiva di comprendere a pieno.

Il carcerato vede con chiarezza chi è solo riflettendosi nei dipinti di quest’ultimo, quasi sempre ritratti di sconfitti, come il Bacchino malato cui, impietosi, lo avevano paragonato i compagni del liceo. È solo la prima d’una serie di riferimenti figurativi volti a farci comprendere il suo temperamento: o saper vivere o saper scrivere, e, conscio delle sue mancanze, Melanconia — questo il soprannome del giovane venditore manqué— inizia a mettere in cantiere un libro su Caravaggio, non riuscendo però a portarlo a termine. A questo punto la narrazione bruscamente s’interrompe dando inizio alla seconda parte del romanzo, la più debole: complice l’assenza di uno specchio trasfigurante, la voce narrante (non più il carcerato, ma Pincio stesso nell’atto di scrivere il suo libro caravaggesco) si fa onnipresente, perde tenuta infilandosi in attardati sperimentalismi d’avanguardia.
La vivacità del racconto riemerge nella terza ed ultima parte, in cui la voce narrante ritrova forza inanellando diversi fili sulla vita e fortuna di Caravaggio. Come nei ritratti di Warhol, le cui citazioni dai Diari costituiscono un altro fil rouge che lega i cinque percorsi annodati da Pincio, l’immagine del pittore si moltiplica in versioni contrastanti: c’è l’omicida poco atto al disegno preparatorio detestato dai biografi seicenteschi; c’è il Caravaggio cinematografico di Longhi, che diviene parte dell’identità artistica nazionale in seguito al boom della mostra sui Caravaggeschi curata dal critico nel ’51; c’è l’effigie, contraddittoria e infingarda, che rimbalza sui pezzi da centomila lire sostituendosi al Manzoni; c’è la sua vita infarcita d’errori nel numero Maestri del Colore ritrovato per caso in un cassonetto (e gettato di nuovo tra i débris dei nostri feed: «Ho estratto il telefono dalla tasca e mi sono piegato sulle ginocchia cercando l’angolazione migliore, dopodiché ho scattato»).
È stato scritto che Il dono di saper vivere è un libro sul rapporto tra arte e denaro, ed è senz’altro così, altrimenti il suo autore non avrebbe dirottato la sua scelta su un artista la cui vulgata si è fatta sempre più smaccatamente pop (basti pensare alla nemesi delle “Esperienze con Caravaggio”, dove dettagli dei dipinti del maestro ingigantiscono in una sala 3D, in un incubo alla Dalì formato PowerPoint). Ma più che per il già ampiamente esplorato rapporto arte-merce e l’operazione metanarrativa ad esso connessa – a differenza di quanto racconta, il libro è stato finito, svela in copertina il biglietto da centomila con Caravaggio, ha un suo prezzo di vendita –, nel Dono colpiscono le riflessioni sul talento, su cosa sia necessario per farlo fruttare:
Chi mai scommetterebbe un centesimo su di lui? Nessuno punterebbe su un suo riscatto, anche solo momentaneo o fortuito; nessuno crederebbe che in lui covi un destino, che possa diventare tre cose in una: un usurpatore d’anime, un omicida, un genio della pittura (l’ordine non è rilevante). Io per primo non ci crederei e men che mai punterei su di lui, non fosse che quel giovane ero io e quel suo tempo il mio.
L’arte è diventata merce, sì, o lo è sempre stata, ma se c’è qualcosa che sfuggirà sempre ad ogni tentativo di sbrigativo storytelling da post è la capacità individuale di ogni artista di metter becco nella propria vita, di dargli una forma che gli calzi a pennello (il ritratto e il vestito, questi i topoi del Dono e di altri romanzi di Pincio). È una partita che Caravaggio vince sfuggendo al carattere negromantico proprio d’ogni classicismo, ovvero calando in presa diretta la vita nella propria arte:
Se da un lato i ruderi ispiravano voglie e sentimenti di grandezza, dall’altro erano il promemoria costante del fatto che quella grandezza non esisteva più e si poteva soltanto provare ad emularla, a riviverla in forma di simulacro freddo e lontano dal presente, da una realtà ormai sintonizzata su altre lunghezze d’onda. La pittura di Caravaggio era appunto antitetica a questo. Era antimalinconica perché indifferente ai ruderi, perché era affondata nel presente e al marmo delle statue preferiva la carne della moltitudine degli huomini.
Il Dono è un’involontaria elegia al dono di sapersi disperdere, tentando tutte le strade, perdendo tempo e non perdendo un minuto di tempo: convince pienamente nei momenti in cui, lasciato da parte l’ammicco postmoderno, smette di arroccarsi in forme difensive per aprirsi all’alterità. Quel che manca, forse, è la capacità di tradurre il moto centrifugo che anima la vita di chiunque scriva (o dipinga) in una forma più aperta all’imprevisto; Pincio costruisce un labirinto a più livelli, ma non sempre riesce ad uscirne, ed è un peccato.
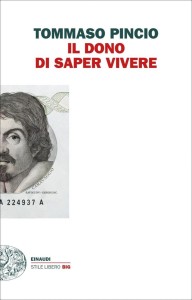 Tommaso Pincio, Il dono di saper vivere, Einaudi Stile Libero, Torino 2018, 200 pp. 17,50€
Tommaso Pincio, Il dono di saper vivere, Einaudi Stile Libero, Torino 2018, 200 pp. 17,50€