«Livio voleva dirle che i grandi avevano equivocato, che un tempo il lavoro era servito per farle, le famiglie, e non per metterle alla prova. Ma poi avrebbe dovuto anche spiegarle, con parole semplici, che nel primo articolo della Costituzione il lavoro era stato anteposto allo stesso uomo che avrebbe dovuto beneficiarne» (p. 123)
Nella Brianza profonda dei luoghi dimenticati, delle piccole e grandi fabbriche
abbandonate al libero arbitrio di chi le controlla e del lavoro che immiserisce
l’uomo lavora e vive Livio Belotti, verniciatore neo-disoccupato e protagonista
del romanzo Poliestere (Fandango Libri, 2020). La crisi del famigerato 2008
non risparmia nemmeno la sua relazione, che si trova sull’orlo della fine. Livio
difatti viene lasciato e cacciato di casa dalla sua compagna Lidia, madre di
Martina, avuta però con un altro uomo che è scappato come se, anziché aver
messo al mondo un individuo, ne avesse uccisi dieci (p. 7). Livio non smetterà
mai di frequentare la bambina per tutta la storia, è legato a lei da un sentimento
più che paterno, ed è come se si fosse impegnato a mantenerla pura ed estranea
alle spietate dinamiche del mondo adulto, tanto che la parola ‘lavoro’ è proibita
nelle loro conversazioni.
Esule, senza una famiglia a cui far riferimento, Livio, ciondolando in piena
disoccupazione, rincontra Elia, storico compagno di liceo e di ragazzate, degli
anni in cui ancora sognava di diventare un pittore. Costui è diventato un pezzo
grosso del settore del mobile grazie a un buon matrimonio e senza esitazioni lo
introduce nella propria azienda, teatro principale del racconto, dove ha già preso
con sé e posto in una buona posizione di supervisore Danilo, ultimo angolo del
terzetto giovanile.
Il suo nuovo datore di lavoro accompagna il protagonista alla sua postazione. Si
tratta di una piccola capanna condivisa con un altro verniciatore prossimo alla
pensione, Tito, fatiscente e di un’indecente pericolosità, così come il resto del
luogo. Abita nella fabbrica un freddo secco e polveroso, un’umida sensazione di
malessere condiviso e taciuto per timore di non trovare un altro salario. I ritmi
di lavoro sono mortificanti ed estenuanti, di una stanchezza che non lascia
riposare la notte. Elia e Danilo continuano da tempo a promettere un
miglioramento delle condizioni generali, a quanto pare basta un ultimo sforzo
per concludere un importante accordo, che dovrebbe portare, insieme alle altre
cose, più tranquillità ai ritmi estenuanti. La fabbrica, però, avrà da qui vita
breve, e lascerà gli impiegati a casa per un certo periodo, a causa dei severi
controlli innescati da un incidente sul lavoro. L’imprenditore, con le mani legate
(e la fabbrica chiusa), tenta comunque di concludere quell’affare con una truffa,
con conseguenze disastrose. Dopo le ultime peripezie, Livio, stanco del mondo
degli adulti, si licenzia e si rifugia in quello di Martina, fatto di giocattoli di
plastica, domande infinite e mai soffocate, un luogo in cui il denso fumo delle
macchine non opprime gli abitanti. Livio riesce in un’impresa ancora più ardua
del colpaccio progettato da Elia: sopravvive, felice, disoccupato, in una società
che non solo da giovane gli ha negato il suo sogno, la pittura, ma che negli
ultimi tempi lo ha anche abituato a pensare di non poter vivere senza un lavoro.
Ma quando comunicò a tutti che non avrebbe firmato il rinnovo del contratto, restandosene a casa, la reazione dei colleghi fu di silenziosa indignazione. Era come se avesse infranto il peggiore dei tabù. […] In tempi di vacche magre nessuno tollerava i disoccupati volontari. In quei giorni un tizio era rimasto senza lavoro si era dato fuoco davanti a un centro per l’impiego di Viterbo, lasciando una macchia scura sui sanpietrini. Livio come riusciva a sentirsi la coscienza a posto quando gli altri si suicidivano per aver perso quello che lui invece stava ripudiando? (p. 211).
In un punto nevralgico come questo, però, l’autore riesce a non schierarsi
eticamente, è come se non gli importasse davvero dare un giudizio morale sulla
faccenda, pur avendo condiviso lo stesso mestiere del protagonista del libro. Si
propone in modo molto semplice di mostrare un evento raro in un contesto
comune: la ribellione sommessa e non conclamata. È estremamente puntuale in
questo caso la scelta di cambiare punto di vista della narrazione per queste
poche battute. Il fatto è raccontato seguendo la reazione degli ex-colleghi, non
quelle del protagonista che invece si limita a compiere azioni. Questi uomini
sono accomunati dallo stesso atteggiamento prono verso il sistema e si
accontentano della loro condizione, senza arrivare mai ad essere davvero felici,
e, pur volendo andarsene allo stesso modo, adesso, spiazzati dalla sincerità del
suo gesto, biasimano la scelta del protagonista. Livio, invece, rompe questo
meccanismo opprimente, rinunciando al lavoro di cui tanto aveva bisogno e per
cui ha sofferto. Egli sa di non appartenere allo scolorito stile di vita degli
abitanti della fabbrica e non rinuncia al suo desiderio di trovare un’alternativa.
Necessaria per la svolta nell’animo del personaggio è la figlia adottiva. Martina
gioca un ruolo fondamentale in questo processo poiché, ingenuamente, mette
spalle al muro l’uomo che tanto ammira, nel momento in cui lo obbliga a
escludere dalle loro conversazioni ogni cosa che abbia come oggetto il lavoro.
La bimba, coi suoi modi, avvicina agli occhi dell’adulto l’interrogativo sulla
sulla contentezza, parola che in origine aveva proprio a che vedere col sentirsi
completi e appagati.
Il vero finale del romanzo, forse inespresso e in qualche modo impossibile da
scrivere, affonda le proprie radici sul senso quasi esistenzialista del lavoro,
ovvero la difficoltà di una convergenza tra il proprio mestiere e la realizzazione
più vera di sé, possibile esclusivamente tramite condizioni che valorizzino
l’essere umano, non che lo riducano a macchina servile di una società. I soprusi
dei potenti, capiamo, non risparmiano nessuno: né amici né parenti. È proprio la
conclusione del romanzo a far luce sulla difficoltà di adattarsi al proprio tempo,
di cercare nel rosso cremisi del magma della realtà la propria dimensione, senza
rinunciare a un sostentamento.
Con una scrittura lineare e clinica, Luca Bertolotti ci porta nel disperato
microcosmo di una categoria dimenticata: gli operai sottomessi, sottopagati, del
sottosuolo. Riesce ad evocare ogni singola sfumatura dei rischi a cui
quotidianamente i lavoratori di una fabbrica incorrono. È una lente
d’ingrandimento che può essere utilizzata solo da chi è stato dell’ambiente e che
riesce ad essere scevro da ogni giudizio, perché, nonostante le palesi ingiustizie,
tiene conto della difficoltà di trovare un posto di lavoro migliore. Nessuno se
non un abitante di questi luoghi potrebbe parlare con tanta precisione dei sensi,
interiori ed esteriori, dei dipendenti:
C’era il lamento della squadratrice nel momento in cui il pezzo si inceppava, perché chi stava tagliando era in debito di ossigeno e la sua mano da qualche giorno tremava. C’erano i botti dei pannelli di Mdf che venivano buttati sulla sezionatrice, senza che le braccia li accompagnassero più. […] Ci si faceva trascinare anche troppo dal mestiere e dalla malizia, ma pure dalle borsiti, dalle tendiniti, dall’ernie al disco. C’era nell’aria il profumo del tannino: lo stesso dei vini buoni. Ma ciò voleva dire che il rovere tagliato si scaldava perché le lame non venivano affilate da troppo tempo. E le lame che non tagliavano bene erano quelle che costringevano a fare forza, che diventavano pericolose. Era una sinfonia di possibili infortuni (p. 108).
Siamo in una zona di confine tra giusto e sbagliato, in cui ribellarsi non è
permesso perché si ha una famiglia, un tetto da procurare e procurarsi. Ogni
sofferenza, quasi fisiologicamente, si trasforma in speranza per un futuro più
roseo.
A quale costo, dunque, ci chiede implicitamente Bertolotti, si può dar voce alla
velleitaria ambizione di volersi riscattare sapendo di poter rischiare tutto? E in
che modo, inoltre, la propria identità si costruisce sul proprio impiego?
Che fine fa quell’uomo che non ha realizzato il proprio sogno, che è stato
educato alla passiva idea di doversi impegnare necessariamente in un mestiere
utile, quando si allontana da questi principi?
Forse Livio davvero è in una società segreta che si batte per non lavorare più
(p.18), perché nel momento in cui chiudiamo l’ultima pagina del libro non
possiamo fare altro, come lui, che ripensarci in toto, provare a ripartire dalle
macerie dell’edificio di noi stessi che abbiamo smantellato, cominciando dai
valori imposti e dogmatici che sempre ci propongono, che l’autore con la sua
scrittura chirurgica, tutta reale, e il sorriso di un bambino (o meglio, di una
bambina) mette in discussione, lasciando a noi le ultime conclusioni.
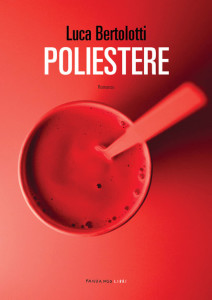 Luca Bertolotti, Poliestere
Luca Bertolotti, Poliestere
Fandango Libri 2020
216 pp., 16€