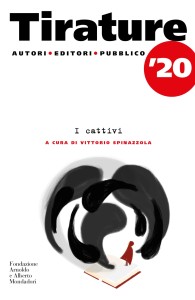[Pubblichiamo oggi uno dei contributi di Tirature ’20, I cattivi, l’ultimo curato interamente da Vittorio Spinazzola, ideatore dell’annuario all’inizio degli anni Novanta. L’intero numero della rivista, a lui dedicato, è scaricabile gratuitamente dal sito della Fondazione Mondadori. Ringraziamo l’autore, i curatori e l’editore per la disponibilità a riprodurre questo contributo]
Forse non è un buon segno se il pubblico si appassiona a un genere che dell’altro, del diverso, delle apocalissi casalinghe fa il suo idolo polemico, e mette in dominante un «paradigma vittimario». Però è possibile che nelle maglie del dispositivo distopico si infiltri qualcosa di differente. Curiosamente, ciò avviene in ambiti diametralmente opposti del nostro sistema letterario.
“Tutti i predicatori dell’apocalisse mi danno fastidio, perché mi sembra che il loro sia un modo per mettersi a posto la coscienza”.
Vittorio Spinazzola, da un’intervista del 2010
Dovremmo prendere molto sul serio il successo delle narrazioni distopiche che impazzano da qualche anno a questa parte. Da Westworld a Black Mirror, dai romanzi di Atwood a quelli di Houellebecq, da Matrix a Hunger Games, passando attraverso quasi ogni declinazione, letteraria, fumettistica o audiovisiva che sia, è fin troppo evidente che immaginare futuri catastrofici è uno dei piaceri preferiti da spettatori e lettori global. L’onda distopica ha dilagato anche in Italia, benché non siano emerse opere di grandissimo successo, tali da determinare il caso letterario. Romanzi di qualità invece sì: per esempio La galassia dei dementi di Ermanno Cavazzoni (La nave di Teseo, 2018) o il godibilissimo Un attimo prima di Fabio Deotto (Einaudi, 2017), per non dire dell’ormai lontano e quasi dimenticato Dai cancelli d’acciaio di Gabriele Frasca (Sossella, 2011) che a mio avviso dovrebbe essere considerato un capolavoro. E che autori cosiddetti di ricerca come Tommaso Ottonieri (Le strade che portano al Fùcino, Le Lettere, 2007) e Gherardo Bortolotti (Quando arrivarono gli alieni, Benway Series, 2016) si siano misurati con ottimi risultati con questo particolarissimo pattern, la dice lunga sulla vitalità del genere, appunto in Italia. E siamo qui a chiederci, del resto, che cosa sarà di Anna di Niccolò Ammaniti (Einaudi, 2015), trasformato nella serie tv in programma su Sky tra fine 2020 e inizio 2021.
Dovremmo prendere molto sul serio la distopia, appunto. Anche perché la moda che l’accompagna un po’ ci inquieta. Scorgiamo sullo sfondo questioni poco rassicuranti. Tutto sommato, per vederci chiaro, è sufficiente citare l’incipit del romanzo di Giacomo Papi, Il censimento dei radical chic (Feltrinelli, 2019, in libreria a gennaio). E cioè: «Il primo lo ammazzarono a bastonate perché aveva citato Spinoza durante un talk show». Proviamo a ragionare sul cortocircuito (scusate i tecnicismi) anaforico e cataforico che viene messo in campo, cioè sulla possibilità che la frase da un lato si colleghi al titolo e dall’altro anticipi i contenuti del romanzo. Dunque: il lettore è subito informato circa il fatto che un intellettuale cosiddetto radical chic verrà ucciso per aver richiamato contenuti culturali troppo difficili parlando nel luogo dell’anticultura quasi per definizione, cioè la tv; e che la sua morte sarà l’inizio di una strage sistematica.
La lettura letteraria è ideologia, com’è noto, e i bianchi che riempiamo mentre procediamo nella nostra esperienza immaginativa sono segnati da presupposizioni, idee ricevute, schemi mentali codificati. Oggi, a ben vedere, ci divertiamo a soffrire perché qualcuno ritiene colpevole l’eccesso di attività intellettuale; ma, ovviamente, non perché davvero condividiamo questa opinione: esattamente all’opposto, perché pensiamo che là fuori, in un universo degradato fatto di incultura e di barbarie, c’è qualcuno che la pensa così. Una specie di doppio legame: è bello indignarsi per un futuro negativo in cui ci verrà tolto ciò che maggiormente pregiamo e amiamo. E a togliercelo sarà un nemico estraneo a noi, un male coincidente – di fatto – con gli aspetti più popolari di quello che un tempo era detto sistema dei media. Il nemico è lì, in televisione o nei social, pronto a vendicarsi dei pericolosi intellettuali annidati dietro le loro cattedre, nei loro eleganti uffici tappezzati di libri, nelle redazioni degli editori e dei giornali che contano.
Non si tratta di buttarla sul politico – o si tratta proprio di questo, ma con un minimo di discrezione e di understatement. La paranoia di questo modello conoscitivo è quasi perfettamente omologa a quella dell’avversario – per così dire –, di chi agita ogni giorno il fantasma di un’invasione avvenire a opera di un “diverso”, caratterizzato da precise peculiarità di pelle, religione, credenze, abitudini ecc. Nel caso delle relazioni intellettuali, è in gioco, poi, e in maniera esemplare, quel «paradigma vittimario» di cui qualche tempo fa Daniele Giglioli (Critica della vittima, nottetempo, 2014) parlò con lodevole lucidità, e su cui oggi ci ammonisce anche Valentina Pisanty nel suo I guardiani della memoria e il ritorno delle destre xenofobe (Bompiani, 2020). Niente di meglio che immolarsi a vittima per mettere in stallo ogni vero ragionamento, ogni possibile crescita intellettuale e politica, ogni tipo di prassi. A chi giovi una simile impasse è abbastanza chiaro, se è vero che la retorica della vittima produce una visione miope del mondo. Resta il fatto che il meccanismo piace, produce consenso, vende. La sua capacità di semplificare, di eccitare compiacimento, di colludere con le nostre paure proiettandole in maniera consolatoria fuori di noi definisce un dispositivo perfettamente funzionante, che attira sia l’intellettuale supercilioso sia il lettore e la lettrice di bocca buona.
Il rischio, come si vede, è di cadere nella trappola del sistema che si vorrebbe denunciare. Insomma, di usare male (distopicamente?) il genere o modello distopico, accettando gli ultimatum che ci propone. Dovremmo dunque rifiutare in toto un intero genere letterario? E se, invece, dentro questo dominio di opere stessero crescendo degli anticorpi? Cioè: la visione del mondo catastrofistica potrebbe rivelarsi uno strumento, anche formale, per dire altro, in modo – si perdoni la parola logora – autentico? Per rispondere, propongo un esperimento: ossia prendere due libri in senso lato distopici, ma a dir poco diversi, entrambi pubblicati nel 2019, e verso la fine dell’anno. Da un lato c’è il vincitore del premio Urania 2018, Le ombre di Morjegrad, di Francesca Cavallero, uscito come n. 1672 della collana Urania nel novembre 2019; e dall’altro Un paese di soli guardiani, di Marco Villa, un volumetto di poesia edito da Amos Edizioni di Vicenza nell’autunno dello stesso anno, per la collana A27 poesia.
Niente di più lontano di una brossura da edicola che pratica in maniera ligia tutte le forme del genere fantascientifico, ivi comprese le sequenze di inseguimento e di battaglia, molto più efficaci su uno schermo cinematografico, e di un elegantemente sobrio libriccino di versi e prose “liriche”, che in fondo deve la sua ascrizione al genere soprattutto alla quarta di copertina, ove si legge che il testo «capovolge la distopia in utopia». Tra l’altro, se la scrittura di Cavallero presenta falle stilistiche evidenti (ma che fine ha fatto il buon vecchio editing?), quella di Marco Villa brilla per tour de force sintattici al limite del virtuosismo. Eppure.
Eppure, in entrambi i casi il paradigma distopico mette in gioco qualcosa di prezioso. Diciamo qualcosa di dissonante, fuori squadra, pur nei limiti di convenzioni che in entrambi i casi vengono rispettate. La trentottenne autrice di genere punta sull’eccesso del corpo, sulla crisi di un’identità, significativamente femminile, che passa attraverso la possibilità di ricostruire e programmare l’involucro fisico che ci contiene. Ovviamente, nulla di nuovo, e Wells e Huxley avevano detto a loro tempo quasi tutto sulle distopie chirurgiche e genetiche. Ma qui la tematica organica, l’embodiment del racconto, la cerebralizzazione di una storia che coinvolge un ospite di carne (quello che leggiamo nel romanzo è la scansione dell’attività mentale di un personaggio), implica la dissoluzione carnale di un intero universo cittadino. «Laggiù, verso l’orizzonte a brandelli, è facile scorgere le enfiate colline dove si tumulano scorie e si stoccano anime, perché nulla, a Morjegrad, è più abbondante della carne» (p. 9). Corpi disfatti e riplasmati, mostruosità dolenti che nessuna chirurgia può riscattare, una collettività mutilata che sempre più si disgrega, si liquefà sotto i nostri occhi: è un universo mutante che viene costantemente declinato al femminile. L’umanità distrutta e poi rinata, rimodellata, che cerca di nascondere le proprie ferite, di tenere insieme i pezzi della propria fisicità, è la risultante di un sistema narrativo in cui il maschio può solo svolgere i ruoli o dell’astratto oppressore o della comparsa. Così, uno dei personaggi, Chloe, si salva da «Gente che l’aveva usata come un giocattolo, e prima o poi l’avrebbe gettata via» (p. 151), grazie a un incidente che ne mutila il corpo ma ne comporta anche la ricostruzione fisica e psichica. Ma, attenzione: non si tratta mai di una soluzione definitiva; il mondo in cui si muovono Le ombre [appunto femminili] di Morjegrad permette solo il baluginare di un riscatto. E la killer Michelle va incontro a un calvario lungo il quale recupera la propria identità scandalizzando osservatori (uomini) con una progressiva dis
soluzione: «Tutti mi osservano. Fissano me e i miei pantaloni inzuppati di sangue e neve. / Fissano me che, claudicando come una bambola rotta, mi avvicino» (p. 205).
Come spesso succede nei racconti in prima persona al presente, le opposte azioni di vedere ed essere visti possono confondersi; e non c’è niente come l’io che (si) narra per produrre effetti di straniamento. Nel libretto del trentunenne Marco Villa, com’era prevedibile, si racconta poco, e anzi direi che in questo testo così curiosamente e originalmente prosimetrico si distillano con grande intelligenza molte delle possibilità che il genere lirico, oggi, offre a chi vuol fare poesia. Quello che colpisce è la scioltezza con cui io/tu/noi si alternano come modalità enunciative; e quanto spesso sia possibile che una terza persona focalizzante costituisca il centro prospettico del narrare. Un incipit è in questo senso degno di nota: «Niente turba il discernimento, niente svia l’azione più di Marco Villa. Questo bambino fatuo e inesauribile» (p. 55). Tra l’altro, specificità forte di questo poeta è saper costruire partiture ragionative e quasi saggistiche: vi si parla di serie televisive, per esempio, o dell’abilità di rilasciare la palla di un campione Nba come Steph Curry. L’immaginario di Villa è ben radicato nel presente, e il suo sguardo osserva le molte derive fantasmatiche del reale, la decomposizione mentale delle cose e delle persone. Compito – immane – del soggetto è la costruzione o forse più esattamente ricostruzione del mondo; ma, come abbiamo intuito, si tratterà di un soggetto al quadrato, una sorta di mutante: «un soggetto particolarmente forte […]. Un uomo in seconda battuta, per cui il piacere è legge ammutinata e che nel nulla non può permettersi il lusso di vedere alcuna perfezione. / Un uomo che deve costruire un mondo solo per provare a se stesso di non essere un fantasma». Perché sono gli altri a vederti, a sapere quello che sei – un assassino. «Bisogna considerare tutto; forse chi hai di fronte ti ama. D’altra parte, sono occhi che scopriranno un assassino» (p. 16).
Verrebbe da dire che la vera distopia attiva nella poesia di Marco Villa è l’irrealtà del reale, di cui l’umanità, il soggetto che si dice Marco Villa, non può che essere complice (Delitto e castigo è uno degli avantesti di Un paese di soli guardiani). Certo, le intenzioni esplicite del libro sono quelle di propiziare un tempo di speranza, costruito appunto su ciò «che ti ha ucciso una volta per sempre» (p. 64). Ma il lettore, diciamo, implicito preferisce abbandonarsi all’impressione di irresoluzione, di virtualità non pacificata, di rimuginìo quasi compiaciuto, che da un testo del genere proviene.
Come dire: il dispositivo distopico funziona se, passatemi il gioco di parole, rinuncia a essere dispotico. Se declina il suo malumore in modo fluido e aperto. La fine del mondo è quella cosa che, a ben vedere, distrugge anche le narrazioni. E raccontare la fine è la massima delle tautologie. Non lascia scampo, ci illude che la soluzione sia, in fondo, facile. L’alternativa additata da un pulpissimo fascicolo di fantascienza e da un aristocratico manufatto numerato a mano è invece quella di non chiudere, di rilanciare le questioni piegando il genere e i suoi luoghi comuni a dire non un desiderio di distruzione e di liquidazione, bensì di faticosissima, chimerica rinascita. È una ricostruzione forse impossibile, forse velleitaria. Ma un minimo di utopia svincolata dalla paura e dalla paranoia, per un attimo, sì, la vogliamo. Per favore.