Nella critica letteraria è comune tracciare una distinzione fra il poeta-poeta (il poeta ‘puro’) e il poeta-critico. Quali tipi di poeti-critici è possibile rinvenire, e in cosa si differenziano, a loro volta, dai critici-critici? Normalmente, al critico-critico sembra richiedersi uno sforzo teorico di inquadramento storico-estetico e un almeno dissimulato mascheramento o attenuazione delle proprie predilezioni e idiosincrasie: fattori, questi, propedeutici per un lavoro che aspiri a una qualche forma di sistematicità, o quantomeno di ampiezza inclusiva. Da un poeta-critico invece ci aspettiamo, più probabilmente, lo svolgersi in sottotraccia di un dialogo (o meglio, di un invito al dialogo) inter pares tra studiato e studioso, al fine di testare la tenuta delle coordinate estetiche e poetiche del primo, arricchendo o ridefinendo (per contrasto o consonanza) quelle del secondo.
Quest’ultima è, perlomeno, la figura del poeta-critico che emerge a tutta forza dalla tesi di laurea di Cesare Pavese, Interpretazione della poesia di Walt Whitman, discussa nel 1930 e meritoriamente pubblicata da Mimesis quest’anno per la cura di Valerio Magrelli, che ne firma la prefazione. In questo lavoro, per certi versi trasandato e per altri geniale, teso com’è fra «scarsa accuratezza nella redazione finale» e «ricerca degna, a dir poco, di un dottorato attuale» (Magrelli, p. 8), emergono tanto quel dialogo inter pares cui accennavo, quanto l’inevitabile distanza che separa il poeta-critico Pavese dai critici-critici con cui si trova a fare i conti: i numerosi (già allora) esegeti del bardo americano, che il poco più che ventenne biasima ripetutamente – e con un brio e una sicumera che riescono persino spassosi, come messo bene in risalto da Magrelli – per mancare continuamente il bersaglio. Il bersaglio continuamente mancato è la novità estetica apportata da Whitman. Ecco quindi alcune parole rivelatorie contro quello che fra tutti rimane pur sempre il critico preferito da Pavese (il che può solo far immaginare il trattamento riservato agli altri): «il de Sélincourt parla sempre soltanto di stili, di metrica o del contenuto storico, mai di una realizzazione estetica» (p. 27). A Pavese preme cioè comprendere Whitman in quanto poeta, gli interessa cogliere la novità dell’operazione (e la sensibilità, l’intenzione, la necessità a monte di questa) che l’americano mette in campo. I critici invece si perdono «in infinite questioncine formali» (p. 77), con il risultato che «tutti discutono di metrica e di democrazia e alla poesia ci pensi il lettore» (p. 77). Il fatto che fra le ultime due citazioni e la precedente intercorrono ben cinquanta pagine dimostra come questo j’accuse non sia affatto uno sfogo estemporaneo, ma la conseguenza di un’idea fissa che torna a spingere, di una presa di posizione netta a cui Pavese vota la propria fedeltà d’interprete.
La tesi che Pavese espone, difende ed espande per tutto il corso del libro è che all’intenzione di Whitman di «fare il poema dell’America intesa come una creazione nuova, distinta dall’Europa madre» (p. 18) abbia poi fatto seguito qualcosa di sostanzialmente diverso:
Egli non fece il poema primitivo che sognava, ma il poema di questo suo sogno. Non creò affatto un libro diverso in qualità dai libri ‘europei’, un nuovo modello letterario, un libro che non fosse un libro, ma, come ogni poeta ‘europeo’ degno del nome, creò un suo libro dove il sogno pratico si risolve nella poesia di questo sogno, nella lirica del mondo veduto attraverso questo sogno (p. 25)
Più avanti Pavese rincara la dose e accosta Whitman a uno dei massimi modelli europei, Keats, che solitamente gli viene invece contrapposto: per entrambi i poeti, infatti, la poesia consisterebbe nella «espressione di stati d’animo» (p. 38). In questa attenuazione dello specifico americano si potrebbe sospettare una strategia di legittimazione garantita dal confronto con il nobilitante modello europeo; strategia vòlta forse a incoraggiare una diffusione più agevole della letteratura americana in Europa, di cui Pavese diverrà di lì a poco uno dei maggiori artefici. Oppure, più semplicemente e meno maliziosamente, vi è in Pavese la convinzione profonda che tutta la grande poesia fondamentalmente si assomigli, e che pertanto travalichi tradizioni nazionali e periodi storici, vincendo sulla volontà whitmaniana di creare un poema nazionale.
Almeno due elementi sono notevoli in questo modo di procedere. Il primo è che Pavese prende le mosse dal tentativo di comprendere l’intenzione artistica di Whitman così come questi la espresse «in innumerevoli pagine innumerevoli volte» (p. 17), e in questo inconsapevolmente segue una pratica che un critico eminente come Harold Bloom afferma di aver appreso da Kenneth Burke: «Burke, sempre geniale e acuto, mi ha insegnato a chiedere: cosa sta cercando di fare il poeta (o il critico) per se stesso, in quanto persona, nello scrivere quella poesia o quel saggio?» (Bloom, prefazione a Hart Crane, The Complete Poems, trad. mia). Questa è la parte dell’ascolto, della comprensione appunto. Il secondo elemento, ancor più meritorio, costituisce la parte della replica, dell’agone: lungi dall’appiattirsi sulle dichiarazioni di Whitman, e cioè dall’usarle come una lente interpretativa privilegiata o un orientamento per il proprio studio, Pavese evidenzia la scollatura fra intenzione e risultato estetico, senza per questo svalutare il secondo. Anzi, sembra suggerire Pavese, Whitman è un grande poeta proprio perché la poesia gli riesce diversa da come egli avrebbe desiderato, proprio perché nel suo stesso articolarsi genera un’intuizione estetica nuova: non quella, già attestata in altre letterature ben precedenti quella americana, di creare un poema nazionale, per quanto diverso e innovativo; quanto piuttosto quella di cantare questo stesso desiderio, o per usare una formula impiegata più volte da Pavese: «poesia di far poesia».
Proprio questa riflessività autotelica, questa meta-tematica, consente a Pavese di liquidare come eresia critica «una letteratura primitiva che sa di esserlo» (p. 22) come quella agognata da Whitman; l’aspirazione al primitivo sarebbe, anzi, conseguenza di un eccesso di sofisticazione culturale, di consapevolezza letteraria:
Sempre, in fondo a tutte queste compiacenze moderne nel primitivo, sta il senso di liberazione dal civile e dal raffinato. E questo è del resto il loro pregio: noi, civili e raffinati, ci compiacciamo in questa ricerca poiché essa è figlia di un nostro raffinatissimo bisogno spirituale (p. 23)
Portando nelle stesse pagine anche l’esempio di Jack London, Pavese insomma ci ricorda che l’esistenza primitiva ha fascino non di per sé, ma in quanto opposta a (e quindi filtrata da) quella civilizzata che ci si vorrebbe lasciare alle spalle. Pavese vede così in Whitman «non un poeta primitivo, bensì un poeta del sentirsi primitivo, e pertanto capace di creare il mito modernista della primitività» (Magrelli, p. 11).
Che Pavese tratti Whitman da eguale (come d’altronde fece Pound in una poesia sempre a Whitman dedicata, A Pact: «we have one sap and one root. | Let there be commerce between us») lo si vede dalla severità impietosa, certamente esacerbata da sicumera giovanile, dei molti giudizi estetici che costellano la tesi, e che non risparmiano nemmeno i due poemi forse più celebri, la Song of Myself e O Captain! My Captain! («chi abbia messo in giro la favola di questo pregio straordinario, non so», p. 115): come dire che proprio la passione per un poeta, l’impegno nel metterne in luce la grandezza e nel difenderlo da letture ritenute errate, riduttive o marginali, autorizza il cultore laureando a non fare sconti, lo induce a misurare le parti meno riuscite con le vette di cui il suo maestro è stato capace.
Offrire una carrellata di questi giudizi consentirà di mostrare come l’«impostazione crociana della tesi» (Magrelli, p. 7) informi lo sguardo di Pavese laureando, portandolo a un’avversione dichiarata per quei testi o quelle sezioni in cui il pensiero, il concetto, sembrano prevalere sulla descrizione di scene pregne: «Ora le Inscriptions non introducono nulla […] se qualcuna ha veramente l’aspetto di un preludio o di una dedica, ciò è con suo danno perché cade in una forma che, appunto perché tale, non è più poesia, ma concetto, astrazione, sforzo» (p. 34); «semplicemente qui Walt Whitman ha in qualche istante dimenticato ogni emozione ed espresso una mera idea» (p. 34); «talvolta W. Whitman nella realizzazione di questa sua forma fallisce e dà fuori pagine morte, ora per troppo schematismo, ora per troppa confusione, sempre, nei due casi, per poca chiarezza interiore» (p. 35); «Dico subito che in questo poem [Starting from Paumanok] c’è una parte fallita, ma essa forma come una massa sola nel suo corpo, si può toglierla e di nuovo la corrente della poesia ritorna limpida e intera […] alludo alle sezioni dalla 6 alla 13 compresa […] egli qui discute, definisce, polemizza e proclama, però non crea un’immagine, la sua passione resta oratoria, vaga» (p. 36; si veda anche l’uso espressivo dell’analogia parti riuscite: fiume = parti fallite: impedimento); «Walt, quando come in questi casi, lascia la descrizione precisa per parlare più vagamente a esclamazioni e concetti di natura oratoria o passionale, fallisce quasi sempre» (p. 55; si noti anche l’informale uso del nome proprio, indice di trasporto confidenziale); talvolta dice addio anche al decoro accademico, come quando rileva «l’innegabile bruttezza di certe poesie e brani delle L. of G.» (p. 46) o quando, commentando la poesia Out of the Rolling Ocean the Crowd, si scaglia contro una «pasticciata e cerebrale similitudine […] assurdo dialogo del poeta con una goccia d’acqua che artisticamente non si vede» (p. 61); «la prima sezione [di Out from Beyond This Mask] è fallita causa il solito uso di un’immagine cervellotica com’è quella della maschera» (p. 139). Riportare alcuni estratti delle poesie liquidate da Pavese (che, per inciso, quasi mai le riporta in corso di discussione) potrebbe consentire di intuire, per contrasto, il suo ideale estetico, poi praticato in proprio negli anni della maturità artistica. Il seguente è tratto proprio dalla criticata Out of the Rolling Ocean the Crowd:
Out of the rolling ocean the crowd came a drop gently to me,
Whispering, I love you, before long I die,
I have travell’d a long way merely to look on you to touch you,
For I could not die till I once look’d on you,
For I fear’d I might afterward lose you.
Now we have met, we have look’d, we are safe,
Return in peace to the ocean my love,
I too am part of that ocean, my love, we are not so much separated,
Behold the great rondure, the cohesion of all, how perfect!
Whitman antropomorfizza la goccia d’acqua equipaggiandola di parole, e quindi di coscienza. Lo fa, probabilmente, per esaltare iperbolicamente la comunione fra poeta e natura («I too am part of that ocean»). La tradizione letteraria ci ha abituati ad animali parlanti, ma una goccia che parla è un’operazione più radicale, perché il salto ontologico da essere cosciente a composto chimico è assai maggiore rispetto al salto da essere cosciente ad esseri come minimo senzienti quali sono gli animali. L’espediente, pertanto, risulta troppo inverosimile («assurdo»), e dunque concettoso; il che semmai finisce per dar ragione alla tesi sopracitata che Whitman, mentre sogna il primitivo, è poeta sofisticato e per nulla sprovveduto dal punto di vista retorico. Possiamo sospettare che a Pavese dispiaccia anche la forma dialogica del componimento, che disapprova apertamente altrove («quell’antipatica forma dialogica che al poeta è piaciuto di assumere», pp. 105-6). D’altronde, le poesie di Pavese stesso coerentemente prediligono la voce monologica del narratore, empatico ma stoico nello schermare i sentimentalismi, e che solo nell’ultima produzione diventano allocutive («verrà la morte e avrà i tuoi occhi»).
La passione giovanile non conosce mezze misure, e allora non meno specularmente convinti e talvolta perfino affettuosi sono gli elogi che Pavese tributa al suo poeta quando ritiene che questi sia riuscito in qualcosa di notevole: a proposito della breve Native Moments scrive infatti «è veramente una gran cosa questa poesiola» (p. 58); più avanti, l’elogio si mescola a quello che nell’università di oggi sarebbe penalizzato come caso leggero di plagiarismo, ovvero la mancanza della fonte citata: «Ora, le poesie elegiache, o tragiche, di W. W. Sono solitamente gran belle poesie non mica per la tenebrosa ragione che più toccano «il fondo di tristezza che è la finale rivelazione di ogni profondo sguardo all’esistenza» come diceva non so più chi» (p. 80), e ancora più entusiasticamente su Crossing Brooklyn Ferry, «sento stupenda la lirica dello sguardo estatico gettato dalla chiatta alla città sotto il tramonto» (p. 127). Prendiamo, a titolo d’esempio, un estratto della prima sezione di Starting from Paumanok, che Pavese implicitamente apprezza, in quanto definisce fallite solo le sezioni che vanno dalla 6 alla 13:
STARTING from fish-shape Paumanok where I was born,
Well-begotten, and rais’d by a perfect mother,
After roaming many lands, lover of populous pavements,
Dweller in Mannahatta my city, or on southern savannas,
Or a soldier camp’d or carrying my knapsack and gun, or a miner in California,
Or rude in my home in Dakota’s woods, my diet meat, my drink from the spring,
La lingua, come si vede, è concreta e denotativa, con toponimi, paesaggi elencati al plurale e dunque come in campo lungo («many lands», «southern savannas»), arnesi e accessori di vita quotidiana e avventurosa («knapsack and gun»), un impianto monologico e biografico («where I was born»), un versetto che è reso musicale dalla cesura che lo bilancia in due, talvolta in tre emistichi; indici stilistici che rimandano agli «slanci e struggimenti autobiografici» del «primo Pavese, rimasto sostanzialmente inedito» (Silverio Novelli, Amore e disamore per il poeta Pavese, Treccani), ma che in fondo restano in buona parte applicabili al Pavese della maturità (al netto, certamente, di una modulazione del discorso più elegiaca e cupa di sottintesi – ma anche Whitman sa farsi elegiaco quando occorre, per es. in When Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d):
Un inverno a mio padre già morto arrivò un cartoncino
con un gran francobollo verdastro di navi in un porto
e augurî di buona vendemmia. Fu un grande stupore,
ma il bambino cresciuto spiegò avidamente
che il biglietto veniva da un’isola detta Tasmania
circondata da un mare più azzurro, feroce di squali,
nel Pacifico, a sud dell’Australia. E aggiunse che certo
il cugino pescava le perle. E staccò il francobollo.
Tutti diedero un loro parere, ma tutti conclusero
che, se non era morto, morirebbe.
Poi scordarono tutti e passò molto tempo.
(Pavese, da I mari del sud)
Scrive Magrelli che «molto andrebbe detto intorno all’influenza di Whitman sullo scrittore italiano» (p. 9). Nella consapevolezza che occorrerebbe un’intera monografia per uno scopo di tale portata, porgo intanto questi brevi prelievi per far notare come le predilezioni di Pavese vadano verso quei luoghi whitmaniani più prontamente assimilabili dall’autore italiano: quelli dove la descrizione prevale sulla declamazione, dove la verità individuale la spunta sul volontarismo epico o sul cronachismo grezzo. Non sorprende, allora, che persino delle poesie tarde criticate aspramente nell’ultimo capitolo (Il passaggio all’anima e la vecchiaia) egli salvi quelle in cui si rappresenta «la figura del vecchio che ha lottato e faticato e ora finisce melanconico e stanco», grazie alla quale tali poesie riescono «indimenticabili per questo senso penoso dell’inutilità e della fine» (p. 145). Siamo nella preferenza per l’elegia, per la vulnerabilità; quando il vecchio Whitman cerca di rifare se stesso, cade invece nella «letteratura diventata mestiere, la letteratura letteraria» (p. 144). Non è difficile scorgere in questo fastidio, in questa postura già ben formata, quella intransigenza e quella vena misurata così centrali nel futuro scrittore e poeta.
Oltre che nei giudizi estetici, il crocianesimo del giovane Pavese si fa sentire nell’approccio intuitivo, non sistematico, nei confronti dei testi: così l’autore rivendica orgogliosamente di non aver «detto nulla, finora, della metrica whitmaniana» (p. 121) per subito dopo correggere maldestramente il tiro («Intendiamoci, io non combatto qui la scienza metrica che anzi, benché mi sia sempre parsa un poco ermetica, rispetto e ammiro», p. 121). Magrelli qui giustamente ammette che questo presupposto «lo porta a vere e proprie enormità» (p. 13). Eppure, lo sguardo così intuitivo e anti-analitico di Pavese coglie in profondità la funzione di almeno un tipico stilema whitmaniano, quello del catalogo, spesso frainteso dagli altri commentatori:
[Whitman] fa poesia della contemplazione ed è quindi interamente fuori segno lamentarsi della gran parte che hanno in lui i cataloghi, come fanno quasi tutti. […] È la sua forma il catalogo, egli, a sottilizzare, non descrive questa o quella parte del paesaggio, ma il modo con cui egli stesso riassorbe il tutto (p. 125)
Questa intuizione sembra davvero lontanissima dalla (pseudo)stilistica formalista-prescrittiva (la spesso lamentata pesantezza del catalogo) e anticipa ricerche recenti della poetica e della stilistica cognitiva, inclusa quella in fieri del sottoscritto e del redattore Lorenzo Cardilli: la forma-catalogo come montaggio d’immagini che mima una percezione continua e fluida dei referenti, come la carrellata di uno sguardo che, nel caso di Whitman, procede spesso per campi lunghi. A p. 88 c’è anche una tangenza con la foregrounding theory (teoria del rilievo/della salienza), cioè la teoria formalista inaugurata da Shklovsky all’inizio del Novecento e che sta vivendo attualmente un vero e proprio rinascimento: assunto fondante della foregrounding theory è che parti del testo siano rese stilisticamente salienti, distaccandosi dalla norma del testo come nell’arte pittorica figurativa un soggetto o un dettaglio si distaccano dallo sfondo. Pavese difende la scelta di Whitman di usare il forestierismo Allons, deprecato quale barbarismo dal critico John Bailey, nella poesia Pionners! O Pioneers!, con argomenti di comune buonsenso estetico, e cioè sfidando beffardamente il Bailey a valutare altre opzioni paradigmatiche: «Che cosa voleva il Bailey? Uno scialbo «come on!» o un discorsivo «get up!» o un «forward» o «let’s go»? Un pittoresco e slangy «shake a leg!»?» (p. 88). Allons, in quanto forestierismo, si distacca dalla norma anglofona del testo («per staccare risolutamente e indimenticabilmente dal resto», p. 88) e risulta essere proprio le mot juste, perché «reciso e impressivo nella sua posizione e nelle sue ripetizioni» (p. 88). Così, mentre ripercorre, capitolo per capitolo, altrettante figure whitmaniane (il mito della scoperta, il pioniere, l’amore virile, i grandi songs, l’epica nazionale, le meditazioni, il passaggio all’anima e la vecchiaia), questo Pavese ventunenne non risparmia al lettore intuizioni, polemiche, acerbità, ridondanze, entusiasmo, rivelando anche certe contraddizioni che forse inevitabilmente lo animano. Interessante, in particolare (anche a seguito del recente successo dell’ultimo di Franco Buffoni, Silvia è un’anagramma) la posizione ambigua sull’omosessualità di Whitman: da una parte il giovane Pavese rivela un progressismo che mal sopporta la censura puritana e anticipa nell’attitudine gli studi di genere («Ci vuol tanto a esprimersi colla scientifica schiettezza di J. Schlaf che, chiaro come il sole, intitolò il suo articolo Walt Whitman homosexuelle?», scrive a p. 51); dall’altra egli stesso non è immune dalle norme morali dell’epoca (siamo al principio degli anni Trenta): poco oltre, quasi di sfuggita e come in un appunto personale, infatti scrive «io, personalmente, credo che W. Whitman non avesse quel vizio» (p. 57, corsivo mio). Insomma, da queste centocinquanta pagine emergono due figure, quelle di Pavese e di Whitman, davvero a tutto tondo, contradditorie ma estremamente pulsanti, accoglienti: si offre così – tanto ai cultori quanto agli appassionati (amanti?) dei due autori – di che riflettere e di che divertirsi.
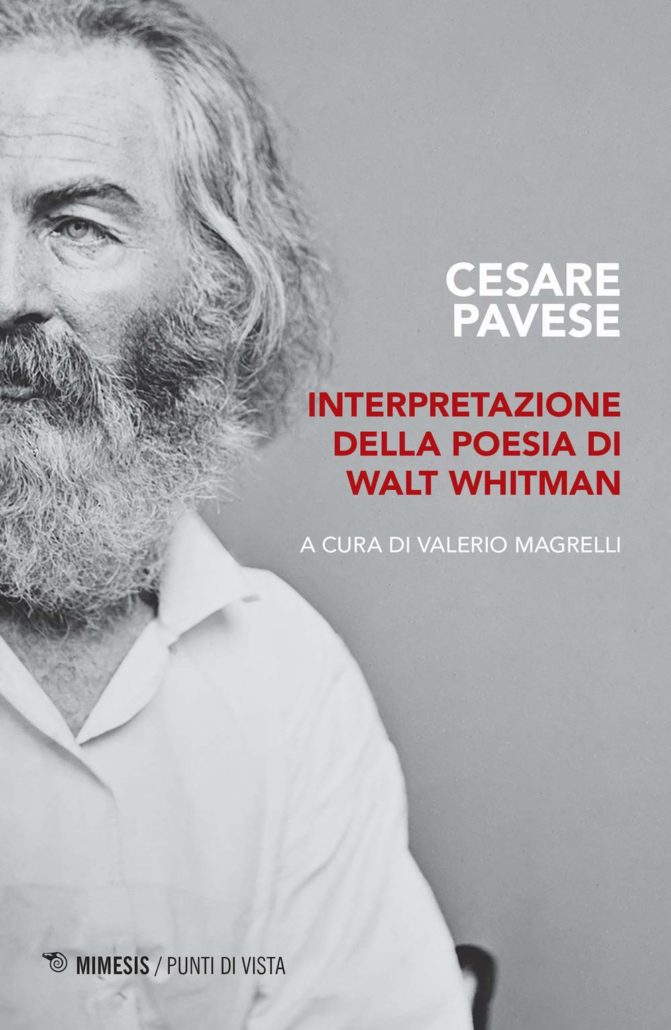
C. Pavese, Interpretazione della poesia di Walt Whitman, introduzione e cura di V. Magrelli, Milano-Udine, Mimesis, 2020, pp. 152, € 13.