La questione razziale non è una questione di pelle, dice James Baldwin, non una questione di corpi, ma una questione di simboli e di modi di vivere: la pelle non è un connotato somatico, ma una realtà politica. Allo stesso modo, il bianco «non è un colore, è una disposizione mentale. Sei tanto bianco quanto credi di esserlo»; mentre «il nero è una condizione». Questo carico simbolico, culturale e politico, è esattamente ciò che la scrittura affilata di Baldwin cerca di scrutare in La prossima volta il fuoco, pubblicato per la prima volta nel 1963 e ripubblicato da Fandango nel 2020. Al cuore del saggio, il pulsare di umori sotto la pelle di un’America escoriata, aperta a colpi d’arma da fuoco. A muovere l’analisi è l’audacia di sfidare lo stato paranoico di una parte e dell’altra, di chi detiene il potere e di chi ha il potere di minacciarlo, le sabbie mobili nelle quali gli Stati Uniti si sono ritrovati a stagnare in nome di un sogno americano suicida. Riproponendo un’espressione dello stesso Baldwin utilizzata in un’altra occasione, il tentativo è di guardare in faccia «il cadavere nero che galleggia nella psiche della nazione».
Il saggio si compone di due parti: la prima è una lettera indirizzata a suo nipote James, pensata in occasione del centenario del Proclama di emancipazione (con cui nel 1863 lo status legale degli schiavi neri passa a libero); la seconda, più lunga, è una riflessione più organica sulla condizione afroamericana di quegli anni, e prende vita dalle esperienze personali dello scrittore, per procedere verso una progressiva astrazione nell’analisi culturale, psicologica e morale dell’America del tempo. L’andamento della riflessione è tanto serrato quanto limpido, in grado di mantenere la solidità di un rigoroso ragionamento logico e allo stesso tempo abbastanza coraggioso da cedere all’emotività, quando necessario. Il risultato complessivo ha la violenza di una prosa implacabile nei toni, eppure tanto umanistica nei contenuti. Baldwin non lascia mai che la forza delle sue argomentazioni si trasformi in cieca aggressività. Declama chiaramente il sopruso ma non odia il carnefice. Piuttosto decide di guardarlo e descriverlo con condiscendenza, con la pietà di chi dice cristianamente: «Perdonali, perché non sanno quello che fanno». Da questo tono perentorio e conciliante, rappresentativo di una sorta di hard love, emerge un costante confronto tra biografia e analisi filosofica. La storia di Baldwin è quella di qualsiasi altro afroamericano, un vissuto particolare e generazionale allo stesso tempo. La vicenda privata diventa, così, testimonianza viva del sopruso, e va a comporre le fondamenta indiscutibili su cui poggiare per rivolgersi al nocciolo del problema, squisitamente filosofico: perché la questione razziale?

Lo scrittore afroamericano parte dalla Harlem della sua infanzia, dagli androni pieni di whisky e sguardi bassi, da quell’odio rimasticato contro un potere generico, una «nube che si piazzava tra loro e ciò che desideravano, qualunque cosa fosse». Una gabbia a cielo aperto perimetrata dalle regole del ghetto, che svelavano da un lato le frustrazioni dell’America bianca (anche di quella istituzionalizzata) e dall’altro la sopravvivenza delinquenziale dell’America nera. La vita descritta da Baldwin era assediata da un fuoco incrociato, e l’incontro con il potere dei bianchi suggeriva una prima e unica lezione di vita: il disprezzo di sé stessi. In questo humus di sproporzioni e contraddizioni nasceva il bisogno di aderire a una comunità, alle gang di quartiere o alla Chiesa, l’esigenza di appartenere a qualcuno per senso di protezione e il calpestamento del dignitoso appartenere solo a sé stessi. La segregazione razziale – che terminò, nella sua forma più conosciuta, solo nel 1964 – alimentava il bisogno di far parte di qualcosa, qualsiasi cosa. Allora lo scrittore ripercorre dall’interno innanzitutto il suo giovanile interesse per la Chiesa (all’età di quattordici anni divenne predicatore per tre anni). Poi il suo confronto con la predicazione separatista dei Black Muslims (che è – indirettamente – anche un confronto con Malcolm X, suo amico che aderì al movimento fino al 1963). Entrambe le soluzioni, però, gli apparirono monche, come deprivate di una riflessione imprescindibile: non esiste una salvezza dimezzata, la vittoria partigiana è inapplicabile, oltre ad essere immorale. In questo risiede, secondo Baldwin, il vero limite del movimento dei Black Muslims, perché il destino dell’America nera è legato a doppio filo a quello dell’America bianca, e viceversa.
Eppure per Baldwin questa interdipendenza tra America bianca e America nera non va confusa con una sterile integrazione, che è un altro modo per legittimare l’imposizione del modo di vivere bianco alla comunità afroamericana: dal seno dello scontro fra le culture non deve sorgere una bonaria apertura delle porte del paradiso bianco, concessa in cambio dell’omologazione, ma una matura convivenza tra modi di vivere differenti, una critica radicale del sogno americano come unico dettato che la nazione è disposta ad accettare. In un’intervista rilasciata a «Esquire» nel 1968, Baldwin riassunse:
«Non voglio essere integrato in questa casa, o in nessun’altra casa se è per questo, e tanto meno in una casa che brucia. Non voglio diventare… come voi. Voi popolazione bianca. […]. Noi puntiamo a qualcosa di diverso, che poi è esattamente quello che cercava anche Martin: una comunità. Vorrei solo che mi lasciaste in pace».
In questo rifiuto sdegnoso di uno stile di vita diverso e imposto emerge anche una certa convergenza con le posizioni di Malcom X che – come Baldwin – si chiese in quale casa sarebbe stato integrato, prima di considerare l’integrazione come ipotesi («L’integrazione in America è un’ipocrisia nella forma più cruda. Tutti questi privilegi di facciata vengono propinati al negro per poi dirgli: “Guarda cosa stiamo facendo per te, Tom”»). Ciò che serve non è dunque una perfetta sinergia tra le parti, che è un altro volto del dominio perpetrato dalla parte più forte, ma l’accettazione della disarmonia.
A questo punto della riflessione appare evidente l’influenza esercitata dallo scrittore Richard Wright, conosciuto direttamente da Baldwin negli anni Quaranta e con il quale instaurò una vera e propria querelle. Secondo Richard Wright il nero deve tener conto dell’opera di razzializzazione che si auto-infligge osservando sé stesso negli occhi del bianco. L’afroamericano di Wright perde le fila della propria identità perché frastornato dallo sguardo bianco, che appartiene all’Altro e che viene interiorizzato. In Fame americana (1944), Wright scrive:
«Odiato dai bianchi, e facendo organicamente parte della cultura che lo odiava, il nero finiva a sua volta con l’odiare in sé stesso ciò che gli altri odiavano in lui. Ma l’orgoglio gli imponeva di nascondere l’odio di sé stesso […]. E così, ogni minuto della sua giornata si consumava in una guerra contro sé stesso».

I due autori condividono proprio questa presa di coscienza: la questione razziale si gioca innanzitutto su un campo psicologico e simbolico. Al centro del discorso svetta lo sguardo che la cultura dominante applica alla comunità afroamericana. Ma mentre Wright si fa rappresentatore della confusione identitaria che ne deriva, della cieca violenza nata dal rapporto tossico con lo sguardo del bianco, Baldwin ribalta la prospettiva: è in questo che risiede la chiave del riscatto.
«Non so cosa vedono i bianchi quando guardano un nero, ma quello che ho percepito, sin dall’infanzia, è che quello che vedono, non sono io. Se io, in quanto afroamericano, mi rifiuto di utilizzare il suo metro di giudizio e di considerarmi nei termini in cui lui, ipotetica figura del bianco americano liberale, mi vede, divento libero di pensare con la mia testa e di giudicarlo a mia volta».
Un ribaltamento di prospettiva: se la cultura bianca guarda l’afroamericano attraverso un filtro stereotipato e suprematista, la reazione del nero non deve limitarsi al sentirsi guardato, ma deve trovare il coraggio di fissare negli occhi la cultura bianca, a sua volta. Conoscere l’Altro e, in un certo senso, riconoscerlo in quanto Altro; estirpare il suo discorso dalla costruzione dell’identità afroamericana; e, infine, ribaltare i ruoli, assumere su di sé il diritto di giudicare e di accettare (o meno) la comunità bianca. Su queste energiche rivoluzioni morali e psicologiche si costruisce la solidità di un riscatto in grado di resistere al richiamo della cieca violenza.
Per Baldwin questa rivoluzione tettonica alimentata dalla comunità afroamericana non solo è auspicabile, ma è anzi indispensabile: la condizione dell’afroamericano non potrà cambiare finché anche i bianchi non saranno liberi. Liberi da loro stessi. Superare la questione razziale è anche una questione di sopravvivenza della cultura bianca, perché, in fin dei conti, è della sua morte che si sta parlando: ancora una volta, la salvezza dell’America non può esser dimezzata. Per risollevarsi dal suo progetto suicida l’America deve allora accettare il proprio fallimento, deve, in sostanza, riconoscere le proprie contraddizioni. Solo così potrà smettere di sacrificare la comunità afroamericana sull’altare dei “colpevoli”. Con grande lucidità Baldwin scorge, nel 1963, tutti i limiti della narrazione americana, fanatica e contraddittoria, gloriosa e spaventata. E dimostra, in questo senso, quanto aveva già sostenuto: gli afroamericani hanno compreso dei bianchi molte più cose di quanto i bianchi siano disposti ad ammettere a sé stessi. L’esclusione dell’afroamericano rivela la paura provata dall’America bianca, e con essa la percezione verticale del paradosso: il sogno americano è stato costruito sulle spalle del nero, l’illusione di libertà è cresciuta come un fungo all’ombra della prigionia. Così Baldwin scorge già nell’America del 1963 il profilo di un paese sfiancato dalla sua stessa ideologia (che non si autodenuncia come tale) e che è costretto a nutrire il terrore con il terrore; un paese che crede talmente tanto in se stesso da non riuscire a credere in altro (e che finisce per aver paura dell’Altro); un paese che predica la libertà ma celebra la superiorità. Queste contraddizioni dell’America si alimentano, secondo Baldwin, in maniera sotterranea, rinvigoriscono un senso di inquietudine inespresso che spinge ad allontanare e zittire chiunque possa mettere in discussione la cultura dominante, come, ad esempio, la comunità afroamericana («non voglio essere integrato in una casa che brucia»). È questa la grande vergogna che una certa America non può sopportare: non essere desiderabile. Per questo si attacca a simboli come potere, denaro e sicurezza, alla tendenza (anch’essa simbolica) a considerarsi bianca e solamente bianca, all’incapacità di accettarsi per il paese che realmente è; ma da questo tentativo di cristallizzazione, proviene anche l’incapacità di attingere alla propria linfa vitale. La conseguenza è chiara: non ci sarà libertà incondizionata finché l’America bianca non abbandonerà la propria narrazione solitaria e narcisistica per accettare anche ciò che la contraddice (non integrare, accettare). E deve farlo alla svelta, perché c’è un limite massimo di afroamericani da sbattere in prigione e da uccidere, c’è un limite massimo per questa carneficina, per questa soppressione istituzionalizzata dei corpi: ogni afroamericano ucciso ingiustamente non è altro che una conferma dell’inevitabilità di quella morte differita, a lungo termine, che sta rincorrendo l’America bianca. E per la quale, secondo Baldwin, l’America tutta rischia di collassare su se stessa. Eppure Baldwin non si ferma qui. Non solo rielabora in maniera limpida le contraddizioni e le colpe dell’America bianca, ma espone anche le responsabilità storiche dell’America nera. In questo quadro deve inserirsi l’assunzione di consapevolezza dei neri, una comunità che soffre la pena senza sapere quale sia la sua colpa. In questo quadro la rivoluzione della comunità afroamericana agisce come un energico sfondamento di schemi ad ogni modo destinati a crollare, di cui l’America tutta ha un bisogno spasmodico. E in questo senso la comunità afroamericana dovrebbe riuscire a metter da parte il rancore storico, la rabbia vuota (quella narrata da Wright), per abbandonare la linea separatista e partecipare alla costruzione di una nazione rinnovata.

Così, rielaborando l’insieme di queste riflessioni e la loro interazione, appare evidente come l’ottica di Baldwin si rivolga sia a un’analisi della cultura bianca sia a un’analisi della cultura nera separatista: della prima critica le contraddizioni interne, della seconda le soluzioni. Come nella sua Harlem, la questione razziale è vittima di un fuoco incrociato. Come nell’impostazione di tutto il saggio, la vicenda privata diventa quasi prefigurazione di riflessioni ed evoluzioni di carattere strutturale: né con la Chiesa né con i Black Muslims; né con la ghettizzazione bianca, né con il separatismo afroamericano. Ancora una volta questo fuoco incrociato è sì causa di dolore, ma anche punto di incontro di due traiettorie destinate ad incrociarsi, e che non possono continuare a negarsi vicendevolmente. Proprio per questo Baldwin riesce a ricostruire il profilo di un vero e proprio rapporto tra classi, in cui ogni classe esiste proprio grazie all’esistenza dell’altra, e in cui l’interdipendenza crea anche l’ipotesi di un ribaltamento: gli oppressi possono diventare, paradossalmente, i liberatori degli oppressori; e gli oppressori possono, liberando sé stessi, liberare anche gli oppressi. A questa critica politica (prima ancora che culturale) Baldwin affianca un ulteriore elemento di originalità: la comunità bianca va posta di fronte alle sue grosse responsabilità, ma non va odiata, in virtù di una cristiana pietà riservata a ogni forma di oppressione, anche se è autoinferta, e in virtù della difesa della propria dignità morale. Da questa interazione dolorosa ma costruttiva l’America deve ripartire per ricostruirsi un’identità radicalmente diversa, un hard love, un’accoglienza del conflitto inteso non come vendetta, ma come confronto a cuore aperto con una realtà polimorfa, troppo spesso mummificata da simboli stantii. Altrimenti, secondo Baldwin, il rischio è evidente, e assomiglia molto a ciò che l’America sta vivendo recentemente: i due fronti drizzano la schiena, da un lato l’ormai disperato attaccamento al sogno americano di chi crede troppo, dall’altro il liberi tutti di chi non crede più in nulla. «I neri di questo paese magari non riusciranno a raggiungere il potere, ma sono nella posizione di precipitare tutto nel caos e di far calare il sipario sul sogno americano».
Così Baldwin affonda una critica lancinante nel grembo di un’America ancora fiduciosa, un attacco di una limpidità violenta, che però è in grado di mantenere la dignità del controllo sulle proprie emozioni, di resistere all’odio per amore di sé, di proporre un legame di interdipendenza per richiamare tutti alle proprie responsabilità storiche. Perché i rapporti di dominio sono legati ai simboli, non a uno stato di cose fisiologico, e i simboli possono essere storicamente sovvertiti. Su questo punto Baldwin è irremovibile, come ribadito nella sua intervista su «Esquire»: «Perché l’uomo nero americano diventi una persona libera in questo paese, la popolazione deve rinunciare a qualcosa. E se non lo farà, gli verrà tolto con la forza».
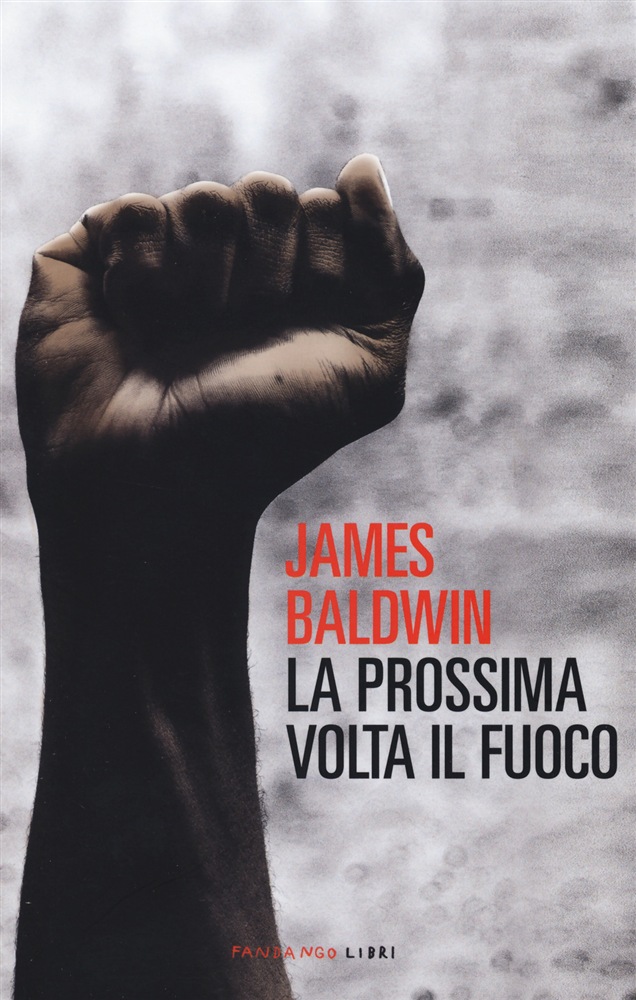
James Baldwin, La prossima volta il fuoco, Fandango, Roma 2020, 118 pp., € 14,00.