La vitalità del genere ‘stroncatura’ è indice di buona salute di un ecosistema culturale. Davide Brullo, autore di diverse raccolte poetiche, romanzi, traduzioni, e fondatore della rivista Pangea, ha raccolto ora in volume per l’editore Gog alcune sue recenti stroncature di libri italiani. Nell’aforistico saggio iniziale l’autore espone la sua idea (discutibile, ma rispettabile) della stroncatura e dello stroncatore. Brullo rifiuta sia «la posa del critico» che «i codici costituiti dell’etica giornalistica»; a suo avviso «non si entra in ‘dialogo’ con l’opera, la si disintegra», e perciò «la stroncatura non ha un linguaggio sobrio – al contrario, è esasperata, grottesca, inaudita –, non è oggettiva», possiede «il mordente della satira di Swift, la leggerezza di una chiacchiera». Lo stroncatore s’identifica col selvaggio Mowgli di Kipling, creatura della giungla, né uomo né bestia, sciolto perciò da vincoli d’appartenenza e da timori reverenziali. È evidente il richiamo all’Omo salvatico di Giovanni Papini, che per primo con le sue Stroncature (1916) introdusse quest’ultimo termine nell’àmbito letterario, e nella cui linea di critica umorale e ‘teppistica’ anche Brullo s’inserisce, pur senza nominarlo (ma pubblicando per un editore dal nome molto papiniano).
Diremo più avanti di quanto possa risultare problematica tale postura. Quanto al genere stroncatura, si può aggiungere che si tratta di una sottospecie del genere recensione: la sua eventuale crisi va inquadrata nella più ampia crisi di quest’ultimo. La critica letteraria, sia nella sua anima accademica che in quella militante, è tutt’altro che scomparsa, ma attraversa senz’altro un periodo di difficile riassestamento; la recensione, positiva o negativa che sia, fatica particolarmente a trovare uno spazio e una forma che si distingua dal saggio scientifico, dal lancio d’agenzia, ma anche dal tweet. Così, anche la stroncatura veramente salutare sarà oggi quella che si fondi su un’articolata visione critica, non solo sull’uzzolo di rovesciare idoli; e all’aggressività mordace (già ampiamente praticata sui social librarî o generalisti) dovrà affiancare un’argomentazione perspicua e una controproposta credibile.
Naturalmente, a Brullo non si può certo imputare di non aver proposto, nella sua variegata opera di poligrafo, una pars construens. Ma va detto che anche prima di questa raccolta si era distinto per lo stile battagliero e provocatorio che infiamma i suoi scritti: si direbbe che nel suo caso la polemica sia un asse portante dell’ispirazione e dell’attività letteraria. Portati per indole a una critica più obliqua, ci sottraiamo alla tentazione – peraltro troppo facile – di stroncare un libro di stroncature. Non, però, a quella di recensirlo. Vediamo dunque più in dettaglio l’oggetto e la natura delle demolizioni brulliane.
Oggetti delle stroncature antologizzate sono letterati di professione (nella fattispecie narratori) nella prima e più ampia sezione del libro, Il mausoleo della letteratura; giornalisti/saggisti e guru culturali di varia estrazione nella seconda, Gli intoccabili. Alle due sezioni si aggiungono un frammentistico reportage del Premio Strega 2018 e una riflessione sul ruolo deleterio degli editor, che rendono la prosa dei Wu Ming indistinguibile da quella di Caterina Balivo. È notevole che Brullo, poeta e promotore militante di poeti (benemerito curatore di antologie come Maledetti italiani, sui minori del Novecento, e Stella polare, sugli autori degli anni Zero), qui non faccia oggetto delle sue attenzioni la poesia. Fanno eccezione, per modo di dire, gli orridi tentativi in versi di non-poeti, come le Bambinacce di Veronica Raimo e Marco Rossari (interessante perché la recensione stessa è in versi), e l’imbarazzante ‘fuori collana’ einaudiano di Eugenio Scalfari (elogiato da Asor Rosa in quella che Brullo definisce, a piena ragione, «una delle più brutte pagine di giornalismo culturale che il nuovo millennio ricordi»).
È possibile che la scelta di non includere recensioni di poesia dipenda dalla volontà di concentrare l’attacco sulle figure più in vista del panorama culturale nazionale; la poesia, si sa, gioca ormai un ruolo davvero minore in questo panorama, e proprio per la sua marginalità è meno soggetta alle incursioni di prestigiosi dilettanti (con qualche incresciosa eccezione come quelle appena citate), e in media appare caratterizzata da una maggior competenza linguistica di base. Comprensibile, insomma, che nel denunciare storture sistemiche si miri ai rappresentanti più importanti e tipici di quel sistema.
Basta già scorrere l’indice per sospettare che Brullo compia opera giusta e necessaria. Di fatto, leggendo i pezzi, si è colpiti da quanto spesso l’aspro giudizio sia condivisibile. Brullo mette a nudo i vizi di un’editoria soccombente alle logiche del marketing: gli autori fagocitati dal personaggio o dal brand, i romanzi già pronti per diventare fiction o spettacoli teatrali, l’ossessione per il giallo e per il food, il contenutismo che pretende di sostituire l’impegno e i certificati ideologici alla cura dello stile e allo scavo nella realtà, il declino di collane storiche come i Meridiani o la ‘bianca’ Einaudi… I mali sistemici di cui le singole opere recensite sono altrettanti sintomi vengono tutti individuati con precisione e denunciati con appassionata verve. Il bersaglio prediletto, però, è il narcisismo patologico di scrittori e intellettuali italiani; l’approssimazione stilistica dei letterati di successo, da Baricco a Camilleri, da Ferrante a Saviano, e il dilettantismo enciclopedico dei saggisti tuttologi alla Augias o Citati. Per non parlare della vanità di chi pretende con sicumera di esportare la propria auctoritas in un campo non suo, come gl’imprenditori rifatti filosofi, i fisici che gareggiano coi poeti, gli psicoanalisti con l’invidia del pulpito; e, peggio forse di tutti, quei giornalisti che «pensa[no] alla letteratura come a una medaglia ornamentale» da appuntare al curriculum. Ne risulta una galleria grottesca di soggetti degni della pagina io, professione mitomane (che in genere preferisce però, maramaldescamente, prendersela coi pesci piccoli), i quali sfoggiano l’egocentrismo quasi comico di chi fa la storia dei grandi eventi sulla base dei suoi viaggi di lavoro a New York, o la storia del pensiero sulla base di una cultura generale imparaticcia.
Aggiungiamo la permalosità di quegli scriventi che davanti alle critiche preferiscono adire le vie legali. Brullo riporta una recensione ad Alessandro D’Avenia cancellando le frasi giudicate offensive dai legali dell’autore, e vantandosi sornione in nota che la stroncatura integrale sia «irreperibile in rete e altrove: l’intimidazione ha vinto» – ma i passaggi censurati si trovano tutti virgolettati nella prefazione a p. 8, e reintegrarli è agevole.
Le staffilate a simili personaggi sono non solo fondate, dunque, ma perlopiù ben argomentate nel merito. È apprezzabile che Brullo, pur nei limiti di pezzi dal taglio giornalistico, cerchi quasi sempre di fornire e commentare campionamenti testuali dalle opere trattate. Come critico, mostra di avere un buon orecchio per le stonature stilistiche, lessicali e psicologiche: i suoi rilievi diagnostici sulla scrittura degli autori recensiti sono in genere precisi e convincenti, i commenti a margine sovente spassosi. Forse può lasciare più perplessi la ricorrente formula del tipo «piuttosto che perdere tempo con X, leggete Y», dove se X è lo stroncato di turno, Y può essere un autore del canone ‘maggiore’ (nel qual caso il confronto è tanto impietoso da essere improponibile: chi davvero oggi potrebbe o vorrebbe gareggiare con Proust o Rilke?) oppure un altro contemporaneo, vuoi celebrato come Roth o Houellebecq, vuoi relativamente snobbato dall’editoria (in questo caso i suggerimenti di letture alternative sono utili, e avrebbero potuto forse essere moltiplicati).
Veniamo alle marche stilistiche dell’attività stroncatoria di Brullo. È infatti sul lato formale che si concentrano le principali riserve. Non parlo, evidentemente, di refusi o scelte editoriali dubbie che non saranno imputabili all’autore (diacritici assenti in qualche nome straniero, anacoluti, le «canzoncine di Paul McCarthy» [!]; e lascia perplessi la scelta di non riportare gli anni di pubblicazione dei libri discussi).
Lo stile di queste stroncature, già noto a chi conosce la prosa critica di Brullo, è espressionistico e imaginifico, con qualche unghiata del poeta nei momenti migliori, e un’insolenza che però diventa spesso corriva, qui incoraggiata dalla natura giornalistica dei pezzi. La ricerca dell’icasticità e dell’enfasi produce iuncturae surreali («quadrupede noia») o introduce scarti lessicali bizzarri in locuzioni consuete («sgangherare dalla tomba Freud»). A un livello più superficiale, Brullo ama vivacizzare la scrittura con formule allitteranti («romanzi che marmorizzano i maroni», «peplum pepato, un polpettone») e paronomastiche: «i puttini […] mica il puttaniere», «scampagnata nella scarpiera», «omerica e omertosa», «s’impunta lì, s’impantana», «compassata compassione», «afrore nostalgico, l’afrodisiaco», «dovuto, devoto». La ricerca della freddura a volte stucca: «la letteratura funziona finché fa cassa. Cassate.»; «quanti – che quantificano la mia quantità di stupidità in materia». Quando il cognome stesso del recensito invita al calembour, lo stroncatore purtroppo non si tira indietro: «Teresa Ciabatti […] romanza sciabattando», «Gamberale, scrittrice che gambizza tutte le voglie», «baraccopoli dei Bariccodipendenti», «Rampini, in vena […] di rampicata» – neanche se l’esito è scurrile: «Francesco Piccolo, quando ce l’aveva piccolo». Ho sfogliato perciò con terrore le pagine dedicate ad Aldo Cazzullo – e infatti, a p. 129, ecco «col cazzo. Cazzullo…».
Non si tratta di boutades isolate, per quanto di dubbio gusto, perché s’inquadrano in una scelta più generale. Quando va bene, agli stroncati sono indirizzati epiteti pachidermici («rinoceronte», «ippopotamo», «ungulati», e sopra tutti il prediletto «brontosauro»). Ma quando vuole infierire davvero il recensore non si perita di ricorrere al registro escrementizio e genitale («il libro è una pisciata […] è stato scritto col cazzo»). Brullo rimprovera a diversi recensiti l’ossessione per il sesso, e ha tendenzialmente ragione a punzecchiare la morbosità mandrilla di scriventi (maschi) che usano i libri come «appendice fallica», peraltro mostrandosi stilisticamente impacciati ogni volta che c’è da descrivere un amplesso. Ma l’impressione è che lui stesso vada per così dire sempre a parare da quelle parti (basse), se di un libro lamenta che provochi «ragadi anali di noia» anziché una «erezione letteraria», se quattro volte compare l’espressione gang bang (due volte, è vero, in accezione letterale, ma altrettante adibito evidentemente a termine critico), e se a un altro scrittore si consiglia di «scopare di più». C’è in generale un ricorso a un’aggressività di stampo a dir poco popolaresco: non si contano i «che cazzo me ne frega», «gente con due palle così», «ci si lecca il didietro», «capire se lo stronzo sono io o se è lei», «tira più un pelo di fica che un carro di buoi». Benissimo rivendicare alla recensione un linguaggio «eccessivo» e «pugnace», come nella risposta a Paolo Cognetti, ma un tono può essere diretto e antiaccademico senza essere da osteria o da caserma.
Va detto, però, che nella retorica mistico-viscerale adoperata da Brullo gli stessi campi metaforici ‘bassi’ e lo stesso violento espressivismo sono impiegati anche nella lode degli autori amati o nella descrizione del proprio ideale di scrittura. Nel suo gergo, infatti, non si contrappongono un polo-merda e un polo-rose, ma un polo-merda e un polo merda+rose. Tipiche sono espressioni come «ho le narici lordate di stelle – non cerco niente se non un linguaggio […] che brilli nel regno dei morti», o «Eros non è una scatola di cioccolatini, ma una turba di lupi che ti assaltano». Brullo addita a ideale positivo una letteratura che «è stimmate, ferita, iato, bestemmia, ululato, affronto» e che «fa odore di piscio e di rose» – o, con variazione sul tema, «mescola abisso e mezzogiorno, sterco e rose». In altri suoi interventi, il vero poeta è al tempo stesso angelo e carogna, creatura sublime e reietto imperdonabile, l’atto conoscitivo della scrittura è un frugare tra visceri ripugnanti, etc. Molto si può obiettare su questa retorica di esagitati ossimori e su quanto essa sia conciliabile con la lucidità dell’esercizio critico, ma non sulla coerenza con cui è impiegata.
Che altro aspettarsi, insomma, da un recensore-Mowgli, cucciolo d’omo salvatico? Ma reclamando questo status di selvaggio, fuori dal consesso e dalle regole, Brullo si automitologizza non meno dei letterati mitomani da lui fustigati; giustifica a priori i suoi eccessi stroncatorî e mistifica il ruolo che egli stesso detiene nella società letteraria, sia pure da marginale scontroso. Stuzzicati dall’appendice Davide Brullo stronca Davide Brullo, ci attenderemmo di vedere l’autore stesso affrontare questi nodi problematici – ma l’attesa va delusa. L’autostroncatura finale è infatti esagerata nei toni quanto puntigliosa nell’elencare gli effettivi meriti dell’autore, e perciò non può non suonare insincera, passivo-aggressiva; il negativo di un autoelogio. Sarebbe stata più realistica e credibile (ma, lo capiamo, meno brulliana) una critica circostanziata. Qui invece siamo sempre nella solita retorica dell’oltranza, che umilia per innalzare. Suona casomai più onesta e lucida l’autocritica di p. 182: “Eccomi. Blatero di Rainer Maria Rilke sola sanità del mondo, poi non ho le palle di spappolare ogni legame con la letteratura italica e inondarmi di deserti”.
Il problema non è tanto Brullo in sé, la cui persona autoriale è forse infelice, ma ben abitata, quanto la rimessa in auge nel giornalismo culturale di uno stile sguaiato, manicheo e apodittico, esemplificato da tanti articoli di Pangea. Maniera tra profetico e piratesco, in cui non si vede più bene dove starebbe la distinzione fra il politicamente scorretto (del quale Brullo giustamente osserva che «in Italia puoi esser[lo], anzi devi») e il “culturalmente anarchico” da lui auspicato.
In conclusione, caschiamo anche noi nel brullismo di suggerire altre letture, non per disconoscere a questi corsivi corsari la loro ragione e la loro utilità, quanto per allargare lo sguardo ad altri modi di condurre la stessa battaglia, in cui Brullo per fortuna non è solo. Da una posizione tutt’altro che marginale nel sistema culturale, e con piglio meno ‘salvatico’, nel secondo Novecento ha esercitato magnificamente l’arte della stroncatura Giovanni Raboni, i cui interventi sono ora raccolti nell’Oscar Mondadori Meglio star zitti? Scritti su letteratura cinema teatro (1964-2004), a cura di Luca Daino (2019). Alla raccolta raboniana ha dedicato un ampio saggio-recensione Matteo Marchesini, critico che a sua volta sa prendere a picconate gli intoccabili (è tristemente nota l’assurda vicenda editoriale del suo Casa di carte, rifiutato in extremis dal suo primo editore per le stroncature ivi contenute ad alcuni autori pubblicati da quella casa editrice). Marchesini, osservando l’odierna disabitudine alla critica, specifica che intende «la capacità di illuminare una realtà estetica attraverso argomentazioni, intuizioni e idee-forza» (di cui appunto Raboni fu esempio virtuoso), ossia «qualcosa di molto diverso dalle caricature di stroncatura prodotte da certe caricature di Papini». Le seconde non sarebbero che il rovescio della medaglia rispetto alla promozione acritica dei prodotti letterari. Difficile, qui, non pensare proprio a uno stile come quello di Brullo. D’altronde, quando anche la statura degli idoli da abbattere è ben poca cosa rispetto a cento anni fa, i colpi bassi risultano non solo efficaci, ma appropriati.
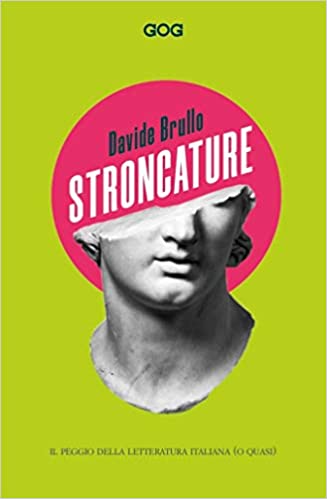
Davide Brullo, Stroncature. Il peggio della letteratura italiana (o quasi), Roma, Gog Edizioni, 2020, pp. 204, € 12.