Le espressioni più interessanti sono certamente quelle intraducibili. Sono tutti quei modi di dire che, per varie ragioni, si sottraggono alla possibilità di farsi trascinare pacificamente da una lingua all’altra, restando degli scrigni magici che possono essere aperti solo da chi è penetrato nelle viscere di una certa cultura.
Un esempio che mi è particolarmente caro è caving in, una strana espressione della lingua inglese. Questo modo di dire è spesso riservato alle manie e alle ossessioni, al concentrarsi in maniera esagerata su qualcosa, qualsiasi cosa. Nel senso più letterale possibile, questo modo di dire significa produrre caverne, accartocciarsi su di sé e divenire un oggetto involuto ed ermetico; viene usato in vari contesti, danzando irrispettosamente dalla depressione più nera fino alla gioia più travolgente, ma porta con sé sempre la stessa criptica immagine: qualcosa che si fa gola, buco nel terreno, lembo di mondo involuto su sé stesso. To cave in significa chiudersi in sé, ma diventando paradossalmente un buco aperto, un recipiente per entità esterne capaci di far sprofondare il soggetto ancora più in profondità. Significa, in altre parole, andare fino in fondo, per sbucare, probabilmente, da tutt’altra parte.
Questo termine conserva per me un valore magico non solo per la sua impermeabilità a ogni traduzione e a ogni domesticazione, ma anche perché è probabilmente una delle poche formule capaci di trattenere in sé l’essenza maniacale e totalizzante dell’esperienza psichedelica. Senza spiegare troppo, affidandosi totalmente all’astrazione e all’immagine mentale, proferire “caving in” significa, in una certa misura, dare corpo e concedere quotidianità a quell’esperienza di riavvolgimento su di sé, di paradossale aperta chiusura, che è, per molti, uno dei tratti distintivi del contatto di una sostanza allucinogena con il proprio organismo. Quando si assume LSD, ad esempio, è comune, seguendo il volere chimico della sostanza, vedere il tempo e lo spazio accartocciarsi su di sé, chiudersi sul malcapitato per divenire un tempo più profondo, striato da arabeschi improbabili. Pronunciare quel modo di dire, termine perfettamente maniacale, è far parlare e rendere comune e condivisa un’esperienza paradossale, ambigua, folle. Un’esperienza che per molti dovrebbe restare ai margini della cultura, della legge e della civiltà e che, per sua natura, riposa ai bordi della vita cosciente. Proferire certe formule magiche significa, in altre parole, documentare e, indirettamente, sperimentare insieme gli effetti, gli affetti e le strane logiche che le sostanze allucinogene fanno patire al corpo umano.
La prima cosa che mi ha colpito de La scommessa psichedelica, antologia curata da Federico di Vita e recentemente pubblicata da Quodlibet, è la fedeltà con cui questo lavoro segue, chiaramente involontariamente, l’esperienza del pronunciare, del rendere pubblico e accessibile la formula magica e i mondi esotici ed estremi del caving in, questo diagramma paradossale che si chiude su di sé per aprirsi ad un mondo più profondo e più misterioso. Sembra quasi che la missione di questo libro, la scommessa che dà sostanza a queste pagine sia divulgare mondi sommersi, tesori inestimabili e sottrarre dall’oblio opalescenze rare, che sfuggono spesso all’occhio umano.
Questo sforzo di salvaguardare ciò che è nascosto e raro parte da alcune contingenze storiche e culturali fortunate. Come è facile dedure dal titolo di questo testo, l’antologia affronta quella che potremmo definire la cultura psichedelica contemporanea, un mosaico di movimenti, molto eterogenei e spesso mossi da obbiettivi e ideologie contrastanti e inconciliabili, che, secondo molti, sta vivendo un inaudito rinascimento – una sorta di seconda giovinezza, tanto nei vari ambiti della cultura e dell’arte contemporanea quanto nella scienza e nella sperimentazione medica. Secondo la vulgata più o meno popolare, infatti, la psichedelia sta attraversando un periodo di rinascita paragonabile soltanto alle Summer of love, culla, prima, del movimento hippie e, successivamente, della rave e club culture, che hanno caratterizzato, fugacemente e con violenza rivoluzionaria portentosa, la seconda metà del secolo scorso. Dopo un lungo torpore, pare che stia davvero iniziando una vera e propria Età dell’Acquario per la ragione umana.
Partendo da questa fortunata congiunzione astrale, il libro si propone, però, un compito ambizioso e difficile. Secondo Di Vita, infatti, la letteratura psichedelica contemporanea si è limitata a ghettizzare il nostro ingresso in questa nuova Età dell’Acquario nelle stanze asfittiche del sapere scientifico e farmacologico, tralasciando gli avvicinamenti più propriamente umani e esperienziali, tanto individuali quanto storici e collettivi, allo strano, l’allucinato, il bizzarro. Rifiutandosi di aderire perfettamente alla sapienza superficiale e spesso puramente clinica e terapeutica del rinascimento psichedelico, La scommessa psichedelica tenta di leggere questo fenomeno portentoso, prima di tutto, in un senso che potremmo definire, pervertendo e brutalizzando il significato propriamente filosofico del termine, fenomenologico e, in secondo luogo, epocale, restituendo al lettore l’epica privata e sconvolgente delle sostanze e la «vicenda millenaria» dei nostri contatti con questo regno alieno e numinoso.
Questa premessa metodologica orienta con naturalezza il testo in due direzioni eterogenee che si intersecano in più punti e che, dal punto di vista della totalità dell’opera, formano una sorta di respiro, ritmando in maniera estremamente gradevole la lettura. La scommessa psichedelica, infatti, si contrae e si distende, alternando riflessioni private, biografiche e irriducibilmente particolari a momenti di grande apertura critica, in cui le sostanze vengono descritte come veri e propri agenti politici sovrastorici, che attraversano e, in un certo senso, guidano la storia della nostra specie sulla Terra. Ravvivando la cosiddetta stoned ape theory di Terence McKenna – teoria secondo la quale l’evoluzione della specie umana è stata fortemente condizionata dal nostro incontro con il trauma e la vertigini indotte dall’assunzione di sostanze psicoattive – l’antologia alterna momenti di autoanalisi e, forse, autofiction individuale e soggettiva, in cui la storia di un ego viene stravolta e riscritta dalla prossimità con la psichedelia, a visioni epocali in cui queste sostanze paiono avere una sorta di agency propria e in cui la storia umana sembra diventare un sistema di contenimento e di diffusione di questi demonietti inanimati.
Si passa, dunque, da testi come quelli di Peppe Fiore e Francesca Matteoni, in cui si analizza, rispettivamente, l’arte di raccontare i propri trip e l’esperienza dell’autrice con l’ayahuasca, la sua storia profonda e il suo «amore ferale», a saggi quasi spaventosi per la portata titanica dei temi trattati, come lo scritto d’apertura di Federico di Vita, che si propone di diagrammare l’intera storia della psichedelia umana, risultando un vero e proprio assalto frontale cognitivo fatto di date, storie e visioni, o il testo, delirante di un delirio che non può che destare ammirazione, di Edoardo Camurri che tenta di tracciare i contorni della guerra spirituale che, occultamente, sconvolge il mondo contemporaneo.
Nel punto medio e all’altezza delle varie intersezioni di queste contrazioni ed espansioni, si annidano, poi, una serie di testi che affrontano l’intersecarsi dell’esperienza psichedelica e psiconautica e il panorama politico contemporaneo, dipingendo un quadro sfaccettato del presente allucinato che ci è toccato in sorte. Fra questi punti di incontro fra il privato, l’eonico e il cosmico, spiccano sicuramente il saggio di Silvia Dal Dosso e Noel Nicolaus, piccolo gioiello di theory-fiction implessa nella critica del reale, in cui si analizza la possibile potenza psicoattiva del cyberspazio e dei meme, ravvivando la famosa massima di Arthur C. Clarke secondo la quale la tecnologia al giusto grado di complessità risulta indistinguibile dalla magia, e la cautionary tale di Vanni Santoni, fiaba inquietante e inquieta la cui morale ci avverte e, forse, profetizza la totale fagocitazione della potenza psichedelica da parte dei mercati.
Proprio, però, su questa inquietudine politica si gioca, a mio avviso, una battaglia irrisolta de La scommessa psichedelica. In questo tipo di considerazioni, assolutamente non rare in questa antologia, si trova una tensione che il testo non risolve, conservandola come una sorta di conflitto interiore nevrotico, e che lascia al lettore come sua posterità problematica. All’interno de La scommessa psichedelica, infatti,sembrano scontrarsi due istanze contrapposte, due fra le molte ad attraversare il movimento psichedelico contemporaneo.
Da un lato, troviamo quella che potremmo definire l’ipotesi progressista, esemplificata dal testo di Marco Cappato sul diritto universale alla psichedelia e da un’affermazione che Di Vita pone come punto programmatico nella sua premessa all’antologia, la quale dovrebbe assumersi il compito di affermare con forza che è «arrivato il momento di dire che “questa non è controcultura, questa è cultura”». Il nucleo teorico della tesi progressista può essere riassunto dalla necessità di includere l’esperienza psichedelica all’interno della cultura mainstream e raccontarla come un momento positivo dello sviluppo della Ragione umana, restituendogli tutta la sua potenzialità terapeutica.
D’altro canto, troviamo, contro questa visione un po’ candidiana, una tesi più cupa, più eversiva e mossa da una, a mio parere, giustificatissima paranoia, difesa in special modo da Santoni e Betti. Secondo questa tesi dark il rinascimento psichedelico, questa piccola rivoluzione sotterranea, si sta già volgendo in una controrivoluzione altrettanto psichedelica, in cui le forze eversive di questo tipo di esperienze vengono riassorbite e messe a buon uso dal sistema capitalistico che le ha inizialmente messe al bando e condannate. Per quanto né Betti né Santoni siano apertamente contrari alla normalizzazione dell’esperienza psichedelica e non neghino l’importanza di una politica psichedelica universale e affermativa, sembrano entrambi scorgere all’orizzonte un senso più sinistro del termine “normalizzare”.
Dietro a questa tesi svetta cupa l’ipotesi che il rinascimento psichedelico non sia altro che una versione particolarmente colorata della cultura del narcisismo descritta da Christopher Lasch, una cultura ossessionata dalla terapia, dall’autopreservazione, dalla guarigione, dal controllo e dal profitto, in cui tutto viene inglobato, domesticato e disarmato a favore del consumo privato. Al culmine del suo radicalismo questa posizione sembra sollevare implicitamente una questione insolubile per La scommessa psichedelica: e se l’estraneità di cui la psichedelia gode rispetto alla cultura e al progresso fosse un bene? Cosa accadrebbe se coltivassimo i margini e la stranezza? E se ce la prendessimo proprio con il progresso in quanto tale, usando la psichedelia come alternativa rivoluzionaria? Che cosa ne sarebbe del rinascimento psichedelico se formassimo controculture secessioniste, più vive e più libere, rifiutandoci di essere fagocitati? Quella volontà di salvaguardare il caved in – ciò che è raro, lo strano e l’allucinato – si ripresenta qui come un monito nero, uno scontro inesausto.
Chiaramente, in un testo antologico così aperto ed esplorativo una tensione del genere risulta estremamente stimolante e spinge il lettore a esplorare recessi ancora più profondi dell’animo umano e della nostra condizione sociopolitica. Lungi dal risultare un limite, questo tipo di attrito rende i saggi dinamici e attuali, materiale con cui vale la pena confrontarsi. Nondimeno, il dubbio sollevato da questo scontro silenzioso rimane, a libro terminato, un mistero insolubile. Forse, in fondo, è giusto che un problema del genere non si risolva fra le pagine di un libro. Probabilmente, il grande merito di questa antologia è di non dissolvere il mistero e il pericolo, di consegnarlo semplicemente nelle mani degli psiconauti e dei proibizionisti che verranno.
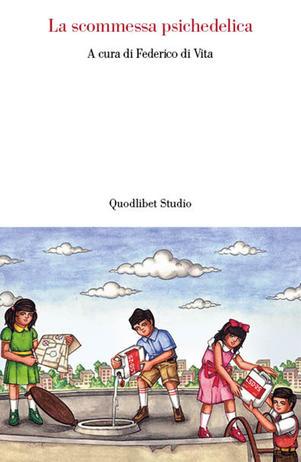
Federico di Vita (a cura di), La scommessa psichedelica, Quodlibet, Macerata 2020, 230 pp., € 18,00.