È il 1942, lo scrittore afroamericano James Baldwin si trova in New Jersey, decide di andare a cenare in un tipico diner americano insieme a un amico, ma i dipendenti si rifiutano di servirlo, lui che è afroamericano. Baldwin viene pervaso da un istinto assassino, «una sensazione fisica, un clic sulla nuca come se la corda interna che collegava la mia testa al mio corpo fosse stata tagliata. […] Ero pronto a commettere un omicidio. Non ci capii molto, ma una cosa la compresi: la mia vita, la mia vita reale, era in pericolo, e non per qualcosa che le altre persone avrebbero potuto fare, ma per l’odio che portavo nel mio cuore».
Lo racconta Baldwin in Notes of a Native Son, un testo critico sul romanzo Native Son di Richard Wright. Nel romanzo di Wright il protagonista afroamericano Bigger Thomas si macchia di omicidio, ma non sa bene il perché («Non volevo uccidere. Ma ciò per cui ho ucciso, quello sono io! Deve essersi acquattato ben dentro di me per spingermi a uccidere»). Quel qualcosa che si è acquattato nella mente del protagonista è lo stesso tarlo di rabbia, paura e umiliazione che ha inquinato l’autocontrollo di James Baldwin nel diner, anche perché «non esiste nessun nero americano che non abbia nel suo cranio il suo privato Bigger Thomas». I testi di Richard Wright sono in genere proprio questo: un’escalation di violenze senza redenzione, un atto compiuto fino in fondo, laddove James Baldwin si ferma a recuperare un cristiano autocontrollo. Per questo le opere di Wright sono la diretta rappresentazione di cosa era e di cosa sarebbe diventato Baldwin senza una paziente opera di continenza delle proprie emozioni. Per questo leggere Wright vuol dire guardare sotto terra, là dove la discriminazione razziale è umbratile e – nello scatto di un momento – sanguinolenta.
Si tratta della stessa realtà sommersa narrata in Otto uomini (Racconti edizioni, 2020), la raccolta di otto racconti che Wright scrisse dal 1937 al 1959, pubblicata nel 1961. La raccolta presenta anche spunti autobiografici dello scrittore, afroamericano del Sud, che nacque in una piantagione nella Contea di Adams, vicino a Natchez (Mississippi); che si trasferì a Chicago e a New York, dove conobbe la discriminazione razziale formale, meno violenta; che aderì al partito comunista per poi staccarsene, che entrò a far parte della “lista nera” del Maccartismo; che finì a Parigi, dove entrò in contatto con l’esistenzialismo, con Camus e Sartre; che visse una vita liminare, da esule cosciente dentro e fuori il cuore di quell’America «troppo giovane e troppo nuova, vigorosa perché sola, aggressiva perché spaventata». Sono racconti di umiliazione, quelli di Wright, di afroamericani che scoprono come il loro valore non coincida con il loro ruolo nella società, pur essendo vincolato a quest’ultimo. Sono racconti in cui capiscono che semplicemente così vanno le cose, che non vale la pena parlarne, ma anche che è impossibile sottrarsi a questa esperienza di riduzione umana: i protagonisti di Wright non riescono mai a realizzarsi come soggetti neutri, come semplici uomini: devono percepirsi costantemente nel segno di una negazione, quella di non essere bianchi, soffrendo l’assenza di una neutralità che, di fatto, non esiste neanche (nemmeno i bianchi sono soggetti neutri, ma hanno il dominio culturale per imporsi come paradigma). I protagonisti di Wright sono costretti a esperire l’impotenza e l’umiliazione del “non potere” (dire, fare, migliorare), in quanto afroamericani. O meglio: potenzialmente possono fare qualsiasi cosa, dire o tacere, a seconda dei casi, ma il gioco truccato trova sempre il modo di riassegnarli alla parte del torto.
Così in “L’uomo che andò a Chicago” Wright porta avanti un vero e proprio studio narrativo sull’incomunicabilità tra l’America bianca e l’America nera. Il protagonista lavora in un negozio di alimentari e, nonostante la disponibilità dei proprietari, ha paura di svelare il reale motivo dei suoi giorni di assenza, legato alla ricerca di un altro lavoro. I proprietari dell’alimentari lo ritengono un bugiardo, lui continua a ribadire la menzogna iniziale perché «mi si palesò davanti che stavano cercando di trattarmi come un pari grado, cosa che mi rendeva ancora più impossibile dirgli che avevo mentito e perché l’avessi fatto. Sentivo che se gliel’avessi confessato avrei dato loro un vantaggio morale che non ero in grado di sopportare». Passa così ad altri lavori, ed approda in un ristorante nel quale si accorge di un fatto: la cuoca sputa nei piatti. Dirlo, non dirlo? Ma lui è un nero, la proprietaria non gli crederebbe mai. Lo confessa allora ad una sua collega afroamericana che decide di denunciare il fatto, consapevole del rischio di perdere il posto di lavoro. «Gliel’hai detto?», «Sì», «E che dice?», «Che sono pazza». La storia prenderà un’altra piega, ma ciò che importa è che Wright puntella con un’altra sfumatura un tema che attraversa tutto il racconto, fino all’evoluzione finale, quando il protagonista – che si chiama proprio Wright – passa a lavorare come inserviente in un istituto di ricerca medica. Qui, a seguito di una lite, lui e i suoi colleghi afroamericani inquinano per errore i test di laboratorio che, non a caso, si trovano in un seminterrato. La questione muore lì, nessuno confessa, ma il punto è che nessuno vuole farlo: ciò che accade di sopra, nella comunità scientifica dei bianchi, in fondo non li riguarda. Tutti hanno raggiunto lo stadio ultimo dell’esclusione. Il ponte è tagliato, il sotto terra è pienamente abitato, un non-luogo in cui il nero non è più esposto all’angoscia dell’errore, in cui non è più costretto a confrontarsi con i bianchi, e quindi con il ronzare dei propri sentimenti da afroamericano, con il disprezzo auto ed eterodiretto.
L’unico scopo di vita diventa il sottrarsi a quello sguardo bianco, a quel gioco a perdere che invade ogni aspetto del vissuto, dall’economia alla sessualità. Anche perché sia il ribaltamento esplicito di valori che la completa adesione ai diktat discriminatori si rivelano fallimentari. Così accade, per esempio, in ambito economico. In “L’uomo che visse sottoterra”(questa volta il carattere sotterraneo dell’esistenza è esplicito), il protagonista si rintana nelle fogne per sfuggire a un’ingiusta accusa di omicidio. Saltuariamente riemerge nel mondo “reale” per sottrarre simboli da risemantizzare: in superficie ruba dei dollari che poi, in uno stato di delirio, utilizza per arredare la parete della fogna. Un ribaltamento simbolico che cerca anche di confessare “al mondo di sopra”, ottenendo in cambio altra derisione e violenza. All’inverso, in “L’uomo che vide l’alluvione”, il protagonista è completamente assoggettato allo status quo economico, ed è costretto a sottomettersi doppiamente alla subordinazione a cui era stato predestinato: non solo si trova alle dipendenze di un proprietario bianco, ma è anche costretto a pagare sulla sua pelle gli effetti disastrosi della catastrofe naturale, indebitandosi con il padrone. Sia il ribaltamento esplicito che la totale adesione alle regole del gioco trascinano il nero dalla parte del torto.
Perché il baricentro attorno a cui è ingrassata la giovane America non è nei valori assoluti di bellezza e giustizia, ma negli inossidabili rapporti di forza tra bianchi e neri. Un’America ancora troppo fragile per fare a meno della forza, ancora troppo giovane per lasciar andare lo schiavismo, il suo peccato originario. La violenza sessuale, in questo quadro, diventa un altro modo per detonare ciò che risiede sotto l’opprimente convivenza che stringe e costringe le due Americhe, per rompere le righe in «questo persecutorio senso di irrealtà». In “Un uomo tuttofare” un afroamericano si traveste da donna per ottenere un lavoro da badante, per sostentare la propria famiglia («Chi ci guarda mai così da vicino a noi di colore, eh? Per i bianchi siamo tutti uguali»). Torna il ribaltamento delle regole. Tuttavia, il suo travestimento da donna lo renderà vittima di tentativi di violenza da parte del padre di famiglia bianco. Altra umiliazione, altra subordinazione sessuale al genere e alla razza. In “L’uomo che uccise un’ombra”, invece, Saul trova lavoro come inserviente in una biblioteca. Saul beve, perché l’alcol gli permette di diventare un soggetto neutro. Un giorno, la bibliotecaria prova a spingerlo ad avere una relazione sessuale, forte della sua superiorità da donna bianca. Lui, che conosce bene le regole del gioco razziale e non vuole cadere nel tranello, è «così frastornato, umiliato e impaurito» che comincia ad «arrabbiarsi», cedendo alla violenza cieca. La rabbia sale dal carattere contraddittorio di un’America che gli intima di non avvicinarsi alle ragazze bianche e, allo stesso tempo, di soddisfare, come uno schiavo, coloro che pretendono un rapporto sessuale. L’unica soluzione, a quel punto, è stracciare la tela del reale e cedere alla violenza.
Quella di Wright, però, è quasi sempre una violenza raggelata, un errore o una confusa liberazione. Non è mai odio personale o perverso desiderio di sangue, è piuttosto il prevedibile epilogo di un sottile strisciare di umori, pregiudizi, parole non dette, relazioni troncate dalla barriera della razza. È un incordarsi di nervi nell’acme delle storie personali e sociali, il famoso «clic» di cui parlava Baldwin. Per Wright, infatti, la questione razziale non si traduce in manifeste etichette ghettizzanti, in brutalità storiche ed esterne, ma in questa continua interazione strozzata, nelle paternalistiche pacche sulle spalle da parte dei bianchi e nel silenzio pieno del nero. Per questo nei racconti di Wright il razzismo appare con i connotati di un filtro gnoseologico, di un modo di agire e percepire le relazioni. Tutto questo sostrato si traduce in una «distesa di sofferenza inconscia», in umiliazione, paura di sbagliare, difficoltà a comunicare e decodificare, un costante stato di minaccia che punzecchia ogni azione di ogni afroamericano, e che rischia di trovare nella violenza il suo epilogo. Quando agita dai bianchi, invece, la violenza assume i connotati di uno scherzo, di una farsa in cui, per puro caso e senza troppi problemi, un nero ci ha rimesso la pelle («Dai, Elsie, non è morto. Meglio tastargli il polso. Non l’avevo mai fatto a un negro, prima d’ora»). Wright segue le pieghe di questo dipanarsi di sentimenti incrociati, accompagna la narrazione fino al punto estremo, quando il clic scatta, il pavimento si macchia e tutto si risolve in una bianca alzata di spalle o in un liberatorio distacco dalla realtà.
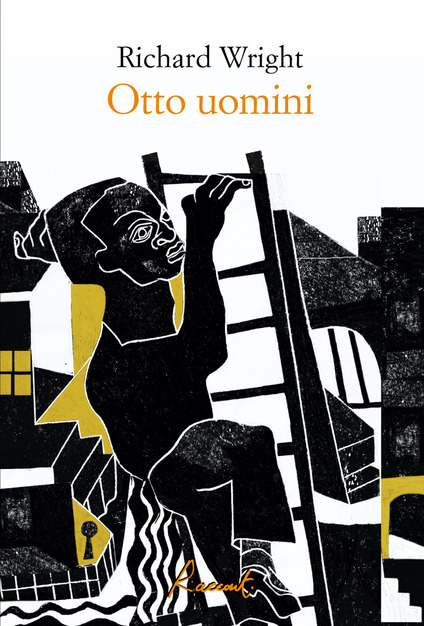
Richard Wright, Eight Men (1961) – trad. it. di Emanuele Giammarco, Otto uomini, Roma, Racconti Edizioni, 2020, pp. 281, € 18.