Quando si parla dei morti, quando si è chiamati a restituirne un ricordo, fosse anche solo un minuscolo tassello, bisogna prendere le misure. È necessario ricostruire i tempi e le circostanze, distaccarsi quel tanto che basta a non cedere alla tentazione di abbandonarsi a facili sentimentalismi. «L’unica cosa importante in questo tipo di ritratti scritti è cercare la distanza giusta», scrive Emanuele Trevi nel suo Due vite (Neri Pozza, 2020), con cui omaggia gli amici e scrittori Rocco Carbone e Pia Pera, entrambi scomparsi prematuramente.
Di Carbone viene anzitutto evocato il bisogno quasi disperato di ridurre ogni cosa ai minimi termini, di ricorrere al senso esatto delle parole per cercare un mezzo di contrasto al «manierismo, alla complicazione» con cui da sempre si era visto costretto a combattere. Carbone era un nato sotto Saturno, perennemente in affanno e spinto dall’urgenza di rispondere alla propria insoddisfazione. Sul finire degli anni Ottanta il mercato editoriale comincia a trasformarsi, seguendo la scia di un cambiamento che Trevi definisce «rapido e irreversibile» e alla luce del quale l’esordio narrativo di Rocco Carbone (Agosto, Theoria 1993) correva il rischio di passare in sordina o di sembrare un prodotto letterario invendibile perché troppo «all’antica». Chi scriveva tentava allora di seguire e d’imitare il parlato, adattava cioè la scrittura ai ritmi, ai tempi, agli usi dell’oralità. La lingua di Carbone era invece una lingua «totalmente scritta», che si era creata in un periodo in cui l’attenzione letteraria era rivolta al processo piuttosto che al prodotto, e la sua era una scrittura controllata, guidata da un principio di uniformità.
Quello che per tutta la vita Carbone aveva inseguito era un processo di semplificazione che, pur con tratti diversi, lo accomunava all’amica Pia Pera. Slavista e traduttrice affermata — ricordiamo le sue versioni dell’Onegin di Puskin e di Un eroe del nostro tempo di Lermontov —, Pera esordisce come narratrice nel 1992 con la raccolta La bellezza dell’asino. A cinquantacinque anni, ovvero alle prime manifestazioni della malattia (Pia Pera morirà di SLA nell’estate del 2016), la scrittrice aveva iniziato a dedicarsi a una «pulizia interiore», a una forma di resistenza cocciuta e solitaria, e questo la faceva apparire agli occhi di molti improvvisamente lontana dalla timida sfrontatezza che ne delineava il carattere nei ricordi giovanili. Al giardino ancora non l’ho detto, pubblicato da Ponte alle Grazie nel 2016, racconto che Trevi ha definito «un finale di partita», è la cronaca della malattia che l’aveva progressivamente obbligata a rinunciare al contatto con quello spazio di terra — il suo giardino, appunto — a cui si era dedicata, negli ultimi anni, totalmente, pensandolo non soltanto come un passatempo, ma come una filosofia.
Quello di Trevi è un esercizio della memoria che costa fatica e lo costringe a procedere per sottrazione: l’autore è a volte parte integrante del ricordo e nella narrazione si fanno spazio le immagini dei giorni trascorsi tutti e tre assieme – come quella fotografia scattata da Rocco Carbone che lo ritrae al fianco dell’amica Pia, parte di una serie risalente alla fine degli anni Ottanta in cui i tre si erano alternati dietro all’obiettivo, lasciando a rotazione gli altri due al centro delle immagini –, più spesso invece osserva gli amici dall’esterno, tirandosi abilmente dentro e fuori dal ricordo. E se la fotografia, così legata all’istantaneità e all’immediatezza, illude soltanto di immortalare e si rivela il mezzo che più di ogni altro può ricordarci la nostra «transitorietà e futilità» – col solo merito, quindi, di rendere visibile e meno aleatorio o passeggero un aspetto permanente di chi è ritratto – la scrittura, al contrario, appare come uno strumento «singolarmente buono per evocare i morti». La letteratura, infatti, tende a procedere per sequenze, seguendo un ordine di volta in volta stabilito da chi scrive e non può godere di quel principio di simultaneità della visione che, per definizione, appartiene invece alla fotografia o alla pittura. Ma i morti, sostiene Trevi, sembrano essere attirati dalla scrittura e sono quindi capaci di farsi largo tra le righe, di «affiorare nelle parole».
Quando si parla dei morti, però, bisogna pure farci i conti. Si arriva allora al momento del confronto e si pesano gli errori, gli screzi, i momenti di distacco. Si corre persino il pericolo di interpretare certi avvenimenti come dei segni premonitori, delle avvisaglie celesti e cupe. L’uccello sospeso a mezz’aria che dà due colpi d’ala prima di schiantarsi al suolo, la macchina di Rocco Carbone rubata pochi giorni prima dell’incidente che gli è costato la vita: è facile ricondurre tutto a una fatalità, a un destino ineluttabile e avverso.
Un peso specifico maggiore, qui, ce lo ha l’amicizia, quei legami affettivi che, come ha detto Trevi in un’intervista rilasciata a Claudio Marrucci per minima&moralia, «sono l’unica realtà del mondo» e si basano sulla totale mancanza di interessi, fondandosi invece su pilastri di fiducia, gioco e un ampio campo lasciato alle emozioni. Sia Rocco Carbone che Pia Pera sembravano possedere una propensione naturale, un vero e proprio talento per l’amicizia. Spesso burrascosa e intermittente, l’amicizia resta anche per Trevi un tarlo che scava e s’insidia tra i ricordi: c’è soprattutto l’ombra lunga degli eterni confronti, dei litigi testardi e privi di senso, e poi c’è l’amicizia codificata, quella che poggia su leggi non scritte e accordi taciti di una promessa fedeltà. Al contrario degli amori, che si erano presto rivelati sfortunati per entrambi, Rocco Carbone e Pia Pera erano quegli «innumerevoli esseri umani» a cui «è dato questo destino, di ottenere molta più felicità dall’amicizia che dall’amore».
A un certo punto del libro, invece, quando si è già raggiunta la giusta familiarità con la dimensione memoriale e con l’immagine degli amici di cui racconta vita e affetti, Trevi dice che «scrivere di una persona reale e scrivere di un personaggio immaginato alla fine dei conti è la stessa cosa» e il confine tra questi due aspetti – che appare qui tanto labile – e questa frase che potrebbe persino cogliere alla sprovvista o sorprendere chi legge, sono parte di una premessa che implicitamente Trevi offre al lettore. Due vite si colloca forse a metà tra il memoir e l’autofiction e così anche l’“io” con cui Trevi sceglie di raccontare le storie degli amici Pera e Carbone, un soggetto distante da quello dell’autobiografia classica, che decide di non mettersi al centro ma di restare ai margini. Trevi racconta da fuori, resta in disparte, e lo fa con la stessa cautela dimostrata anche dopo la morte dell’amico, quando decise di farsi carico della curatela del suo romanzo incompiuto (Per il tuo bene, Mondadori 2009), esercizio che lo obbligò a sostituirsi a Carbone, «a essere una specie di protesi di Rocco, una sua propaggine nel mondo dei vivi» per colmare i vuoti del testo e rimettere ordine senza per questo prevaricarne la mano. Se l’atto di pensare gli amici corrisponde necessariamente anche a emanare una proiezione di sé, scriverne significa per Trevi non soltanto essere in grado di evocarli, ma riuscire persino a sentirli presenti, a instaurare con loro un dialogo, a tessere un racconto cui non potrebbero dirsi contrari.
Già con Sogni e favole (Ponte alle grazie, 2019) Trevi ci aveva regalato dei ritratti, ma lo sguardo era allora rivolto alla generazione precedente, quella dei maestri Cesare Garboli e Amelia Rosselli, tra gli altri. In Due vite, invece, il tempo della memoria è ancora vivido, è cioè il tempo della contemporaneità, e la generazione rappresentata, quella degli amici, rivela che un altro tipo di insegnamento, tra pari, è possibile. Trevi parla infatti di una forma di reciproco incoraggiamento, un confronto imperituro sulla scrittura, che aveva spesso a che fare anche con grandi momenti di abbattimento.
Le due vite che Trevi delinea, quelle dell’«adorata» Pia Pera e dello «spigoloso» Rocco Carbone, che tra queste poche pagine riescono nuovamente nell’impresa di incontrarsi, sono anche il pretesto per aprire a una riflessione più ampia sulla letteratura come vita e questo libro, che oscilla tra il saggio e la narrazione più intima, e sembra quindi tanto difficile da incastonare in un unico genere, equivale a un momento di liberazione, a un’esperienza di guarigione, a un modo di evocare i morti per poi lasciarli andare.
Illustraziione header: Kazimir Malevič, Sportivi, 1930-1931, Olio su tela, 142 x 164 cm, Museo di Stato Russo, San Pietroburgo.
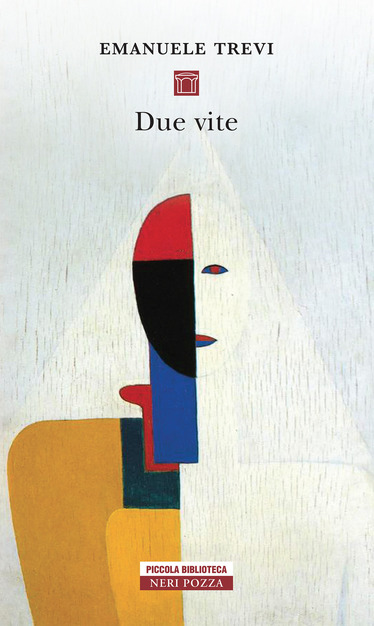
E. Trevi, Due vite, Vicenza, Neri Pozza, 2020, 144 pp., € 12.