La Balena Bianca sospende anche quest’anno le pubblicazioni fino a settembre. E anche stavolta non potevamo mancare di congedarci dai nostri lettori con i consigli di lettura estivi di redattori e collaboratori. In agosto vi terremo compagnia sui nostri social, riproponendo alcuni tra i contenuti più significativi dell’ultima stagione. Ci prendiamo una pausa, ma siamo già al lavoro per settembre. Buone vacanze dalla ciurma!

Calusca City Lights, radiocane.info (a cura di), Riot! George Floyd Rebellion 2020. Fatti, testimonianze, riflessioni, Edizioni Colibrì (Massimiliano Cappello)
«Voce d’un’enciclopedia del presente ancora da scrivere» (p. 8), Riot! intende presentarsi in termini a un tempo autoesplicativi e insufficienti. Autoesplicativi, perché tenta di cortocircuitare la mediazione del libro per restituire l’intensità e l’impellenza di un evento qual è (è stata? Sarà?) l’ondata di insorgenze, pratiche e tentativi di trasformazione delle vite individuali e collettive scaturite dal maggio scorso negli Stati Uniti d’America. E insufficienti, perché non bastevoli a racchiudere per intero la ponderata ‘composizione’ del volume, né tantomeno lo sguardo gettato dai curatori su quanto ha reso visibile, una volta di più e immediatamente, la difficoltà o l’inconsistenza di una rigorosa rappresentazione in due tempi della rottura rivoluzionaria e della spinta reazionaria. Le tre sezioni di Riot!, corredate di numerosissimi reperti fotografico-illustrativi e Approfondimenti – sotto forma di schede di lettura, specchietti, memoria mandae, utili a situare e comprendere ad ogni livello la ‘situazione’ –, si propongono infatti di scandire e di rendere intelligibili al lettore, senza alcun ordine gerarchico, altrettante temporalità. Il «qui e ora» della rivolta colto in Cronologia e corrispondenze – che ricorda, per impatto grafico e rinuncia all’esaustività documentaria, il John Reed dei Dieci giorni che sconvolsero il mondo; il «durante» e il «dopo» delle Analisi e riflessioni tenutesi su Illwill, sito di «analisi partigiana del presente»; e infine il suo «prima», per tramite di uno Sguardo telescopico: una certosina operazione di recupero di testi più e meno introvabili da un passato che – per dirla ancora una volta con quel Walter Benjamin che chiude il volume – non è chiamato a gettare la sua luce sul presente, ma ad unirvisi fulmineamente in costellazione.

Valentina Della Seta, Le ore piene, Marsilio (Lorenzo Cardilli)
Le ore piene: succoso e perverso esordio di Valentina Della Seta, un po’ Bildungsroman della crisi di mezza età, un po’ scorciato prontuario BDSM, in cui l’esplorazione del sadomasochismo sfuma nell’introspezione. Estroflessa nelle cose, però; mentre la vicenda è guarnita da vaghi sentori di allarme climatico e di classe disagiata, saggiamente relegati sullo sfondo, del tutto sottomessi alle urgenze fisiche e psicologiche. L’ansia “iperrealista” della protagonista, insieme alla secchezza quasi alienata che la scrittura assume nelle scene più scabrose, scansano ogni sensazionalismo da Fifty Shades of Gray. Nessuna discesa agli inferi, mettiamo in stile La vita oscena: un’espansione sofferta, invece, delle possibilità dell’eros e del sentimento.

Anna Wiener, La valle oscura, tr. it. di M. Z. Ciccimarra, Adelphi (Massimo Cotugno)
Diversamente da quanto la copertina suggerirebbe, il volume di Anna Wiener è un memoir sull’umano, più che sul post-umano. L’autrice, inviata sui temi della tecnologia per il «New Yorker», racconta i suoi cinque anni trascorsi a San Francisco nella piena espansione dell’ecosistema di startup della Silicon Valley. Ci restituisce un ritratto della città come assurdo acquario in cui la vita segue ritmi e regole diverse da quelle ordinarie, specie se lavori per un rarissimo unicorno, ovvero una startup valutata più di un miliardo di dollari. Anna Wiener ci introduce negli headquarter di questo sistema, tra mansioni insolite se non insensate, interrogativi sulla (opaca) gestione dati, e sviluppatori che dormono pochissimo e assumono sostanze nootrope per migliorare le prestazioni. A rendere speciale questa cronaca dal mondo iperdigitalizzato è lo stile ironico di un’ex assistente di una casa editrice, con formazione umanistica, che si ritrova nel paese dei big data quasi per caso e che per questo è in grado di osservarlo senza finirne risucchiata.

Gilberto Severini, La sartoria-Il praticante, Playground (Michele Farina)
La casa editrice Playground perdura nello sforzo di riproporre le opere di Gilberto Severini, uno dei più dotati e sottovalutati narratori italiani viventi. La sartoria-Il praticante riunisce in volume due romanzi brevi dello scrittore di Osimo, già pubblicate nel 2001 e nel 2009, che vanno a comporre un dittico tenuto insieme, oltre che dal fondale comune a molte sue prove – la provincia marchigiana nei decenni successivi al secondo dopoguerra – dal personaggio di Carletto, che vediamo apprendista presso la sartoria del paese nel primo pannello e che ritroviamo giovane uomo, diviso tra pulsioni identitarie e imposizioni sociali, nel secondo. Carletto, tuttavia, è solo uno dei profili più in rilievo di un intarsio di episodi cuciti con deboli fili di trama e finemente assemblato da Severini, il quale illustra, con una lucidità e un’ironia che mai tracima in sprezzatura, le letali piccinerie di una piccola borghesia in ogni senso provinciale. Fatalmente attratti da tutto ciò che è banale, i pudici narratori di Severini sono sempre in grado di occultare una lieve magia sotto la superficie delle micro-vicende in apparenza più quotidiane, insignificanti e proprio per questo più simili a noi: «In quell’anno ho imparato che per non annoiarsi bisogna stare sempre attenti ai particolari e confrontare continuamente tutto con tutto. È così che ci si rende conto che si è circondati da misteri».

Edgardo Franzosini, Sul Monte Verità, Il Saggiatore (Giulia Marchina)
È una quest del tutto inusuale quella che si snoda nel romanzo di Edgardo Franzosini Sul Monte Verità, recentemente riedito per Il Saggiatore; nei primi decenni del Novecento, nei pressi di Ascona, sulla collina di Morescia, ribattezzata Monte Verità, il gradevole microclima e l’inconsueto magnetismo del luogo avevano attratto una moltitudine di personaggi eterogenei: eremiti, teosofi, poeti, anarchici, psicoanalisti, massoni, nudisti, vegetariani, utopisti di ogni sorta, in altre parole, “un gran calderone di matti”. Ad Else Beer, ultima testimone di quella proto-colonia hippie, viene affidata la ricostruzione della vita di Alceste Paleari, colui che in quel luogo aveva fondato un personale culto della noce di cocco ed era stato trovato morto, in circostanze misteriose, ai piedi della sua palma il 15 giugno 1933. L’indagine implica un continuo movimento narrativo lungo le linee di campo che attorno a Paleari disegnano coloro che egli aveva incontrato nelle sue peregrinazioni europee e soprattutto coloro che avevano abitato con i loro corpi nudi e i loro spiriti assoluti il Monte Verità. Non si può non essere incuriositi da questo libro, che, per dirla con Tabucchi, come un “baule pieno di gente” ci accompagna nei nostri viaggi estivi, abbracciandoci nella grazia della scrittura di Franzosini in un girotondo, proprio come quello che nelle pagine finali torna nell’opera realizzata da Elisàr von Kupffer, il polittico Il Chiaro Mondo dei Beati, al centro del quale campeggia nientemeno che una mistica palma.
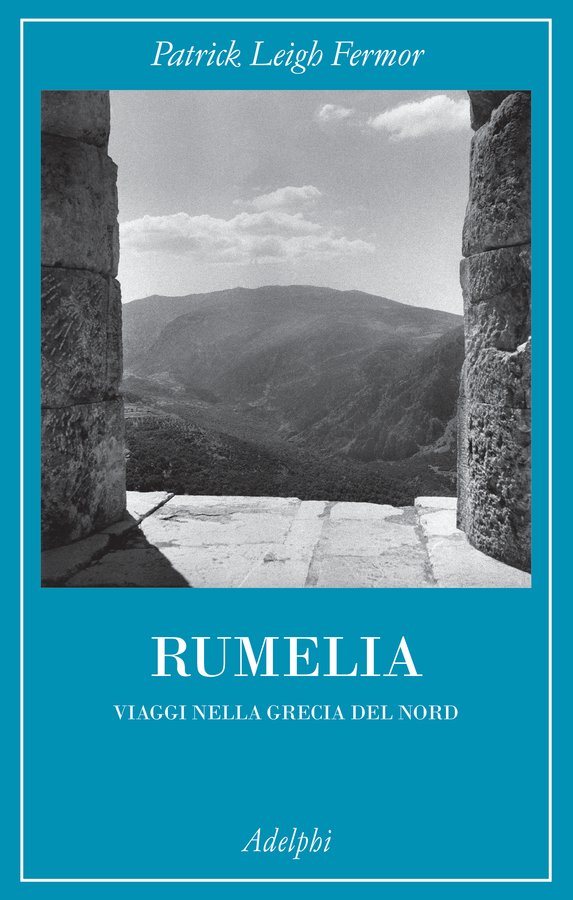
P. L. Fermor, Rumelia. Viaggi nella Grecia del nord, tr. it di D. V. Filippi, Adelphi (Cecilia Monina)
Il nome Rumelia è ormai assente dalle carte geografiche, eppure è rimasto legato a un territorio pressoché determinato, a una regione collocabile nel nord Grecia che col tempo ha visto mutare la propria estensione e i suoi possibili confini. I vagabondaggi di Patrick Leigh Fermor raccolti in questo libro ci parlano di una Grecia diversa da quella che potremmo conoscere oggi se la attraversassimo in viaggio: non ancora toccata dal turismo, incontaminata, spesso narrata attraverso le voci dei suoi abitanti, percorsa seguendo le tracce della storia e le sue rovine, lungo gli stessi luoghi in cui Byron aveva saputo intravedere gli «indizi di una futura resurrezione» e lì dove la mitologia era stata capace di affondare le proprie radici e dare spazio a storie drammatiche e leggendarie sopravvissute al tempo. Una guida e un’ode a una terra che cambia e il cui suono somiglia allo «stridore delle cicale», allo «scatto degli anemoni che sbocciano», allo «schianto di un pilastro che crolla».

Federica Castelli, Comunarde. Storie di donne sulle barricate, Armillaria (Martina Neglia)
Non sono pochi gli omaggi e le riflessioni sulla Comune di Parigi arrivati quest’anno in concomitanza con il centocinquantesimo anniversario dall’esperienza parigina. Federica Castelli con il suo Comunarde. Storie di donne sulle barricate si inserisce in questa scia con un posizionamento dichiaratamente femminista, «situato, imperfetto, appassionato». Partendo da quell’alba del 18 marzo 1871 quando le donne parigine si frapposero fra i soldati del governo Thiers e le armi, facendosi soggetto imprevisto che irrompe nella storia, l’autrice ricostruisce e restituisce quei due mesi di auto-governo nella complessità delle varie posizioni e nella «trasversalità del patriarcato» anche all’interno di un progetto comune. Raccontare la Comune attraverso le comunarde, con e oltre il volto-simbolo di Louise Michel, vuol dire infatti spezzare l’invisibilità di un’esperienza plurale e sessuata di tutte loro, spesso offuscata da quella strategia patriarcale che ne ammette una per poterne dimenticare cento. Castelli ci accompagna così nelle sue riflessioni sulla posizione delle donne nelle lotte e nello spazio pubblico, soffermandosi più volte sull’immaginario che concede loro possibilità dicotomiche: o sante o isteriche che hanno perso ogni forma di ragione. Priva di qualsiasi sguardo eccessivamente nostalgico o sovradeterminante, l’autrice non chiude il suo percorso all’interno della Comune con un punto fermo, ma anzi tracciando un percorso che ci porta fino a oggi, aprendo domande, condividendo i suoi interrogativi, accogliendo l’eredità che le comunarde ci hanno lasciato in termini di conflitto e rivolta.

Anne Carson, Economia dell’imperduto, tr. it. di P. Ceccagnoli, Utopia (Stella Poli)
«Cosa resta delle parole che restano? Qual è il profitto della poesia? Come quantificare un linguaggio fatto di durata e dispersione, esposto alla perdita eppure […] unverloren, non del tutto perduto? Come interrogare la realtà e l’irrealtà del denaro, la visibilità e l’astrazione del concetto di merce a fronte della realtà-irrealtà della parola?» così Antonella Anedda ci introduce Economia dell’imperduto, saggio eterodosso, tradotto da Patrizio Ceccagnoli, di una delle figure più interessanti del panorama contemporaneo: Anne Carson. Poetessa, narratrice, saggista, in questo libro – come in Albertine workout (tlon) o in Autobiografia del rosso (La nave di Teseo) – è inscindibilmente le tre cose insieme e, mentre ricostruisce la figura di Simonide o parafrasa Celan, il ritmo delle sue frasi, le sue acutezze, la sua «imperscrutabile brillantezza» incantano.

Andrea Tarabbia, Il demone a Beslan, Bollati Boringhieri (Matilde Quarti)
A febbraio 2021 Bollati Boringhieri ha riportato in libreria Il demone a Beslan di Andrea Tarabbia, in un’edizione riveduta e, in alcuni punti, corretta dall’autore (ma assolutamente non riscritta). Uscito per Mondadori nel 2011, è il primo romanzo-romanzo (come direbbe Simenon) di Andrea Tarabbia, pubblicato dopo La calligrafia come arte della guerra (Transeuropa, 2010) e Marialuce (Zona, 2011), in realtà scritti mentre già era in lavorazione. La trama è immediata: Tarabbia segue l’assalto alla Scuola n.1 di Beslan, in Ossezia, del primo settembre 2004 da parte di un gruppo di separatisti ceceni. La storia la conosciamo tutti, così come ne conosciamo il drammatico epilogo. Quello che anima Tarabbia, infatti, non è la necessità di raccontare un fatto di cronaca, quanto la sua trasmutazione in una riflessione dolorosa sui meccanismi umani e storici che si nascondono dietro le manifestazioni più assolute del “male”. È il primo tassello di un percorso di indagine sulla genesi di questo male che Tarabbia proseguirà con Il giardino delle mosche (Ponte alle Grazie, 2015) e Madrigale senza suono (Bollati Boringhieri, 2019). Tarabbia, come farà anche successivamente, utilizza i vuoti della cronaca per ipotizzare, immaginare, costruire una verità romanzesca capace di illuminare la realtà storica, dalla fase di progettazione dell’attentato a quello che accadde nella scuola e che è rimasto fuori dalle cronache ufficiali. Un romanzo letterario nello stile (nonostante l’autore dia voce in prima persona a una trasfigurazione dell’unico terrorista sopravvissuto, di cui al momento della stesura non si avevano notizie certe), in cui l’ombra riesce sempre ad avere la meglio sulla luce, dostoevskiano nelle declinazioni del concetto di colpa.
Interessanti due approfondimenti che Tarabbia ha dedicato al romanzo (si trovano entrambi sul suo blog, qui e qui).

Paolo Milone, L’arte di legare le persone, Einaudi (Giacomo Raccis)
Paolo Milone è uno psichiatra genovese, classe 1954, e ha deciso di scrivere un libro per raccontare, dal proprio privilegiato punto di vista, la sua lunga esperienza tra Centri di Salute Mentale (creati all’indomani della chiusura dei manicomi) e reparto di Psichiatria d’urgenza. Ed è una fortuna. Perché Milone ha il dono della scrittura; e di una scrittura riconoscibilissima, diretta, che si dipana per minime scaglie di racconto, aneddoti, lampi, aforismi che tentano di restituire la varietà di forme che assume il rapporto tra medico e paziente nella cornice della cura mentale. Milone dà del tu a tutti, creando un’immediata empatia con chi vive trincerato dall’altra parte; smaschera i pregiudizi e le paure che condizionano anche chi dovrebbe saper vedere oltre i sintomi della differenza e attenuare il disagio della distanza («A conoscere qualcuno, si hanno dei doveri./ Meglio non conoscere nessuno»). L’ironia è tagliente e non risparmia nessuno; le tonalità emotive le più variegate. Talvolta l’ostinazione anticonformista si traduce in una nuova “retorica”, ma è un peccato veniale, perché L’arte di legare le persone riesce a darci la temperatura di un territorio di confine in cui un manipolo di passeur cerca quotidianamente di portare viveri dall’altra parte, per garantire la sopravvivenza di chi, in qualche modo, è destinato a cavarsela da solo. «Filippo, tu che ce l’hai fatta a passare,/e ora sei tutto graffi, sporco, sudore, dimmi com’è di là./Di là dove non c’è ragione./Io curo grandi mappe della frontiera. Per quali sentieri nascosti, per quali valichi, gole, precipizi, sei riuscito a passare? Dimmi com’è di là».
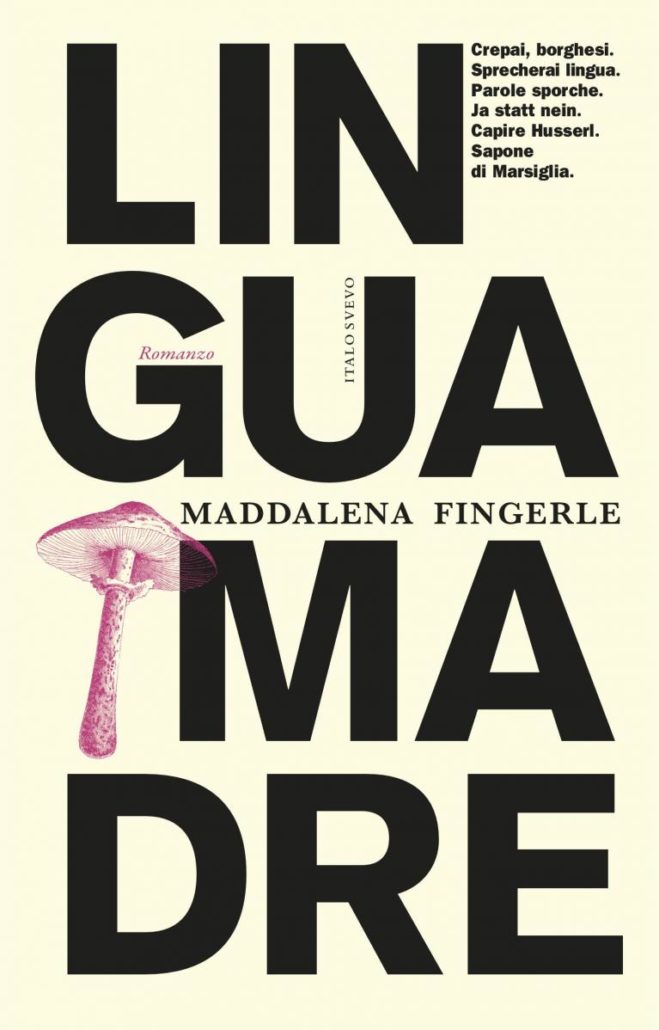
Maddalena Fingerle, Lingua madre, Italo Svevo (Giulia Sarli)
Romanzo vincitore del Premio Calvino 2020, Lingua madre di Maddalena Fingerle è la storia di uno spaesamento che si declina nell’idiosincrasia per la lingua materna, una lingua parlata, sporca, sempre distratta dalla verità delle cose. La sua miccia è in un trauma che insorge nel padre del protagonista: un incidente, una donna morta, un uomo che per senso di colpa diventa muto e prova un suo tentativo di cura. Scrive su delle etichette nomi che poi attacca agli oggetti corrispondenti, riportando così le parole alle cose, in un processo onesto a cui sempre dovrebbe tendere la scrittura. Fa venire in mente il film Sacrificio di Tarkovskij, in cui un bambino senza voce pianta insieme al padre un albero secco, sperando che innaffiandolo ogni giorno esso possa rifiorire. In Lingua madre il figlio riceve dal padre in eredità il suo dolore e si promette di guarirlo cercando una lingua pura, senza rendersi conto che la sporcizia che sente è tutta interiore. La voce narrante, in prima persona, aderisce ai cambiamenti psicologici e anagrafici del protagonista, muovendosi per ripetizioni che performano la forza invasiva dell’ossessione. Un’ossessione che Paolo Prescher porta fin nel nome, anagramma di “parole sporche”. Quello che potrebbe essere un racconto di formazione si trasforma in una tragedia che segue la rotta ciclica degli spostamenti di Paolo: Bolzano, Berlino, Bolzano, città coprotagoniste a pieno titolo del romanzo. L’odio per la propria identità, in cui echeggia il Bernhard di Estinzione, ha qualcosa di terribilmente attuale. Le parole creano un immaginario condiviso. Il senso di sporcizia del protagonista è espressione di uno scacco che l’uomo ha subito nei confronti di un mondo in cui tutto è capitalizzato, anche la lingua materna. Paolo Prescher è un uomo in rivolta. La sua condanna è la nostra.

Thomas Bernhard, Ungenach. Una liquidazione, tr. it. di E. Bernardi, Adelphi (Marcello Sessa)
Per segnare le imprevedibili tappe dello sviluppo pandemico, Adelphi ha scelto sintomaticamente Thomas Bernhard per due anni di seguito. Nel 2020 Midland a Stilfs (1971) è stato per molti il giusto farmaco – in senso etimologico: a un tempo cura e veleno – da assumere alla fine del primo confinamento. Quest’anno, altrettanto, l’estate adelphiana è bernhardiana. Quasi a voler stemperare il darsi parentetico della stagione, come momento di apparente sospensione della malattia dall’orizzonte fenomenico, si ristampa Ungenach (1968). È un racconto breve che funziona come esauriente cartella clinica della scrittura del primo decennio creativo di Bernhard. La storia è ritmata da molti dei suoi leitmotiv: due fratelli (Amras, 1964, è ineludibile precedente), i loro luoghi originari, i loro viaggi, un suicidio, la morte. Insomma è un pretesto non solo per ricordare che l’esistenza – e con essa la letteratura – è, secondo l’autore, malattia e perenne esperienza della soglia estrema, ma che la scrittura stessa, per tale motivo, incarna ogni volta l’incerto “andare” (gehen) del corpo e dei nervi verso la loro possibile “liquidazione”. Il mondo è sempre potenzialmente infetto: è l’ammonimento di Bernhard; e quali tempi migliori di questi per farne tesoro.
L’illustrazione in copertina è di Massimo Cotugno.