La mia copia di Intercalari, esordio poetico di Marina Gogu Grigorivna, ha solo mezzo colophon. Quando ho chiesto all’autrice di farmi una dedica, senza batter ciglio ha strappato la metà destra del frontespizio e se l’è mangiata davanti a me.
Penso che chi conosce Marina abbia gioito per la pubblicazione di una raccolta che, grazie alle cure di Prospero Editore, consegna alla posterità una prima evidenza di un talento che poteva rischiare di restar confinato alla tradizione orale. Chi la conosce, al tempo stesso, poteva legittimamente temere che l’unicità della persona (prima ancora che della performer incisiva e spiazzante) si perdesse sulla carta, e che della sua voce, separata dalla sua corporeità, restasse solo l’eccentricità sgrammaticata. Non sono la persona giusta per dire se quel rischio sia stato scongiurato, perché ovviamente mi è impossibile leggere le poesie senza sentirle dette da quella voce: ma penso che la loro forza intrinseca troverà il modo di imporsi anche ai lettori che non hanno ascoltato l’autrice dal vivo.
Questo umile libretto, non a caso, si presenta corazzato di paratesti critici come neanche le edizioni dei classici: tre prefazioni, quella erudita di Rolando Vitali, quella mistica di Luca Cristiano, quella divertita di Paolo Agrati, più una nota stilistica finale a cura del sottoscritto. Le prefazioni ai libri di poesia possono spesso essere invasive, soprattutto se escono dalla penna di un prestigioso letterato o di un critico iperzelante, che sembrano voler mettere le mani avanti o estendere l’aura della loro autorità sul testo, impedendone una fruizione senza preconcetti. Non in questo caso, e non solo per il tono grato e partecipe che le accomuna, ma soprattutto perché il paragone più esatto è proprio quello con l’edizione commentata del classico di una civiltà lontana nello spaziotempo: anche il libro di Marina Grigorivna è un artefatto alieno, che va presentato al lettore con una certa cautela. Ciò detto, il mio consiglio resta di tuffarsi direttamente nella lettura delle poesie e viversi tutta la Verfremdung del caso.
Il primo straniamento viene dal contenuto. Lungi dall’essere astrazioni liriche, le poesie di Intercalari odorano di vita vissuta (ogni testo porta la data di composizione, a suggerire una natura diaristica) e si fondano su un’esperienza di soggetto tre volte marginale: donna, migrante e proletaria. Una persona per cui non è scontato permettersi lussi come il biglietto del treno (“me l’ha comprato un amico”) o le scarpe (“Di solito le prendo, rubo o mi vengono regalate. | I vecchi non camminano tanto | i morti meno”). Una persona che viene da un’Europa di cui sappiamo ancora troppo poco, come testimoniano i toccanti o raggelanti frammenti di realtà (post-)sovietica che l’autrice (nata in Moldavia nel 1992) dipinge a tinte vivide, iperrealistiche: “quel tuo polmone affondato nell’estate del ‘84 | nel raccogliere in rugiada tabacco | per andare a vedere a Mosca l’imbalsamato”; “Il loro [amore] – sapeva di pesce affumicato e birra […] In una casa-brufolo di terra”; “Muotea era una famiglia affianco che vendeva vino/alcol – avevano soldi. | Io ho imparato che se piangevo mi sentivano, | mi prendevano da loro fino a tarda notte e lei mi faceva qualcosa con uova e pane”.
Una materia simile darebbe adito, potenzialmente, a fiumi di autocommiserazione se non alle peggiori prediche moralistiche; per fortuna, qui non c’è un grammo di tutto ciò. Marina è una nichilista tenace, che di fronte alle realtà più sordide reagisce con un surplus di energia. Il tono che lega tutte le poesie di Intercalari è, anzi, un perenne sorriso divertito e scandalizzato verso l’assurdo dell’umanità in generale, e in particolare di certe sue sottospecie, come gli italiani, i maschi, o i letterati. Così, la sfrontatezza con cui Marina si rivolge a Gabriele Galloni (ancora vivo, se fa fede la data “24/03/2020”; ma cf. il titolo “RIP”!) la affratella all’enfant terrible della nostra poesia, ed è in fondo più degna di lui di tanti tributi commossi:
Gallone [sic!], il tuo libro Estate del mondo
lo uso per fare righe divisorie sulle nevi perenni del foglio
Chi vedrà in ciò un insulto – è uno stolto.
Riconosco quei 12 euro, te li invidio.
D’altronde, come potrebbe provar timore reverenziale davanti a Galloni chi ha questa stessa sfacciata familiarità con Leopardi: “e poi il corpo grasso di sole o qualche gelato, eh, Giacomino?”. Questa postura nei confronti della galassia dei poeti, fatta al contempo di amore fraterno e di irriverente dileggio, ricorda mutatis mutandis quella di Roberto Bolaño verso i suoi Detective selvaggi.
Il suo italiano fantasista, invece, mi ricorda, non so perché, quello delle poesie ‘napoletane’ di Tristan Corbière. In realtà, lo so perché – per gli apostrofi dove non servono, i troncamenti nei punti sbagliati:
T.C.: “all’sole, all’luna, all’sabato, all canonico et tutti quanti”
M.G.G.: “non bastan’ sette vite”, “a lui son’ chiusa”, “mi facevo venir’ crepe all’elmo”; “quei scarafaggi”, “del armadietto”
Ma anche Corbière tutto, in fondo, il più dimenticato dei maudits canonici, per lo stropicciamento vigoroso della lingua, i trapassi fulminei della fantasia, l’umore scostante e vigorosamente malinconico. Il secondo straniamento a cui va incontro il lettore di Marina, comunque, è quello linguistico. E bisogna chiarire fin da subito che il suo non è un italiano banalmente sporcato dal russo e dal rumeno, ma una lingua genialmente ricreata con una presa di possesso tanto decisa quanto sottile.
Sarebbe divertente, ma in fondo fuorviante, un’analisi puntuale delle specifiche libertà che l’autrice si prende: anzitutto, una certa creatività lessicale, ottenuta manipolando con disinvoltura le leve dell’italiano (diffidia, il “passo orsoso”, gli ornito-onomatopeici cirripirsi, piccirirsi; le “nespole maturande”) più che per inserti allogeni (prestito diretto dal rumeno è il verbo curgere che ricorre due volte nel senso di ‘versare’). Colpiscono maggiormente, e maggiormente contribuiscono alla riuscita dei testi, certi usi sintattici. Sono un correlato grammaticale della sua sfrontata immediatezza certe brachilogie fulminanti, per ellissi del verbo (“che era perché la prostata un cancro.”, “il capriolo la cui testa imbalsamata nell’atrio.”) o del nome (“avrò avuto sette”, scil. anni). Contribuiscono allo straniamento complessivo le non poche inversioni (“sceglieva di dormire sui già lavati, | stirati appena, panni”) e la sintassi SOV (“ogniqualvolta del genio mi date | qualcosa che potrebbe rimanere semplicemente vita | sfianco”; “come il tentativo della brasiliana che quella ‘cantina’ ha affittato”). Tratti, entrambi, che in un autore inserito nella tradizione della lingua poetica italiana produrrebbero un effetto intollerabilmente (o caricaturalmente) aulico; qui, se anche sono scelte consapevoli (e sicuramente lo sono), non meri solecismi, sono tuttavia scelte fatte da una posizione diversa, che producono un diverso effetto – quello scarto dall’espressione consueta che ci costringe a disattivare il pilota automatico della lettura.
Insomma, “[p]uò darsi” – mi sia consentito citare la mia nota – “che il suo campionario di sfasature ortografiche e sintattiche dipenda da un’acquisizione sui generis, eccentrica e apolide – ma questa sintassi del quasi errore è una cassetta degli attrezzi utilizzata con estrema consapevolezza”. Prova ne sia la finezza, sconosciuta a tanti parlanti nativi, con cui Marina sa impiegare le risorse del sistema linguistico italiano, in particolare tempi verbali sottoutilizzati come il futuro anteriore (“Un giorno da qualche parte avrò salvato dal circo un gorilla”), adoperati con un senso vivo del valore aspettuale a cui mi piace pensare non sia estraneo il sostrato linguistico slavo dell’autrice.
Ciò che casomai manca a questa scrittura è la costanza e sostanza metrica; il ritmo è quello, in senso lato, degli scatti d’umore, delle invenzioni linguistiche, delle associazioni libere e beffarde, della nervosa volubilità dello sguardo (non è un caso che il segno d’interpunzione più tipico sia la lineetta). E un limite del suo approccio è che non tutti i testi, presi singolarmente, funzionano: alcuni suonano tirati via, o comunque non superano il livello dell’intuizione ficcante, della battuta o dello sberleffo. Ma in nessun caso suonano falsi, pretestuosi, incolori. Non ha forse sguardo fresco e penetrante sul mondo chi è capace di scrivere “È il cervello-salmone a fare il salto”, “Ma io vidi il pelo di Buddha | che ti tiene in equilibrio”, “Luce di stelle morte non mi sazia più”? Non ha forse dono di visione e di sintesi, chi sa farsi questo autoritratto cubista (“Mi vidi Lego da più scatole | fronte, cuore e il frattale fra le gambe”) descrivendo un’esperienza di quasi-infarto?
Naturalmente, non c’è solo un’irreprimibile originalità di natura a rendere speciale questa poesia. L’autrice mette a frutto sì un’esperienza di prima mano del mondo che pochi colleghi italiani possono vantare, ma anche, non lo si dimentichi, i suoi studi filosofici. Rolando Vitali definisce perfettamente Intercalari come “un dialogo sui massimi sistemi, cantato in sgabuzzini”; e per cantare i massimi sistemi bisogna essere attrezzati. In Sigma, a te più vicino, Marina incontra in fila al supermercato la propria Doppelgängerin: una signora sui sessanta, “tanta ma non solo grassa”, vestita Lidl e “infradito con fiorellini verde lime – al cuoio | non si può dare quel colore, dunque Chinatown” (quale poeta odierno sarebbe capace di questa osservazione? quale di tanta disinvolta sintesi nell’esporla?). È la persona più simile a sé che la poetessa abbia mai visto, e pertanto non si stupisce quando la sente chiamare col proprio nome. Osservandola andarsene, riflette su “cosa sia andato storto” e su questo “eterno ritorno dell’uguale al supermercato”. Ma l’incontro richiama anche il ricordo di un’altra agnizione, subìta e orgogliosamente rigettata:
una sola volta “tu sei come me!” una nota clochard
di Bologna/la controlla; ma ho sterminato in lei
ogni proiezione con due lauree e qualche mai fatta
da nessuno traduzione
A questi titoli giustamente rivendicati, si può ora ben aggiungere un libro di poesie che, nel bene e nel male, vanta pochi eguali. L’esperienza di Intercalari potrebbe restare un unicum, ma se così non sarà, è probabile che seguirà qualcosa di completamente diverso, anche perché l’esperienza bolognese, determinante nella genesi della raccolta, è ormai alle spalle. Quasi non capacitandosi della propria sopravvivenza, mancato ormai l’ingresso nel ‘club dei 27’, l’autrice chiude con una dedica a Trieste, questo avamposto italiano sull’Est Europa dove – per ora! – fa tappa la sua peregrinazione.
E a proposito di lauree: qualche anno fa, Marina mi regalò il manoscritto della sua tesi bolognese su Cioran. I fogli, dagli orli bruciati, erano tenuti insieme da un cappio nero.
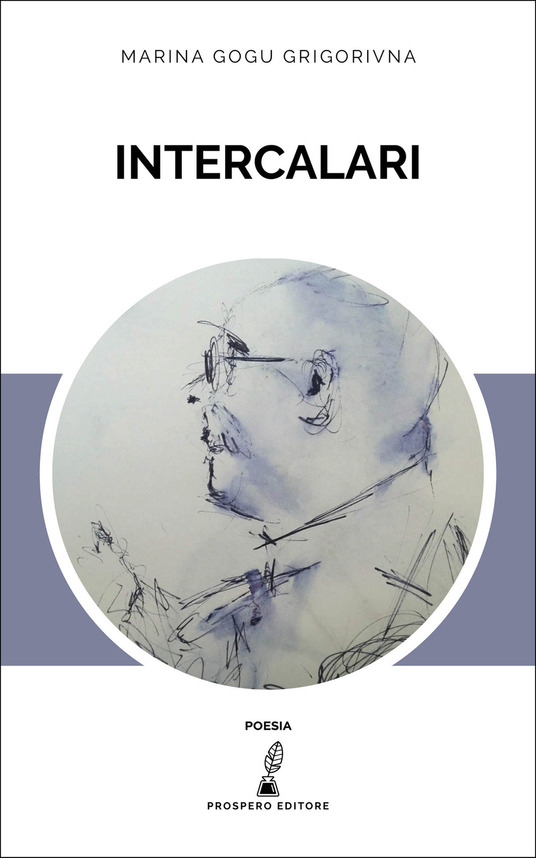
Marina Gogu Grigorivna, Intercalari. Prospero Editore, Novate Milanese, 2021.