L’attrazione sovrumana per l’alterità animale può portare a scelte rischiose, fino a mettere a repentaglio la propria vita. Come uscire fuori sentiero col temporale che incombe, nella steppa, ore e ore di cammino dal villaggio più vicino. La vegetazione fin sopra le ginocchia, il terreno che frana. La nebbia copre tutto, più in alto solo neve e crepacci invisibili. È qualcosa che Nastassja Martin, giovane antropologa francese, ha vissuto in prima persona, e testimoniato in un libro, Credere allo spirito selvaggio. Testo ibrido, a metà strada tra saggio e memoir, uscito a fine giugno per Bompiani, nella collana Overlook. Poco più di un centinaio di pagine. L’autrice narra la propria esperienza diretta di scontro fisico con un orso siberiano, la ferita corporea e psicologica che quell’impatto le ha provocato, e il percorso di rinascita conseguente. Si avventura senza timore nei territori che l’occhio animale apre oltre il linguaggio umano.
Riponendolo a scaffale nella libreria dove lavoro, ne ho subito presa in visione una copia. Il libro è grigio e sulla cover ha dei monti artici, una tenda e un uomo. Sono stato felice di distinguerlo tra le decine di titoli che ogni settimana soffocano il catalogo; mi ha invocato già da subito. La roccia in primo piano è poco più che una macchia di risulta dallo scioglimento dei ghiacci – tutta l’acqua che c’è dietro – ma a guardarla bene potrebbe sembrare il corpo sdraiato di un orso bruno, il muso. Non credo sia un effetto voluto dal grafico.
Anch’io l’ho attraversato, quello stato di trasporto verso il totem, un delirio che ancora non mi abbandona. Perlomeno come lettore di tracce. Sono uno che crede allo spirito selvaggio, ed è una colpa. Saranno almeno due anni che giro intorno a quell’animale, dopo che durante un’escursione nella Riserva Naturale Integrale Valsolda sono entrato nella buca dell’orso e ho sentito quell’odore, un misto tra muschio, rancido e sterco di canide selvatico. Dopo che dal Monte d’Orimento, in Alta Valle Intelvi, ho camminato fino alla Grotta Generosa, ammirando le repertazioni di Ursus Spelaeus e Uomo di Neanderthal, la loro vicinanza concorrenziale già nelle più remote epoche dell’umanità. È la nostra Grotta Chauvet. Su quegli animali avevo già letto il romanzo di Matteo Righetto La pelle dell’orso e studiato Orso vivrai! di Franco Tassi, un vecchio volume ecobiologico dei libri di Airone. Ma mi mancava sempre qualcosa, un segno concreto, la traccia reale di un passaggio. Era una cosa che si trascinava sin dall’infanzia, dalla lettura a scuola de L’orso grigio di James Oliver Curwood, in una vecchia edizione Sonzogno rossa, da cui Annaud ha tratto il film omonimo, passando attraverso il romanzo di Beth Day, Vita con gli orsi e quel sacro, primitivo, racconto-aurora di William Faulkner in Go down, Moses sulla caccia all’orso Old Ben. Arto Paasilinna mi aveva fatto ridere e piangere, con il bizzarro Il miglior amico dell’orso, rendendo l’incontro tra le due creature qualcosa di rocambolesco.
Poi erano arrivati libri come quello di Carl Safina, Al di là delle parole, saggi in cui la scienza biologica si fa poesia emozionale, parlando di orche, elefanti o lupi. Romanzi autobiografici tipo quello di Ben Moon, Storia di un cane e dell’uomo a cui ha cambiato la vita, che trattano dei legami di amicizia tra esseri viventi, l’abbraccio reciproco nella sofferenza. Sono questioni che vanno indietro fino all’origine della nostra specie, girano intorno al rapporto segreto tra animali, scrittura e morte, senza però mai immergersi fino in fondo nella cosa.
Qui finalmente l’ho trovata e l’ho toccata, la cosa stessa. L’autrice, Nastassja Martin, antropologa per l’Ecole des Hautes Etudes e allieva di Philippe Descola, è mia coetanea, questo il suo primo testo tradotto in Italia. Basterebbe la prefazione di Antonio Franchini per farsi un’idea dell’importanza del libro: una scrittura di difficile classificazione, tra il memoriale e una sonnambolica propensione all’ignoto tipica dei diari di viaggio. Il titolo è bellissimo: Credere allo spirito selvaggio. In francese, Croire aux fauves. Tipo, in assonanza, credere alle favole (fables): ma è un “falso amico” ricercato. Mi piace molto anche l’esergo: «A tutti gli esseri della metamorfosi, qui e altrove». Ci ricorda che siamo circondati da viandanti invisibili che attraversano tutto, e che la nostra appercezione è sempre parziale, frantumata, dispersa.
Questa donna studia le popolazioni artiche e la loro visione del mondo-natura da sempre. In Croire… narra il turbine di eventi ambientali, e ospedalieri, e umani, che ha circondato il contatto quasi fatale con un vero orso nelle remote terre della Kamchatka. Il 25 agosto 2015 «un orso e una donna si incontrano e le frontiere tra i mondi implodono». La verità di quell’esperienza si respira in ogni parola. L’animale selvatico imprime un marchio indelebile nell’identità dell’antropologa, la quale trasfigura, trasmigra da un mondo all’altro – esce fuori dal campo – e poi ritorna. La vediamo diventare una sorta di regina dell’oltretomba, una moderna Persefone, rientrata sulle sue gambe dalla zona più buia dell’alterità. Anche chi le sta intorno se ne accorge: prima i medici la trattano come una bestia, ma poi lo spirito dell’animale totem prende spazio, e Nastassja diventa medka, metà e metà. Dallo stare in mezzo viene la sua forza.
Gli animali non hanno molto senso dello humor, si sa. Ma gli esseri umani, quando ci si mettono, ancora meno: gli abitanti del villaggio la temono perché è stata là, ha galleggiato tra le rovine della propria ferita, porta un taglio reale sul volto, per sempre quella sacra cicatrice la identificherà.
Siete mai andati in un bosco di alta montagna in piena notte? Se non si è dotati di torcia frontale, non si vede nulla e domina solo il continuo flusso del torrente, un rombo che copre il rumore dei passi; per il resto tutto tace, eppure a nord a sud a ovest a est, come ti giri, ci sono loro che ti guardano, aspettando una caduta, una storta, una deviazione fatale tra dei rovi, per saltarti addosso… non li puoi vedere, è buio.
John Muir, forse il primo ambientalista della storia, in Andare in montagna è tornare a casa (Piano B, 2020), scrive dell’incontro originario con un orso cinnamomo della Sierra nella Yosemite Valley. Il racconto si colloca in un contesto in cui domina la caccia, ma se ne emancipa già da subito. Avvertito da un cane che lo porta a pochi metri da un esemplare, Muir si nasconde dietro un albero. Cerca di metterlo in fuga facendolo correre, solo che quello resta fermo e lo fissa. È molto preziosa la descrizione che l’autore fa del plantigrado mentre si nutre, o si pasce sdraiato nella radura. Ma c’è ancora uno stacco tra uomo e animale selvatico, uno iato “da scienziato” che impedisce la comprensione della natura metafisica del contatto. È però, senz’altro, il primo passo compiuto da uno studioso verso una cognizione dell’animale non più solo come cibo per uomini («la carne d’orso è la migliore delle montagne») o trofeo o bestia infame da scacciare, ma come materia fenomenica di indagine. Stiamo parlando di più di cent’anni prima, rispetto a Croire... Quel saggio di Muir è come se preparasse il terreno, l’humus fertile necessario per un incontro integrale, spirituale e psicanalitico insieme, negli anni a venire.
A un certo punto nel mio spazio di lettura è successo qualcosa. Si sono come impressi dei fuochi fatui grigio-neri su due fogli, simili a delle impronte o delle bruciature da lapilli incandescenti di lava; una a pagina 36, l’altra a pagina 63. Solo su questa copia qui specifica, particolare e unica, che ho in mano; mentre leggo, si incidono per un errore di stampa delle tracce. Per dire, è passato anche di qui, piccolino – in scala – ma sporco di fango, il bestione. L’artiglio della montagna infuocata ha camminato sopra il foglio. Non so cosa ciò significhi, probabilmente nulla; comunque, a pagina 36 la Martin parla del primo incontro con l’orso, avvenuto sull’argine di un fiume per salvare un cane di nome Shaman. C’è sempre di mezzo un cane. A pagina 63 scrive: «bisogna credere allo spirito selvaggio, al suo silenzio, al suo ritegno». Sarà un caso, ma mi sembrano due pagine spartiacque. Le orme sono aderenze di legatoria, si posano a indicare una chiave di lettura.
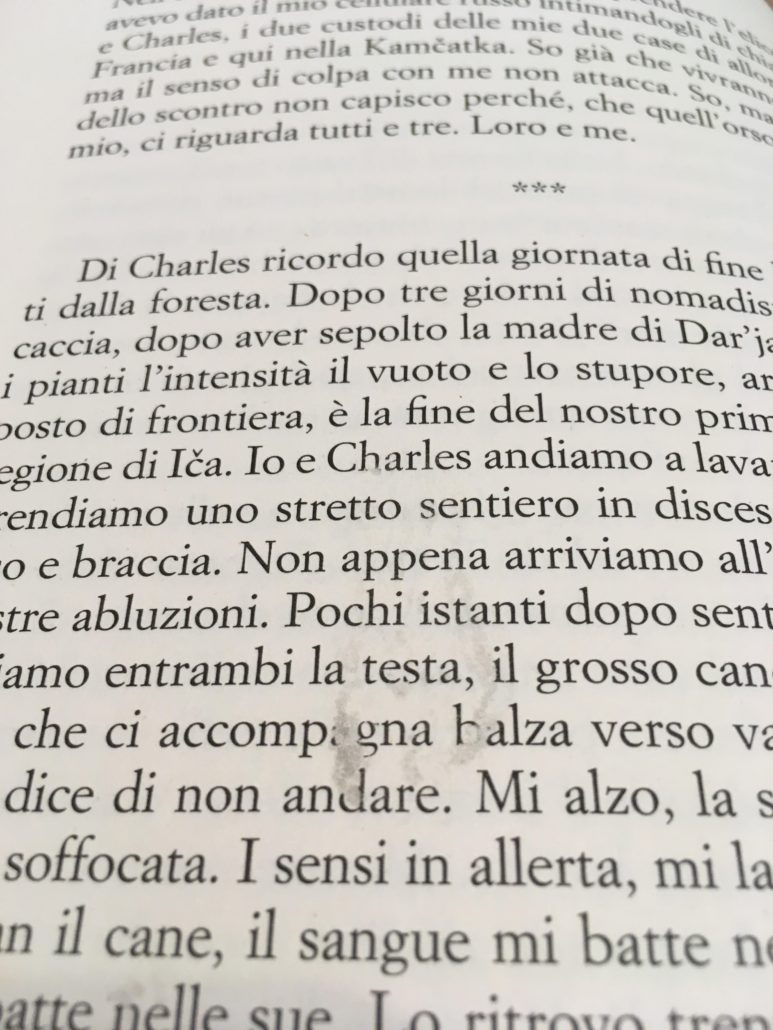
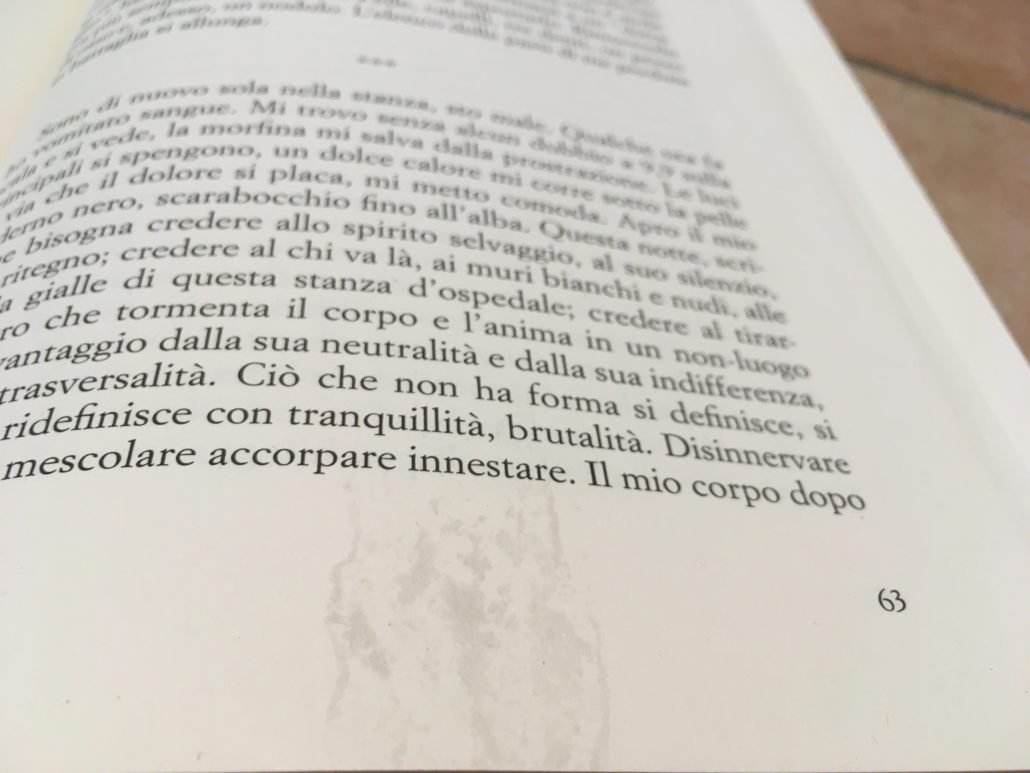
Credere allo spirito selvaggio è un libro che mi ha fatto riaffiorare alla mente, a tratti, con le lacrime, il capolavoro di Werner Herzog, Grizzly man. Vi ho percepito lo stesso pesante e toccante senso di una tragedia già accaduta o lì lì per accadere, l’immersione integrale in una natura spietata. C’è lo stesso amore, la medesima incoscienza ed estrema sensibilità, là montata con i filmati originali di Timothy Treadwell, qui con i frammenti di una scrittura che cerca di renderci partecipi della presenza ovunque, terribile e splendida nel contempo, della creatura selvaggia. Sono loro, gli spiriti degli animali, tutti sparsi nel luogo, a sceglierti. Tim con una vocina tutta sua chiamava a sé i plantigradi, toccandoli, salutandoli per nome uno ad uno, certo di essere loro amico, spaccando quella distanza fra mondi; faceva loro da balia, follemente innamorato di quelle creature, gli orsi grigi d’Alaska. Il regista con sublime maestria riuscì a montare il girato dell’ambientalista, insieme a interviste a chi lo conobbe, persone che ebbero a che fare con quell’uomo-orso. C’è però, secondo me, una differenza sostanziale tra le due esperienze: Treadwell fu ucciso da un grizzly – registrò, si dice, la propria orribile morte, senza alcun filtro. Un maschio aggressivo ed esterno al gruppo familiare aggredì lui e la compagna. Però Werner Herzog sceglie di non mostrare, né far sentire, le grida di quei momenti. Non possiamo che ringraziarlo per la sua pietas, per essersi accollato da solo il peso di quell’esperienza di ascolto. Vediamo solo il suo volto mentre con le cuffie si fa investire dalle probabili urla di Tim.
Nastassja, invece, riesce a sopravvivere, ha il viso squarciato all’altezza della mascella. Per cui nel suo libro si entra fino in fondo alla ferita, nella lacerazione aperta dalle fauci dell’orso. È come se si compisse il passo successivo al girato di Tim, la prossimità estrema e folle con l’altro-da-sé animale: le due figure combaciano e l’irrazionale è tangibile. La grandezza del testo sta qui, nella possibilità unica, direi irripetibile, di leggere il ruglio della foresta, fare avanti e indietro tra la vita e la morte. È un sacrificio che l’autrice si sente di mettere in pratica per amore della ricerca letteraria e antropologica. Questa immersione/emersione avviene con lievità, ed insieme estrema, definitiva consapevolezza. Nastassja si fa investire completamente dall’alito che l’ha colpita, comprende che è l’unica via che ha per accedere a una nuova esistenza. È lei stessa, ora, il vulcano da esplorare. Ha dentro di sé l’orso, ormai, il bacio quasi fatale del plantigrado l’ha segnata e cerca il senso di questa mutazione. Il procedere della sua prosa assume per cui una portata terapeutica universale.
È un libro che tiene, dalla prima all’ultima pagina, perché è autentico. È suddiviso secondo il ciclo delle stagioni, prendendo avvio proprio da quello squarcio e poi risalendo la cavità dei sogni perduti, se si vuole ritornare a Herzog e alle grotte. Perché persino le visioni notturne del sonno sono trascritte e rese fruibili nella loro irrazionalità. Fanno parte del percorso di rinascita dell’autrice. La prosa è ottima, mai pesante, tende sempre a una lieve chiarezza: pur muovendosi nell’oscurità, s’interroga, s’incunea nell’animo devastato, ma vigile e proteso sul precipizio della giovane autrice.
Non serve rievocare le vite di santi come Romedio o Serafino di Sarov, per capire che il faccia a faccia con l’orso è questione che ha a che fare con l’infinito. Per questo lo segnalo ai lettori di spiritualità orientale, filosofia o religione. Va bene per chi ama le montagne, l’etnologia, le sconfinate terre del nord. Sono andato a vedere su google maps l’esatta ubicazione del vulcano dove è accaduto l’evento centrale del libro, il Kljucevskoj. Superfici preistoriche, da dinosauri, lande desolate da mammuth. Conoscevo la Kamchatka come tutti solo grazie a Risiko!, prima. Così sperduta, al di là di ogni logica, marginale al massimo. Ora ne ho un’idea tanto nitida da averne paura.
È un trattato di escatologia, e insieme un reportage sanitario. Funziona come libello di psicologia profonda, o come breviario antropologico. È un volume prezioso, la cui grandezza sta nell’essere la testimonianza di una superstite dello scontro con le forze primordiali della natura. Mi piace definirlo una risonanza sciamanica.
Lo consiglio a chiunque ami questa terra e si senta spesso inadeguato. Nastassja fa da messaggera tra due esistenze, riesce a svolgere questo compito solo dopo un lungo percorso tra sale operatorie e ospedali, il perdono rivolto alla bestia, e un mai interrotto trasognamento, il contatto con gli orsi della notte. Quello che ci rimanda, è il vissuto di un’iniziazione, senz’altro sofferta, e la percezione di un miracolo. Il senso di predestinazione, la prova del ritorno nel ventre della foresta, fanno tutti parte di questa lunga trasfigurazione di cui, per grazia ricevuta, il lettore può diventare partecipe, frase dopo frase, paragrafo dopo paragrafo. L’invito al fruitore fortunato di questo prodotto – così fuori dalle logiche commerciali contemporanee, complimenti a Bompiani per il coraggio – è un richiamo ad uscire, e sognare più lontano. L’ho fatto, lo farò, in Valle Albano. Vivere oltre, andiamo.
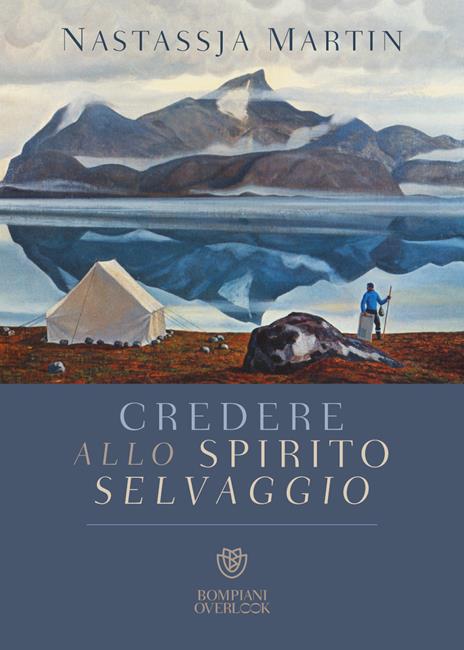
Nastassja Martin, Credere allo spirito selvaggio, trad. M. Karam, Bompiani, Milano 2021, 128 pp. 15,00€