Non tutto il passato può essere ricostruito. È da questa pungente e drammatica constatazione che nasce il libro Lose your mother. A Journey along the Atlantic Slave Route dell’accademica (oggi Professor in African American Studies presso la Columbia University) e scrittrice Saidiya Hartman. Edito per la prima volta nel 2007, il libro arriva al pubblico italiano grazie alla traduzione di Valeria Gennaio per Tamu Edizioni con il titolo Perdi la madre. Un viaggio lungo la rotta atlantica degli schiavi (2021).
Il testo, a metà tra un saggio storico e un memoir, si sviluppa attraverso due domande di ricerca. La prima è guidata dall’ipotesi, che si rivelerà fallace, secondo la quale si possa raccontare la tratta atlantica dellə schiavə attraverso la memoria popolare. Guidata da questa intuizione, nel 1997 Hartman decide di spostarsi in Ghana, un tempo epicentro del commercio di schiavə dell’Africa Occidentale (non per niente fino al 1957, anno dell’indipendenza, era conosciuto come Costa d’Oro), dalle cui coste partì un carico umano che si somma al numero, stimato tra i dodici e sessanta milioni, di persone imbarcate verso le Americhe e l’Europa (tragitto triangolare altrimenti noto come Middle Passage) lungo un asse temporale di almeno cinque secoli. La seconda domanda di ricerca, più personale, si traduce nel desiderio di sapere di più della propria stirpe, delle proprie origini, della propria madre.
All’interno del volume le due traiettorie scorrono parallele, si intrecciano, si confondono. Entrambe, però, si annodano all’amara constatazione che, come per lə schiavə, anche per Hartman è impossibile ricondursi a un inizio, a un utero genealogico, a un’appartenenza: come la schiava, Hartman è “orfana” (p. 116), straniera (obruni) ovunque, impossibilitata a trovare nel proprio passato gli elementi per costruire la sua identità, è una senza-madre. E non basterà riappropriarsi di un atavico nome afrodiscendente, Saidiya, per sostituire il Valerie con cui era stata registrata all’anagrafe appena nata per “cancellare la povera ragazza nera” che avrebbe potuto ereditare dalla madre, poiché anche la lingua swahili è il risultato di un compromesso con i coloni (p. 18).
La madre, ovvero l’origine, il sangue, l’appartenenza, è persa per sempre e a vari livelli:
Perdere la madre significava vedersi negare la propria stirpe, il proprio paese e la propria identità. Perdere la madre significava dimenticare il proprio passato (p. 116).
Se ne accorge subito Hartman quando interroga il nonno sulle vicende della bisnonna Ella e della trisavola Ellen, di cui si conoscono scarsi dettagli. Madre e figlia avevano entrambe vissuto da schiave in Alabama prima che Ella, ancora ragazzina, fosse fermata un giorno del 18651 da un soldato che l’aveva avvisata “che era libera” (p. 21).
Del periodo prima della liberazione, in famiglia, non si era mai parlato. Come si renderà presto conto l’autrice-protagonista, l’“archivio della schiavitù” (p. 28) è vuoto, frutto di un’esclusione razziale, sociale, politica: “L’archivio impone ciò che del passato può essere detto e il tipo di storie che possono essere raccontate circa le persone catalogate, imbalsamate, sigillate e messe via in pagine e schedari” (p. 29).
È vuoto perché rimangono solo numeri nei registri, quelle cifre che sostituivano i nomi di chi veniva prelevatз dall’Africa e trasportatə nel Nuovo Mondo, prezzi, merci di scambio, dati, informazioni, conchiglie di Ciprea2. Non esiste un resoconto, un’autobiografia, un episodio tramandato di madre in figlia; tutta la mole di informazioni su cui la storiografia si basa non si è deteriorata o dispersa: semplicemente non è mai esistita. Addirittura nei luoghi che dovrebbero custodire i cimeli dellə schiavə non rimane che un vuoto incolmabile; nel castello di Elmina, un tempo un forte predisposto ad ospitare le persone incatenate prima di essere imbarcate, non rimane nulla: “Persino nel museo gli schiavi erano assenti. Nessuno dei loro effetti personali era stato disposto con grazia in una teca di vetro ben illuminata” (pp.154-155).
La tratta degli esseri umani è stata inghiottita dall’oblio. Non ve n’è traccia da nessuna parte, come un cimitero di un “passato che nessuno voleva ricordare” (p. 96). Lə ghanesə stessə hanno preferito intitolare le vie ai grandi avvenimenti e agli illustri nomi dell’anticolonialismo. Questa onomastica della liberazione è capeggiata dalla sede del governo di Accra, nel quartiere Osu, Fort Christiansborg, il presidio per lo smistamento dellə schiavə3. Rifugiandosi nel sogno di un futuro libero dall’oppressione, afroamericanə e africanə si erano unitə nel “tentativo […] di sradicare l’umiliazione della schiavitù e del colonialismo” (p. 58) a discapito della rivendicazione dellə schiavə, che rimanevano esclusə dalla storia, dalla memoria e dalla costruzione del futuro.
Dimenticare il passato delle proprie origini era una strategia di controllo attuato dallə schiavistə:
In ogni società schiavista i proprietari cercavano di sradicare la memoria della schiava, ovvero di cancellare ogni traccia di un’esistenza precedente alla schiavitù. […] Una schiava senza passato non aveva una vita per cui chiedere vendetta. Nessun tempo perso a desiderare casa, nessun ricordo di una patria distante a rallentarla mentre dissodava la terra, nessuna immagine della madre che potesse venirle in mente quando guardava il volto di sua figlia. Il dolore di tutto ciò che aveva perduto non le agitava il petto né le stringeva il cuore. Le senza memoria non costituivano alcuna minaccia (p.204).
Lə schiavə erano e sono le persone che hanno perso memoria di loro stessə e della via di ritorno, sono dei corpi morti, remoti, persi. La “non appartenenza […] è l’essenza della schiavitù” (119).
Le uniche tracce di memoria collettiva in Ghana sono strumentali all’arricchimento del Paese: quel turismo dell’orrore che si sviluppa attorno ai monumenti e ai siti di guerra, accompagnato dalla performance di riti e cerimonie, è solo un modo come un altro di “silenziare il passato con il pretesto stesso di preservarlo, dal momento che arginava efficacemente ogni discussione sulla schiavitù africana e sulle sue implicazioni – sfruttamento di classe, disuguaglianza di genere, scontri etnici e conflitti regionali” (p. 215).
Hartman si accorge infatti del dislivello che separa lə africanə dallə afroamericanə e, in generale, dallə appartenenti alla diaspora: se da una parte lə autoctonə contemporaneə vivono la schiavitù come una faccenda per cui non si trova mai il tempo se non, appunto, quando comporta un grado di lucro, dall’altra lə figliə della migrazione, della spoliazione, della perdita della genitrice, sognano di ricongiungersi alla madrepatria, allə loro antenatə. Arrivano quindi in Ghana, piangono lə mortə, lasciano ingenti quantità di denaro per ripagare la violenza subita dalle loro stirpi recise (p. 215). Hartman pondera quindi sulla funzionalità della memoria: se, infatti, “gli africani americani accarezzavano fantasie di ritorni e i ghanesi fantasie di partenza” (217), il ricordo della schiavitù rimaneva una consolazione effimera che, oltre a dividere la comunità nera, alimentava la distanza dal presente.
La schiavitù e i suoi strascichi sono invece onnipresenti, trasversali, come testimonia la differenza sociale ed economica tra bianchə e nerə e che si propaga tramite aggressioni, violenza, segregazione razziale. Allo stesso modo, poiché essa non ha cessato di esistere con l’abolizione ufficiale a fine del diciannovesimo secolo, la schiavitù accompagna nella lotta contro l’oppressione, si interfaccia alla “promessa dell’abolizione”, ovvero alla “ricostruzione della società”, unica modalità che lə vivə hanno di sdebitarsi con chi non esiste più (pp. 222-223).
Come fare a sopperire alla mancanza di tracce, cosa cercare nell’archivio della repressione?
Hartman sfida i limiti dell’archivio come un insieme di norme repressive che limitano la conoscenza delle soggettività dellə schiavə. Allo stesso tempo questa metodologia, descritta da Hartman come “fabulazione critica”4, utilizza la narrazione, ovvero la fabula, per disinnescare quel sistema di sorveglianza che ha portato all’insabbiamento di alcune voci a favore di altre. In Perdi la madre Hartman rende visibile l’insufficienza epistemologica dell’archivio e della documentazione storica, utilizzando la teoria critica e la finzione narrativa non per riempire i silenzi dell’archivio ma per forzare al massimo la tensione tra quello che è stato (e che non sapremo mai) e quello che potrebbe essere successo. In questa frattura narrativa si insinuano i resoconti dettagliati e struggenti che si trovano all’interno del volume. Così dalle poche testimonianze di chi accompagnava lə schiavə nei loro viaggi transatlantici, Hartman ricostruisce le vite di alcunə di loro, come la ragazza a bordo della nave Recovery, appesa a testa in giù nuda e percossa fino alla morte dal suo padrone. Dai detriti organici che coprono i pavimenti e le pareti delle celle di Elmina, allo spiazzo desolato del centro di Salaga, Hartman rievoca lə mortə, il loro dolore fisico e psicologico, replica i loro spostamenti, specula sulle loro esistenze inconsistenti, dimenticate, prive di un inizio (di chi erano figliə? Da dove provenivano?) e di una fine (come sono mortə? Dove sono stati gettati i resti?).
Cosa fare, si chiede incessantemente Hartman, quando la tua esistenza si fonda sul nulla?
La prospettiva che si delinea è quella della decostruzione dell’identità sulla base del lignaggio. Se è dunque vero che il mito della madre non è altro che il “bisogno di un romanzo delle origini” che scaturisce dalla perdita, sarà necessario prendere coscienza del vuoto come presenza (p. 132). È infatti nel momento in cui si rende conto che non esiste la memoria del passato che Hartman inverte la rotta: la sua identità, e dunque la sua appartenenza, la sua cittadinanza, non devono essere ricondotte a una madre. Paradigmatico di questo spostamento dal legame di sangue alla creazione della comunità è uno degli ultimi episodi che Hartman racconta nel volume. Lə abitantə di Gwolu, cittadella all’estremo nord del Ghana, dopo l’abolizione della schiavitù avevano costruito un muro, di cui rimangono le rovine, per proteggersi dallə predatorə di schiavə. Quest’usanza di difendere le città dalle aggressioni esterne era comune in quel periodo. Chi fuggiva da Sud a Nord camminava per settimane, alla ricerca di un luogo sicuro. È proprio negli agglomerati urbani come Gwolu che le genti, provenienti da diverse tribù, si univano allə altrə fuggitivə, lə quali venivano accoltə senza la richiesta di un passaporto genetico:
I nuovi arrivati erano i benvenuti. Non importava che non fossero parenti o che parlassero una lingua diversa, perché quello che importava non era la genealogia […] ma costruire una comunità (p. 293).
Questa comunità si contrapponeva a quel “mondo […] che avevano lasciato” (p. 293), un mondo che era costruito sulle relazioni famigliari: schiavə, figlə di schiavə, schiavistə e figlə di schiavistə. In Africa, non bisogna infatti dimenticare, “nel diciannovesimo secolo c’erano più schiavi […] che nelle Americhe”, e lə loro discendentə costituivano più della metà della popolazione dell’Africa Occidentale. A discapito di ogni ereditarietà, questo “noi” si erigeva sulla possibilità di essere liberə, dove l’“identità era definita tanto da ciò che si lasciavano alle spalle quanto da ciò verso cui correvano” (p. 294). Durante la sua permanenza in Ghana, Hartman descrive con minuzia la complessità della schiavitù e l’inconsistenza di una rivendicazione panafricana come era stata concepita negli anni Sessanta. La congiuntura tra il passato e il presente non si trova nella condivisione della violenza subita, ma nella potenzialità rivoluzionaria e democratica che l’atto collettivo, il “noi”, proietta nel futuro. La schiavitù non è dunque un fatto storico finito e mai archiviato, ma è un processo da cui ancora lə nerə non si sono emantipatə: “il fantasma della schiavitù ancora perseguita il nostro presente […] perché siamo ancora alla ricerca di un’uscita dalla prigione” (p. 176). L’identità africana che Hartman reclama non è dunque quella della madre comune, dell’utopia panafricana; si situa piuttosto nell’eredità dellə abitantз di Gwolu:
L’eredità che avevo deciso di rivendicare si articolava nella lotta tutt’ora in corso per sfuggire alla schiavitù, smantellarla e sconfiggerla in tutte le sue innumerevoli forme. Era l’eredità dei fuggitivi (p. 305)
È in questa necessità di affiliazione che si situa il lavoro straordinario di Hartman. Il Perdi la madre del titolo può essere letto sia come asserzione che come invito: a interrogare le pratiche mnemoniche, il sito della memoria culturale, le faglie conoscitive, la natura lacunosa della storia come narrazione, la materialità degradata, le contraddizioni, le congetture, le increspature interne; ma anche un invito a pensare alla “crisi della cittadinanza ancora in atto” (p. 175). Una crisi che si traduce nel razzismo, nell’esclusione sociale, nella negazione del diritto di appartenere a un luogo. Il matricidio è quindi necessario alla costruzione di una comunità che non si crea a partire dalla filiazione parentale; con l’eco dello ius sanguinis che ancora oggi in Italia determina ingiustamente il diritto di cittadinanza, il matricidio operato in Perdi la madre è attuale, necessario, inderogabile.
1 Il 18 dicembre 1865 viene abolita la tratta degli schiavi negli Stati Uniti d’America.
2 Le conchiglie di Ciprea, che danno il nome a uno dei capitoli del libro, vennero utilizzate come moneta in tutta l’Africa Occidentale fin dall’undicesimo secolo, nonostante la loro circolazione incrementò con il traffico degli schiavi sei secoli dopo.
3 Assunse questa funzione soprattutto durante l’occupazione di Danimarca-Norvegia verso la metà del diciassettesimo secolo.
4 Nell’articolo “Venus in two acts” (2008): https://muse.jhu.edu/article/241115.
Photo credit: Grada Kilomba – O BARCOTHE BOAT -Performance – BoCA Biennial of Contemporary Arts 2021 © bruno simao
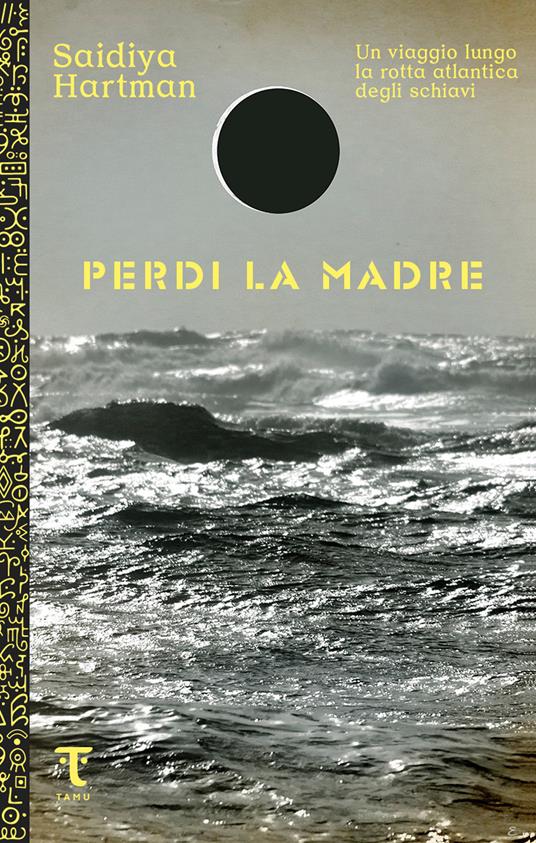
Saidiya Hartman, Perdi la madre. Un viaggio lungo la rotta atlantica degli schiavi, Tamu edizioni, Napoli 2021, 336 pp., € 18.