Con postura sorprendentemente proustiana, un Jack Kerouac lontano dagli esordi sentì a un certo punto il bisogno di ammonire il lettore che la sua opera era da intendersi giusto appunto come tale: un’opera intera. Una e non frammentata – al massimo composta di frammenti che, come le tessere del mosaico medievale in una nota metafora di Walter Benjamin, splendono solo complessivamente, quando tutti gli elementi fanno apparire di concerto una costellazione.
È dunque più chiaro il portato dello “scroll”, del lunghissimo rotolo di carta su cui Kerouac originariamente batté a macchina On the Road nel 1951: non solo supporto ma medium di un romanzo fiume, e a sua volta metonimia di un progetto di scrittura torrenziale che ricopre l’arco di una vita. Lo scrittore fatto mistico ha rivelato, letteralmente, che ogni libro è segno e simbolo e che assume significato e valore soltanto nel momento attivo della lettura (quando il testo si fa verbo: se si accetta la valenza estatica di questo sguardo retrospettivo).
Forse Vanni Santoni vuole fare lo stesso ora che, in piena maturità e a carriera ben avviata, licenzia la sua ultima fatica intitolandola La verità su tutto: sentenza perentoria e grido di rapimento, che attesta la volontà di sintetizzare – alla maniera di John Donne – la meditazione e la modulazione (“the meditation and the modulation”): di ripensare con distacco a quanto si è fatto (e scritto) fino adesso, e di riorganizzarlo in un disegno onnicomprensivo.
Ci dice, con questo libro programmaticamente sincretico, che la sua operazione letteraria si compie, magari, proprio nel tutto del suo catalogo di autore, e trascendendo i singoli pezzi; questi non sono monadi chiuse bensì tappe di un’esperienza ancora aperta che coinvolge la forma-romanzo incidentalmente. Santoni lo fa anzitutto schiudendo al pubblico la sua officina di lavoro, ovvero esibendo metodi preliminari e schemi preparatori (qui), i suoi personali rolls kerouachiani: colonne di fogli appesi a registrare tracce, appunti, episodi, sempre crescenti come una teoria.
E poi, nel merito del romanzo in oggetto, procede per la via processuale con due strategie narrative di marca tautologica e ricorsiva. Dapprima preleva due personaggi di libri precedenti e modifica il loro campo d’azione già delineato. Con duplice moto: Cleopatra di Muro di casse (2015) diventa, qui, la protagonista (il suo spazio è allargato), mentre Antonio di I fratelli Michelangelo (2019) subentra come uno dei tanti suoi “maestri” (probabilmente nell’accezione con cui René Daumal cercava di nobilitare il termine e di affrancarlo dalle implicazioni meramente gerarchiche; il suo spazio è ristretto).
Inserisce inoltre sé stesso – e vistosamente, in quanto autore del «libro […] sulle feste» (p. 99) – nella vicenda: con una V. puntata si fa osservare al rovescio da Cleo per guardarsi dall’esterno, e parodiarsi liquidandosi come «uno di quelli che veniva al Collettivo solo per conoscere ragazze. Tipico edonista controrivoluzionario» (p. 71; la mise en abyme autoriferita e irridente ammicca a quella del Michel Houellebecq che, ormai maturo, si è inscritto nella trama di La carte et le territoire, 2010, lasciandosi intervistare – alcolizzato, tabagista e insoffribile – dalla voce narrante).
Da oggetto di indagine di Santoni, Cleo si ritrova suo malgrado ispettrice del fenomeno socioculturale: in La verità su tutto è assegnista di ricerca in sociologia all’Università di Firenze, ma convive a fatica con il compito ansiogeno che le spetta, perché costretta a indagare il mondo con sguardo esterno – sebbene politicamente posizionato – e dunque altèro più che altro: le sta stretto il distacco analitico che, da sociologa, deve mettere in campo per guardare ogni cosa. Le grava poi addosso, oltre che un peso di matrice sociale, un problema morale; anzi il problema morale per eccellenza. Constata sulla sua pelle che agendo (e nella fattispecie amando e desiderando: instaurando relazioni con gli altri) è possibile fare del male: il vantaggio dell’uno è danno dell’altro, annotava categorico Montaigne al di là di ogni fede.
Di qui l’esigenza di un’altra possibilità: della ricerca di un altrove che non si limiti a conciliare i contrasti di un esistente acriticamente registrato, ma che trascenda le distinzioni nette e i dualismi in una sintesi spirituale svolta però – per sfumarne effettivamente i confini – in un piano di immanenza: «Non è forse intrinsecamente egoistica, una ricerca che sia esclusivamente interiore?» (p. 54).
Poste queste premesse, il romanzo somiglia per certi versi a quei Bildungsromane singolarmente variati da Ernst Jünger (come Die Zwille, 1973, recentemente ristampato, o Aladins Problem, 1983) in cui la formazione del protagonista-iniziato è intesa come scoperta delle matrici tipiche e archetipiche del mondo reale. In Afrikanische Spiele (1936), per esempio, ciò è simboleggiato dalla volontà di un adolescente tedesco di smettere di andare a scuola, di viaggiare lontano e di fuggire battendo perennemente – cruciale è l’analogia – le porte laterali al portone principale: quelle inesistenti e ancora da aprire, a costo di sbattere contro i muri.
Per altri versi, tuttavia, La verità su tutto incarna qualità ulteriori e più versatili della prosa jüngeriana, che Santoni prova a mutuare e a rendere più leggibili, alla portata di tutti. Si pensi in primo luogo all’intenzione di rendere le alterazioni di coscienza e percezione indotte da droghe ed ebbrezza; l’autore ha più volte evocato il pionieristico racconto di Jünger Besuch auf Godenholm, 1952, come ispiratore per il versante psichedelico della sua produzione (di cui il libro in oggetto fa parte, insieme a Gli interessi in comune, 2008, e a L’impero del sogno, 2010).
E poi alla volontà di studiare le medesime esperienze integrandole nella materia narrativa, con lo stesso piglio dello Jünger di Annäherungen, 1970; la nozione di “avvicinamento”, con cui il filosofo tedesco aveva definito il cogliere la morte in quanto soglia mentre si è in vita è ripresa chiaramente da Santoni nella sua radice eraclitea quando enuncia una profezia rivolta a Cleo: «Jessica [le] aveva detto solo: allontanamento. Che era, se vogliamo, il Frammento 122 di Eraclito – avvicinamento – ribaltato» (p. 207).
La storia di Cleo, infatti, è strutturata come una serie progressiva di tentativi di avvicinamento sempre più estremi, e sempre più insistenti nella loro corsa al trascendente da cogliersi, però, in un mondo che ha da lungo tempo scavalcato la secolarizzazione, e che ammette il sacro solo in quanto revival: stile tra gli stili di vita nella cornice logora della postmodernità. Cleo anzitutto spezza i legami dell’amore borghese rompendo la sua relazione con la compagna Laura, poi comincia una fase di studio per così dire insufficientemente gnostica («Fu lì che ebbi un’intuizione: quanto era scolastica l’idea di sopperire al male fatto studiando?»; «La conoscenza contro la colpa?», pp. 47, 57) mettendosi ai margini del contesto universitario e facendosi guidare ora da Morelli (intellettuale-maestro) ora da una nemesi di Simone Weil. La filosofa appare come fantasma e confidente nelle aule di biblioteca indicando la via del bene tramite la pratica dell’attenzione, di ciò che in francese si chiama souci: «Il problema del male cominciava infatti a sembrarmi solo l’ingresso, un ingresso evidentemente spropositato, attraverso cui arrivare alla questione del bene» (p. 59). La personificazione weiliana un po’ sui generis, però, attutisce il portato rivoluzionario del suo pensiero e la sua credibilità, poiché gli affilati aforismi di Weil vengono ri-contestualizzati en découpage in una conversazione eccessivamente amicale.
Cleo getta insomma le basi per l’esperienza religiosa propriamente detta, che è però inevitabilmente nutrita e sostenuta da parole che l’hanno sedotta per «l’aperto sincretismo che le reggeva» (p. 87): le sue condizioni di possibilità si danno in un orizzonte statutariamente ibrido, che tutto accoglie e tutto imbastardisce senza posa. Il significato essenziale del fenomeno del sincretismo sta nella sua ineluttabilità: in mondi e tempi che mutano di continuo si paga ogni prezzo per preservare la deità in qualche modo, a costo di creare moltitudini di idoli dal valore identico (oppure relativo e persino apparente). Tale carattere sembra appunto rispecchiarsi sia nel cammino della protagonista (peregrinazioni e periegesi tra realtà comunitarie eterogenee: il Movimento Hare Krishna, gli Elfi di Sambuca Pistoiese, gli Smeragdini, l’eremo di Macinaia, il Paradisino di Vallombrosa, fino all’utopia di Shaktiville che forse sta in India forse in Lunigiana) sia nel ductus del testo santoniano.
Seguendo il climax dell’ascesi di Cleo, esso si screzia di intertesti (rielaborazioni da Rayuela di Julio Cortázar, centoni di cultura vedica, poesie religiose, esercizi spirituali) e ammucchia nel discorso tutti i paraphernalia della “Fabula mistica” (la lingua che ha ricompreso l’estasi in pensiero e parola secondo Michel de Certeau) e dell’induismo (faticosamente solo appercepito da occidentali in crisi che, non sapendo leggere il sanscrito, sono spesso obbligati ad abbordarne i testi sacri in traduzione inglese). Le debolezze potenziali – o le doppie facce – di un percorso e di un testo concepiti per accumulazione sincretica sono denunciate da un monito del personaggio stesso: «Muoversi per segni: quanto di più stupido e primitivo si potesse immaginare. Pure, quello bramavo, ormai» (p. 131). Si ha la sensazione che, in questo romanzo, il metodo compositivo sia violentemente ritmato in alti e bassi, risultando a tratti disarmonico: le parti più propriamente narrative (come la quarta) fanno l’effetto di superimposizioni incastrate a forza nel magma di riferimenti eterodossi in cui nuotano i personaggi.
Entrambi accidentati, il tragitto religioso di Cleo e quello letterario di Santoni vanno dunque di pari passo, tanto nella loro matrice utopica quanto nel loro sviluppo fatalmente sincretista. Puntando al mistico, entrambi corrono il pericolo della mistificazione. Tutti e due aspirano a «uno stato di “connessione col tutto” analogo a quello del nirvana o nirvikalpa samadhi che dir si voglia, […] quello finale e perfetto» (pp. 142, 145), ma eludono un presupposto inaggirabile: che il loro sguardo è – per usare il lessico dei media studies – situato, e assai precisamente: nell’Occidente ipermoderno; che il loro è un post-postmodern self – per ridoppiare il Martin Amis di The Pregnant Widow. Sono anime smarrite, certo, ma in un contesto ancora pertinente alla modernità; vogliono il tutto e subito, e non nell’aldilà: «Non era solo Ora et labora, avevamo anche lo shaivismo tantrico, la psichedelia: non rimandavamo certo la realizzazione a un’altra vita» (p. 245).
Hermann Bahr, critico d’arte austriaco tra i primi e più acuti interpreti della categoria di moderno, sosteneva già alla fine dell’Ottocento che l’uomo figlio della società industriale potesse esperire lo spirituale nell’immanenza, qui e ora, a patto di ammettere a sé stesso di essere un malato di nervi e che la trascendenza gli fosse concessa solo per via nervosa; ciò che realizzava era al massimo «un romanticismo dei nervi; ancora meglio direi: da una mistica dei nervi». All’uomo moderno è accordato di afferrare la dimensione mistica unicamente sul piano della malattia. «Solo quando la Nervosità si sarà completamente estrinsecata e l’uomo, ma soprattutto l’artista, si sarà completamente abbandonato ai nervi, senza riguardo per la ragione, o per i sensi, allora nell’arte tornerà la gioia perduta. […] È tutto un alato e celeste salire e ondeggiare nell’azzurra voluttà quando i nervi sfrenati sognano» – così scriveva Bahr nel 1891.
Mentre uno studioso accorto come Elémire Zolla opportunamente precisava che «samadhi denota la mente quando si sia sganciata da tutto ciò che di norma la impegna. […] La psiche in samadhi, unificata, può affermare “Sono”, ma non più “Sono questo”, “Sono quello”». E che, per contro, «il rovescio di samadhi è ciò che i vecchi psichiatri chiamavano nevrastenia. […] La psiche indiscriminante, nuda e vulnerabile del nevrastenico è inchiodata alla molteplicità tormentosa e irrimediabile del mondo, che in samadhi viceversa si sorvola senza restarne suggestionati». Il paradigma samadhi è, in breve, l’opposto di quello nevrotico e sincretico in cui i personaggi di La verità su tutto (e su tutti il “maestro” Antonio, laddove afferma: «Sono stato, come si diceva una volta, malato di nervi. Da ciò la volontà di abbandonare il mio reparto, che, ironicamente, era proprio psichiatria» e tuttavia mai smette l’habitus di «medico», p. 186) e Santoni stesso sono nuovamente invischiati. In questo romanzo, tutti mirano al samadhi direttamente, contraddicendo – per via del sincretismo che praticano – il senso ultimo della dottrina orientale (di qualsiasi dottrina, dato che ne prelevano brani a scelta); vogliono accedervi senza prima fronteggiare i nevrotici che in quanto occidentali dunque sono. Pertanto falliscono.
Si spiegano così la natura paradossale e le conseguenze inattese del volere intraprendere una ricerca della “verità su tutto”, tanto nella vita quanto nel testo; essa può significare un tastare ogni cosa non centrando il Tutto impalpabile. Che si traduce ora – per i personaggi – nel mancato raggiungimento del nirvana (nel non riuscire a librarsi «come una libellula sfiora il pelo dell’acqua», prestando ascolto ancora a Zolla), ora – per l’autore – nell’inseguimento della vituperata “fatica” letteraria, ponendone in opera moltissime divorati dall’ansia di scrivere. Legittima e a quanto pare feconda, questa, ma che vede in ogni obiettivo un Nervenriese: un gigante di nervi da sormontare progressivamente, diceva in Mausoleum (1978) Hans Magnus Enzensberger delle imprese costruttive tardo-ottocentesche.
Presumibilmente sta proprio in ciò la particolarità della sfida di Santoni: nel suo schietto offrirsi in quanto variazione sincretica e sincretista del processo letterario nervoso, nel suo svilupparsi eternamente in un rotolo kerouachiano da scrivere assolutamente e su cui registrare tutto inseguendo il Tutto; con il rischio di perdere dei pezzi per strada e di opacizzare per qualche attimo lo splendore del suo mosaico intero.
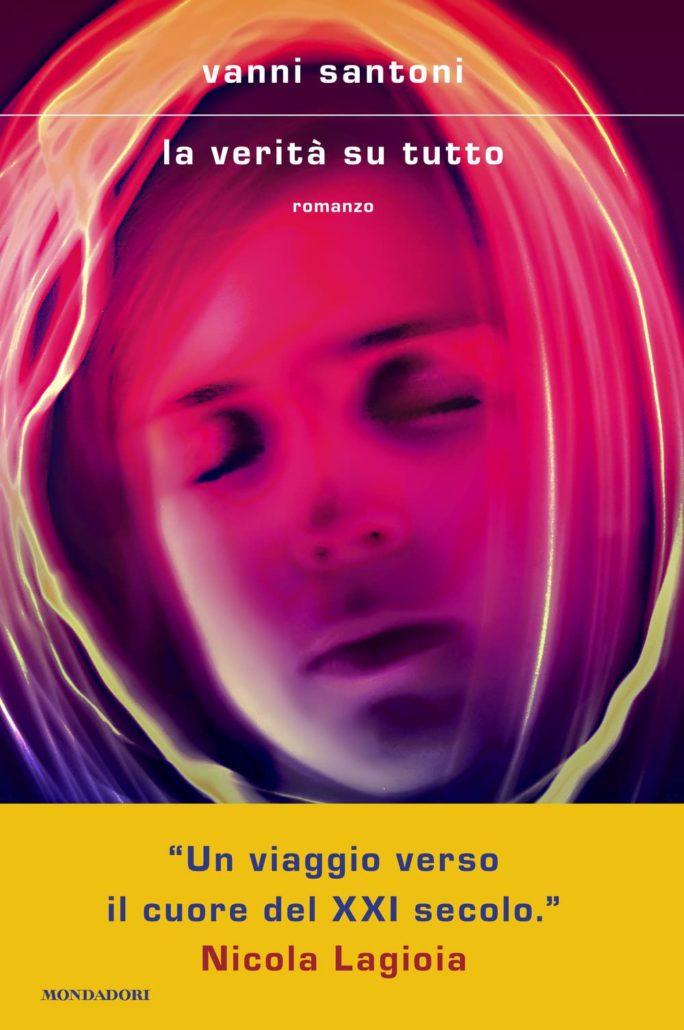
Vanni Santoni, La verità su tutto, Mondadori, Milano 2022, 300 pp., € 19,50.