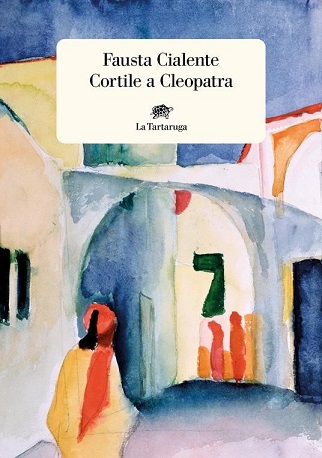In primo piano l’albero scuro e sottile. Legata al tronco, la scimmia ciondola nello specchio di un cancello aperto sul profilo stilizzato del mare. Nel cielo che ingiallisce si legge «Cortile a Cleopatra. Romanzo di Fausta Terni Cialente». Il 4 giugno 1936 (XIV anno dell’era fascista, ricorda la nota tipografica) l’editore Corticelli di Milano termina le stampe di un libro dal titolo enigmatico, aperto dall’«ombra festosa e ondeggiante» di un fico, da una scimmia che veglia e un ragazzo addormentato – «sul petto la camicia sbottonata e macchie di sole».
Un libro fuori posto, estraneo ai canoni di retorica soggezione dominanti nella letteratura italiana del tempo, destinato a mancare il suo debutto: terminato già nel 1931 ma rifiutato dagli editori che contano, parzialmente proposto da una rivista («L’Italia letteraria») che chiude prima di pubblicare tutte le puntate, a lungo ignorato da critici e lettori. Un libro scritto dall’altra parte del Mediterraneo da una donna che abita i confini estremi del mondo occidentale, sulla soglia di un altro continente.
Fausta Cialente vive in Egitto dal 1921. Fino a quel momento è stata la fortuna a decidere i luoghi di una biografia sfuggente, segnata dalla tendenza a trovarsi sempre distante dalle sue origini e dai centri della produzione culturale italiana. Nata nel 1898 a Cagliari, una delle tante destinazioni imposte dalla carriera militare del padre, a ventitré anni lascia un paese a cui sembra legarla solo il dispetto del caso («D’italiano credo di avere solo la lingua nella quale mi esprimo, e anche questa per puro caso») per seguire il marito, il musicologo Enrico Terni, originario della colonia italiana di Alessandria d’Egitto. I Terni-Cialente si stabiliscono sulla costa di Ramleh, dove corre la vecchia linea del tram punteggiata di stazioni dai nomi inglesi e il reggimento britannico ancora occupa le caserme sparse ai limiti del deserto, confuse fra i profili delle moschee e dei dattolieri. Lungo venti chilometri di spiaggia si affacciano le ville in stile liberty dei rigogliosi quartieri europei, interrotte dalle capanne di fango in cui il popolo egiziano trascina una miseria silenziosa e secolare. Nel breve intervallo che separa i due volti dell’Egitto, cresce dalla sabbia un cumulo di case basse e squadrate, strette fra il mare e la grande città. È il sobborgo di Cleopatra, regno di piccoli commercianti e artigiani levantini, da generazioni abitanti di una terra di mezzo dove l’Europa suggerisce modelli e gerarchie sociali ma l’Africa impone il respiro solenne delle sue stagioni.
Qui, dieci anni dopo l’inizio del suo esilio, Cialente scrive Cortile a Cleopatra,la storia di un ragazzo che viaggia in compagnia di una scimmia. Apparentemente un romanzo di formazione, con un protagonista connotato dai caratteri di mobilità e avventura, definito da una condizione spirituale irrequieta e rappresentato nel momento della sua iniziazione all’amore e all’età adulta. Nel primo dopoguerra il giovane Marco, cresciuto in Italia con il padre, raggiunge Alessandria d’Egitto alla ricerca della madre greca, da cui è stato separato per tutta la vita. La ritrova nel sobborgo di Cleopatra, dove divide con arabi, armeni, italiani ed ebrei l’affaccio su un cortile. Spazio che coincide con i limiti del racconto, il cortile ospita una comunità multietnica stretta in una rete di disuguaglianze, conflitti e condivisioni, in cui tutte le pratiche sociali sono falsate dagli squilibri introdotti dal potere coloniale. Di Marco si innamorano la povera Kikì (figlia di un caffettiere italiano e di una donna araba), la bella Dinah e la matura Eva, rispettivamente figlia e moglie di Abramino, ricco pellicciaio ebreo. Incostante, indolente e scontento di ogni legame, il ragazzo attraversa il perimetro di una piccola collettività organizzata che cerca di trattenerlo, avviandolo al raggiungimento della maturità sentimentale e dell’indipendenza economica. Il suo, però, non è il resoconto di un destino esemplare, ma il ritratto di un’identità inquieta e irrisolta, espressione di una solitudine assoluta che nega la possibilità di trovare il proprio posto del mondo accordandosi alle rappresentazioni condivise.
È la mancanza di accordo, l’appartenenza sempre ad un altrove, che svela la pressione autobiografica del personaggio. Per quel mancato accordo con la storia che segnerà buona parte del suo percorso, Cialente pubblica un romanzo di ambientazione egiziana a poche settimane dalla proclamazione dell’Impero fascista (9 maggio 1936), culmine di quella propaganda culturale che esalta una rappresentazione del contesto africano fondata sul razzismo, il trionfo del conquistatore bianco, la misoginia e l’erotismo. Privo di qualsiasi tentazione esotica, Cortile a Cleopatra racconta un’altra Africa: nessun orizzonte incontaminato da civilizzare, ma un ambiente umano privo di un orientamento ideale, senza barbarie e senza progresso, immobile e già corrotto dalle manie piccolo-borghesi di una società levantina pienamente occidentalizzata, che rifiuta ogni promiscuità con gli indigeni e ha perso il legame elettivo con la madrepatria. Un’Africa che non si fa terra di dominio per il giovane italiano, ma desiderio di oblio e regressione.
Per quella stessa mancata sintonia, mentre è così sconosciuta e lontana, ancora trentenne, Cialente ha scritto il suo romanzo più bello. Un romanzo che le è caro «come lo sono i figli dei quali si pensa che non hanno avuto la sorte che meritavano» e per i quali si attende il momento del riscatto. Quello di Cortile a Cleopatra deve molto all’iniziativa di un’altra scrittrice. Nel 1953 Anna Banti lo vuole fra i titoli della «Biblioteca di Paragone», collana dell’editore Sansoni associata alla rivista che la stessa autrice dirige. È di Banti anche l’intuizione, fortunata e decisiva, di affidare la prefazione alla prestigiosa firma di Emilio Cecchi, che lo celebra senza mezzi termini come «uno dei più bei romanzi italiani dell’ultimo ventennio», capace di conservare intatta «una freschezza così indelebile».
Tutto è mutato dal tempo della prima edizione. Completata la sua formazione fuori dalle costrizioni politiche e ideologiche del Regime, circondata dagli stimoli di una metropoli cosmopolita, allo scoppio della Seconda guerra mondiale Cialente inizia una militanza politica attiva per la propaganda antifascista nel Nord Africa. Al rientro in Italia, nel 1947, diventa redattrice culturale dell’«Unità» e della rivista «Noi donne», mentre alla fine degli anni Cinquanta torna a viaggiare al seguito della famiglia di sua figlia, sposata ad un arabista inglese: vive in Kuwait, poi in Portogallo, Iraq, Spagna e infine in Inghilterra, dove si stabilisce definitivamente nel 1977. Intanto pubblica altri cinque romanzi e due raccolte di racconti, vince un Premio Strega, mantiene diverse collaborazioni giornalistiche e diventa traduttrice per Feltrinelli. Muore, quasi sconosciuta, nel 1994. Nel corso di questa durevole, insolita presenza, il suo contributo al panorama culturale italiano è stato singolarmente incisivo e articolato sia sul piano dell’impegno civile sia su quello del rinnovamento linguistico e della qualità espressiva. Eppure, «straniera dappertutto» (così ha l’abitudine di definirsi), resta straniera anche alla tradizione letteraria, che la riconosce tardi, presto la trascura e finisce per dimenticarla, rimuovendola dal canone dei classici e, per ripetuti intervalli, dal mercato editoriale.
Non più la scimmia, ma una figura che indossa un fez rosso compare di spalle e conduce il lettore dentro un cortile di tenui tinte in acquerello – quelle scelte dalla casa editrice La Tartaruga per il nuovo allestimento del romanzo, acceso dal prezioso Ritratto di Melania Mazzucco (Il remoto disordine della vita. Un ritratto di Fausta Cialente). Apparso già nel 2018 come prefazione alle Quattro ragazze Wieselberger (con cui La Tartaruga inaugura la serie su Cialente, seguito nel 2019 da Natalia), il testo di Mazzucco è un appassionato e attento omaggio alla scrittrice, restituita alla cronologia del Novecento per evidenziare i caratteri inconsueti e innovativi delle opere, presentata alle nuove generazioni nella complessità e nella suggestione del suo profilo intellettuale. Una prefazione d’autrice, dunque, che rompe il silenzio e rivendica spazio per una parola di donna secondo la vocazione della Tartaruga: il progetto editoriale, fondato nel 1975 da Laura Lepetit e oggi curato da Claudia Durastanti, è programmaticamente dedicato al recupero e alla selezione di voci femminili altrimenti penalizzate dal mercato.
In questa cornice militante e altamente connotata, torna per essere riscoperto dal grande pubblico il romanzo di Cialente. A distanza di tanti anni, della sua origine fuori posto il testo conserva una giovinezza perpetua, un potere evocativo infaticabile, una prosa lirica e polifonica che non risparmia accenti di disturbante tensione. Poche voci del Novecento italiano mostrano una vocazione così pura per la spettacolarità della parola narrativa, una così sicura sensibilità per la messa in scena di ambienti e personaggi. Nelle pagine di Cialente l’intelligenza che illumina la consistenza figurativa del mondo convive con una profonda fascinazione per il rimosso, per il dominio enunciativo del simbolo e del mito, restituendo al gesto poetico un potere di significato universale oltre il disordine del reale. Così, sullo sfondo in un paesaggio denso e offeso, sempre infiammato ma solcato da ombre lunghe di presagi, si muovono in un tempo fermo le sue figure: quelle femminili (orgogliose anche nella mediocrità, sconfitte ma animate da un’intima disponibilità alla vita) e quelle maschili (inerti e svagate, quando non sono arroganti e sorde), tutte condannate alla seduzione, al rimpianto o al tradimento dalla forza di un protagonista nato sotto il segno della felicità creativa. È nelle sembianze di Marco che l’esperienza della marginalità – geografica, storica, critica, di genere – che ha segnato la biografia dell’autrice si fa invenzione letteraria, si riconosce nella costruzione di uno stile che oppone alla precarietà dell’esistenza la limpidezza dell’espressione. Tradizionalmente votato a esaurire una totalità funzionale, per Cialente il romanzo cresce sul ciglio dell’assenza e della mancanza, sul margine che racconta, sfidandola, l’insufficienza del centro.
Relegato al margine di ogni contratto identitario, lo sradicamento di Marco resta nuovo e travolgente alla prova del tempo perché non cede ad un attivismo picaresco o a un decadente mito di elezione, non conosce trionfo né sconfitta, ma la sola risoluzione di rimanere ostinatamente fedele a se stesso. Una ricerca di libertà che diventa condanna all’esclusione, desiderio di perdersi in una corrente «come gli aquiloni di carta che i bambini mandano su ai primi venti d’aprile» – di ritrovarsi ancora e per sempre nel suo inesauribile, festoso abbandono:
«Seduta sul ramo basso del fico la scimmia sorvegliava Marco che dormiva lì sotto sdraiato all’ombra festosa e ondeggiante delle foglie; dormiva con la bocca aperta e aveva sul petto la camicia sbottonata e macchie di sole…».
Fausta Cialente, Cortile a Cleopatra, La Tartaruga, Milano, 2022 (1936), pp. 304, € 20.