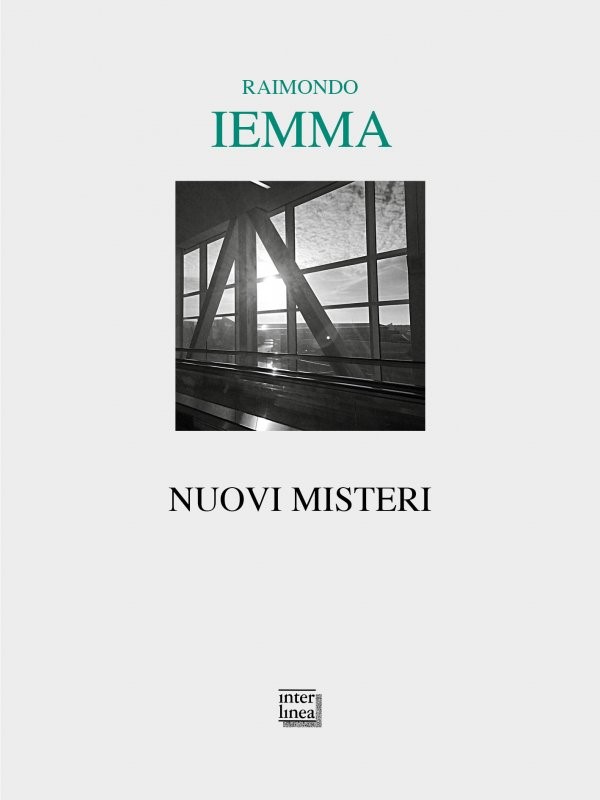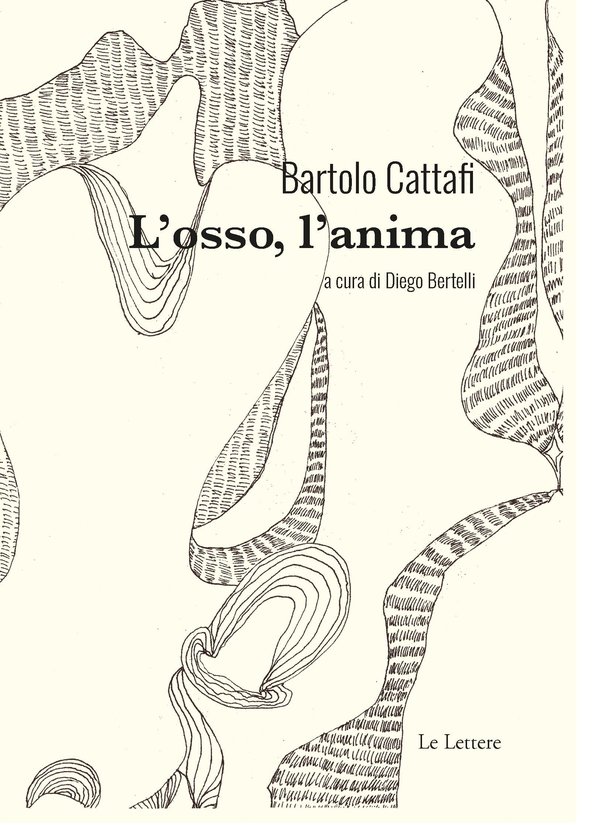Grande assente, eterna moritura: la poesia è inestricabile, pare, dalla vacanza. La balena bianca vi consiglia otto titoli per affrontare la più calda, la più poetica estate della vostra vita (finora).
Raimondo Iemma, Nuovi misteri, Interlinea, Novara 2022 (Roberto Batisti)
I Nuovi misteri di Raimondo Iemma realizzano in poesia quel che riesce sempre più di rado anche alla narrativa: costruire un mondo autonomo e coerente, renderlo abitabile al lettore. Abitabile, non confortevole: i testi allestiscono una dimensione fredda e sottilmente ostile, dal pervasivo retrogusto di sogno inquietante. Territori kafkiani, dunque; e come in Kafka c’è qui un’osservazione insieme affascinata e inorridita delle dinamiche del potere, da quello minimo sul luogo di lavoro alle manovre di palazzo. In questa atmosfera preapocalittica, punteggiata di presagi e di oscuri meccanismi pronti a scattare, frequente è il tempo futuro, e verbi come preparare o incombere. Senza riferimenti didascalici all’attualità né giudizi espliciti, è tuttavia chiaro che il libro riflette gli umori paranoidi dei nostri anni, tra «[u]no stato d’assedio, o comunque d’emergenza […] pronto e documentato», la «attuale epidemia» e la «geografia politica». Iemma, di professione ingegnere, dà l’impressione di aver progettato con cura tutti quei dettagli che possono darci una perturbante impressione di realtà. Questo mondo ha la sua letteratura (le borgesiane sintesi di romanzi immaginari), le sue mode («Sorgono nuovi tipi di giacche»), le sue istituzioni assurde o incomprensibili (dal «settore Zeus» ai «delegati della stratosfera»). Anche il verso, ingannevolmente prosaico nella sua sobria leggibilità, abbonda di effetti ritmici dissimulati; a conferma che qui nulla è per caso, e nulla è quel che appare.
Massimo Palma, Movimento e stasi, Industria e Letteratura, Ancona 2021 (Massimiliano Cappello)
«noi già partiti verso lidi fertili di scavo | a ruminare il sogno d’una mondiale | evasione dei vivi sepolti nelle masse, | nelle fetide fosse dell’assenso comune» (A. Inglese, Ad occhi aperti). A vent’anni dal G8, un poemetto su Genova 2001 poteva apparire quasi ricattato dal suo argomento. Confrontare al riguardo la traccia mazzoniana, secca come una sassata: «per qualche settimana si sentiranno parte di un movimento immenso, un mese dopo si dissolveranno, dieci anni dopo saranno soli e incomprensibili» (La pura superficie, p. 67). Non è difficile pensare che anche a Genova (come altrove, negli anni precedenti e successivi) la verità non fosse qualcosa per cui strapparsi le candide vesti, ma stesse piuttosto nel disvelamento della parzialità insita nell’esperienza dell’interruzione. L’ulteriore lacerazione tra chi ancora ambiva a produrre identità e soggetti entro una linearità storica e storicistica (a darsi un fine e quindi un termine, a farsi homo œconomicus: di qui la buona quota di orrore maschile-poliziesco che serpeggia, non solo in queste pagine) e chi invece si è semplicemente lasciato avvincere dalle fiamme, assieme a nomi, corpi, generalità et similia. Nel calderone linguistico di Palma le fiamme ci sono eccome, e ci finisce tutto, liquefacendosi senza canto e senza ricatto insieme a tutto ciò che a Genova ha voluto farsi simbolo concreto di una giustizia, di un amore, di una verità: ciò che non si può altrimenti avere. Certo, l’alternanza di versi e di prose verte al ben noto “sugo della storia”, tra momenti convulsivi e sintattici, dunque verso un ordine che è in definitiva il ben noto stato delle cose. È la struttura stessa del libro, allora un invito a indagare (nell’antico senso di “stringere le reti attorno alla preda”) un altro senso possibile per questi testi-contesti. Si torna a parlare di violenza e lacrime di liberali, il che fa sempre bene. Meno bene fa sentire ancora accenni a infiltrazioni poliziesche nel black bloc. Anche questo quadro si rivela insomma una cornice; anche perché, diceva qualcuno, siamo tutti sul trespolo. E sporgiamoci, dunque.
Marco Giovenale, La gente non sa cosa si perde, tic, Roma 2021 (Sara Sorrentino e Simone Biundo)
La gente non cosa si perde a non leggere La gente non sa cosa si perde di Marco Giovenale, uscito per Tic edizioni nel 2021. Il gioco di parole è facile e il formato è perfetto per i giri estivi, sta in una tasca. Tra le pagine troviamo un mondo quotidiano frammentato, distorto, fuori sincro, insomma, spaventosamente simile a come solitamente appare.
Quarantadue quadri numerati per nulla rassicuranti che sorprendono e danno al lettore ciò che è del lettore, la responsabilità di capire quello che vuole e che vede senza ricevere lezioni, né di metrica né di moralità. Un libriccino che è un viaggio nelle possibilità, per fortuna infinite, della parola. Come scrive Giovenale: «Non bisogna quindi fare molto affidamento su questo | testo, che ha un larghissimo margine di errore, talmente | largo che vi continua dietro || continua alle spalle del lettore || già lontano, re mo to» (p. 24).
Federico Federici, Profilo minore, Aragno, Torino 2021 (Lucilla Lijoi)
Se è vero che la parola ‘rima’ significa sia ‘identità di suono nella terminazione delle parole, dalla vocale tonica in poi’ sia ‘fenditura’, ‘crepa’, ‘solco’ – il solco sul palmo della mano, la fessura che separa i monconi di un osso fratturato, la spaccatura sulla roccia – allora Profilo minore è un libro di rime, in tutti i sensi che questo sostantivo porta con sé. È un libro di parole dure, lucide, scabre, alla disperata e ossimorica ricerca di fare luce nell’ombra: luce nello spazio fisico (fatto di scorie, polvere, macchie) e luce nello spazio metafisico (fatto di «inesprimibile nulla» e inarrivabile senso), nel quale l’essere resta suo malgrado impigliato. È un libro umilmente titanico, all’interno del quale il poeta – che, in questo caso, è anche un fisico – costruisce per tentativi dei conglomerati semici, degli aggregati di “parole-rima”, destinate a comporre una mappa reversibile del mondo: «di una parola è traccia, | di un’altra tace | la promessa || da una parte mondo | dall’altra nessun luogo» (#22.0). A guidare il lettore nella decifrazione di questa mappa, in dialogo silenzioso coi testi, Federici ha collocato otto tavole, altrettante “rime” – intese come strappi, varchi, squarci di luce – destinate a misurare le potenzialità della nostra umana comprensione: «fosse solo una scintilla | ancora dopo un po’ | un barlume verso il buio | per vedere il dopo» (#II.a + about the horizon).
Gabriel Del Sarto, Tenere insieme, PordenoneLegge – Samuele Editore, Pordenone 2021 (Riccardo Frolloni)
L’ultimo libro di Gabriel Del Sarto è la summa poetica (dal ’95 a oggi) di uno dei migliori poeti della sua generazione, quella dei poeti nati negli anni Settanta, una generazione ancora tutta da comprendere. Credo che possa essere un motivo sufficientemente valido, per il frequentatore di poesia contemporanea, per interessarsi di un libro simile. In Tenere insieme il poeta e personaggio Gabriel (soggetto e oggetto finalmente insieme? Sdoppiamento e sparizione, fiction e non-fiction, ecc.) si confronta con tutta la sua narrazione artistica e umana, e dunque il libro diventa sia auto-commento (auto-antologia? Riscrittura?), sia il tentativo di «tenere insieme» una vita, o meglio, mettere un punto, o meglio ancora, i tre puntini di sospensione. D’altronde, il primo esergo è di Emerson e recita: «Non esiste, propriamente la storia. Esiste soltanto la biografia»; e la poesia finale s’intitola Gabriel is Dead.
Bartolo Cattafi, L’osso, l’anima, Le lettere, Firenze 2022 (Pier Franco Brandimarte)
Torna in libreria una raccolta celebre – non solo tra poeti e poetesse contemporanei che, da carbonari, si trasmettono i maestri più oscuri, ma già tra i massimi critici e poeti dell’epoca, uno su tutti Raboni – L’osso, l’anima di Bartolo Cattafi. Un’avventura per mari di meraviglia terribile. Ogni occasione, anche la più terrestre, per Cattafi si trapunta di varchi dimensionali, fuoriuscite superne. A cent’anni dalla nascita, a trenta dall’uscita di questa raccolta, scoprite, se già non lo amate, questo formidabile poeta, inquieto e vorticoso.
Franco Scataglini, Tutte le poesie, Quodlibet, Macerata 2022 (Elena Niccolai)
È possibile fare filosofia in dialetto? Secondo alcuni no, ma con questo invito alla riflessione si è concluso, tra gli appuntamenti del festival letterario La punta della lingua, l’incontro dedicato alla recente edizione di Tutte le poesie di Franco Scataglini (Ancona 1930- Numana 1994) per i tipi di Quodlibet, a cura di Paolo Canettieri e con l’avvertenza di Giorgio Agamben. E la domanda vale nonostante risulti quantomeno problematico inscrivere Scataglini nell’alveo dei poeti dialettali.
«A sedici anni ho letto Montale, per caso, in una biblioteca circolante dove andavo a portare per mano la mia solitudine, fu come se i più deietti oggetti dell’universo quotidiano si mettessero a parlare in sanscrito». Ma se a chi come Scataglini frequenta le scuole industriali di Ancona la poesia in lingua risuona irrimediabilmente estranea, il marchigiano offre invece una trama linguistica necessaria e funzionale a creare un codice eccezionalmente movimentato, pronto nei suoi scarti nevrotici a sfidare la calma apparente dell’istituto linguistico dominante: dal recupero delle tradizioni romanze (per cui si veda la nota traduzione in settenari del Roman de la Rose) all’inclusione di lessico specificamente filosofico. Il riscatto delle paubres motz: «Voria bagiatte el riso | in gola, a la sorgente: | bagnamme tuto el viso | ’n quel sasso trasparente. || Come un’oliva tonda | in fondo a ’n rivu chiaro, | ’nte l’acqua che m’inonda | io perderia l’amaro».
Una lingua ricca dunque, una sorta di giardino, che è poi l’eredità paterna descritta in M’hai lasciato un giardì — inclusa nella stessa raccolta da cui proviene la poesia appena citata, E per un frutto piace tutto un orto, 1973 — dove nel giro di due quartine affiora uno dei temi cardine, l’afonia di chi tenta la parola dalla marginalità: «C’è chi lascia un poema | e chi non lascia niente | perché esse muto è il tema | de vive, in tanta gente. || Però te m’hai inganato, | vechio, e pe’ non morì | muto com’eri stato, | m’hai lasciato un giardì».
Fuori commercio da decenni, la poesia di Scataglini è ora finalmente apprezzabile nella sua interezza — eccezion fatta per l’autoantologia e le varianti del Rimario agontano di cui si spera di avere presto, assieme ai saggi del poeta, la pubblicazione.
Jean-Marie Gleize, Qualche uscita. Postpoesia e dintorni, a cura di Michele Zaffarano, tic, Roma 2021 (Stella Poli)
«Esiste qualcosa dopo la poesia? La poesia è la pratica di questa domanda», (Integralmente e in un certo senso, p. 29). Nella collana Gli alberi («La collana di critica letteraria con gli alberi in copertina»), dopo l’illuminante Picconi (La cornice e il testo. Pragmatica della non-assertività), escono, tradotti e curati da Zaffarano, i quattordici saggi di Sorties, con l’aggiunta di Opacità critica.
Qualche uscita, appunto: testi di interventi fra il 1993 e il 2011 in cui Gleize ci invita a familiarizzare con l’idea, forse dolorosa per alcuni, ammette, ma non certo impensabile, che la poesia possa smettere di esistere. E che, anzi, una «riconversione della nostra industria logica» possa essere fruttuosa. Ma poi, nella strana ricorsività di questi saggi sparsi ma vicinissimi, ritratta e ammette che «oggi meno che mai», la poesia possa essere «pensata al singolare». Elenca allora, almeno, nel campo culturale: lapoesia, la tradizione, verrebbe da dire in breve, o una certa tradizione; la ripoesia, che tenta di rifondare liricamente lapoesia, sia restaurando sia rendendo più “avvertito e critico” il lirismo, inseguendo un «lirismo paradossale» à la Ponge; la neopoesia, «costantemente a venire», che sperimenta la necessita del linguaggio poetico di rifondarsi continuamente, verso la poesia azione o la poesia-performance; e, infine, la postpoesia, che pensa il proprio operato come al di fuori della sfera della poesia – se «la poesia ha già avuto luogo», il venir-dopo può smettere di ritenere pertinenti i dibattiti sul lirismo o la prosa, può permettersi di farsi sempre «più impur[o]» e non assomigliare più a niente.
Brillante, tranchant, a tratti apodittico, Gleize – che pure guarda altrove – può fornirci coordinate utili per pensare questa posterità in cui nostro malgrado ci troviamo immersi o ricacciati, per, magari, trovarvi quasi un guizzo: «penso la poesia in sé stessa come un compito impossibile, interminabile, impensabile, irrealizzabile. E […] penso la poesia come qualcosa di necessariamente prossimo allo scacco e alla rinuncia. E […] comunque non c’è altro da fare».