Cosa può un compost, si chiede Antonia Anna Ferrante nel saggio pubblicato quest’anno da Luca Sossella Editore, il cui sottotitolo è Fare con le ecologie femministe e queer. In realtà quella di Ferrante non è davvero una domanda, come dimostra l’assenza di punti interrogativi nel suo titolo, coniato sul deleuziano Cosa può un corpo? Lezioni su Spinoza (Ombre Corte, 2007). Più che chiedere, Ferrante propone, stimola alla riflessione, provoca. Non perché la postura della domanda non si addica al suo pensiero, che è tra i più aperti e dialogici del panorama intellettuale italiano, ma perché con il suo saggio l’autrice sembra voler dichiarare che la necessità di discutere di compost – per quanto a prima vista inusuale – sia oggi ineludibile. Il compost in quanto materiale, ma anche in quanto ambiente in cui le demarcazioni tra diversi elementi vengono meno, nonché vettore di processi in cui si rivelano rapporti di interconnessione generalizzata, può diventare lo spettro perfetto attraverso il quale osservare la società, l’accademia, la politica di oggi – ma soprattutto di domani. E allora andiamo per gradi e chiediamoci, accompagnati dalla trattazione di Ferrante, cosa sia di preciso un compost, dove si trovi, quando, come e perché. Le potenzialità implicite nel titolo emergeranno di conseguenza, e con esse la consapevolezza di avere tra le mani uno dei saggi italiani più stimolanti degli ultimi anni, in grado di far reagire con originalità femminismo e ecologia, ma anche critica postcoloniale e pensiero queer.
Cosa
Il compost è «la materia e il processo attraverso cui il rifiuto umido diventa concime nell’agro-ecologia» (p. 8). Processo di trasformazione, dunque, di cooperazione. O meglio di “intra-azione”, attraverso cui funghi, batteri e vermi modificano lo scarto organico intaccandone la struttura cellulare, la quale entra a far parte di un tutto in cui i confini tra esseri e stati non esistono più, a tutto vantaggio delle mutue relazioni. Come distinguere la buccia di una mela da una foglia di insalata quando, dopo alcune settimane dal loro ingresso in una compostiera, entrambe sono state smangiucchiate, entrambe sono marcite, entrambe si sono pian piano trasformate nel terriccio che le circonda, al punto da far dubitare che esistano ancora in maniera autonoma? Antonia Anna Ferrante non si dilunga sui processi biochimici in atto in un compost, ma è chiaro sin da subito che il compost stesso per lei è molto più che una metafora, bensì è «espressione della natura» (p. 43) che si fa «modello di pensiero critico» (p. 11). Come insegna Bruno Latour, del resto, è bene rendersi conto che i discorsi tecno-scientifici non sono neutri e imparziali come l’onda lunga del pensiero illuminista ha lasciato credere. La netta separazione tra i livelli micro e macro dell’indagine scientifica ha fatto sì che si sia data per scontata per molto tempo una “naturale” organizzazione gerarchica della (micro)materia, sulla quale basarsi per produrre e giustificare (macro)architetture sociali fatte di subordinazioni di razza, genere, classe e specie. Al contrario, sulla scia di Karen Barad e dei suoi studi sulla Performatività della natura (ETS, 2017), Ferrante ci ricorda come già l’atomo, dunque il livello minimo di costituzione della materia, sia “ultra-queer”, intrinsecamente poroso, intento in orge di quanti e aperto verso un radicale desiderio macchinico (p. 47).
Dove
Il compost è quindi ovunque. Tutto è, tutti sono compost: interrelati, interdipendenti, interagenti. Ma da alcune prospettive questa consapevolezza emerge con maggiore forza. Prima tra tutte, la prospettiva decentrata e periferica. Scrive Ferrante:
Da napoletana non posso nascondere una certa inclinazione per la “munnezza”, ma preferisco situarmi in questa riflessione come studiosa femminista e terrona. Ancor prima di essere una studiosa, infatti, sono una donna cresciuta nell’attivismo per la difesa della terra e dei beni comuni. […] Ho imparato nei comitati – una forma di auto-organizzazione della partecipazione, orizzontale e dal basso, molto legata ai territori – cosa fosse la violenza ambientale […]. Questo posizionamento riconosce prima di tutto che i miei saperi sono stati prodotti in un’ecologia di relazioni e pratiche, e che sono situati in comunità che hanno esplicitato con estrema chiarezza il rapporto che c’è tra partecipazione, comune, giustizia ambientale, femminismo, colonialità. È solo di recente, tuttavia, che ho imparato l’orgoglio di dirmi “terrona”: la riappropriazione di un insulto, la rivendicazione di un abietto legato alla terra, una forma di resistenza all’esotizzazione del termine indigeno e alla neutralizzazione del termine autoctono (pp. 11-13).
Dal medesimo brodo di coltura (o sarebbe meglio dire compost) napoletano, è emersa non a caso un’altra voce di rilievo dell’ecocritica italiana: quella di Serenella Iovino, che al ventre di Napoli e ai suoi paesaggi della porosità ha dedicato un capitolo del suo fondativo Ecocriticism and Italy: Ecology, Resistance and Liberation (Bloomsbury, 2016), recentemente tradotto dal Saggiatore come Paesaggio civile: Storie di ambiente, cultura e resistenza (2022). L’inquinamento è per eccellenza un fenomeno distribuito e translocale, che rende assurdo e anacronistico qualsiasi concetto di confine, confinamento o barricata nazionalista – come è possibile comprendere una volta che il compost sia stato accolto nelle nostre strutture di pensiero e di azione e lo si sia lasciato fermentare e influenzare schemi statici prima dati per assoluti. È però indubbio che l’impatto diretto di un “orizzonte di tossicità” sulla salute di specifici corpi in specifiche aree renda tali aree più sensibili di altre al «valore collettivo della responsabilità» (p. 13). Napoli è tra queste, ed è qui che si muove il collettivo di Ecologie Politiche del Presente, al cui sito rimanda uno dei vari QR codes inseriti a margine di Cosa può un compost, versioni contemporanee delle glosse medievali che rendono il volume poroso e iperconnesso anche nella forma.
Quando
La riflessione di Ferrante ha preso le mosse in risposta all’apparente eccezionalità dell’“acqua granda” veneziana del 2019 e ha continuato a sdipanarsi nel corso dei primi lockdown e della pandemia ancora in corso, nello sforzo dichiarato di «non pensare questa catastrofe in modo puntuale, ma congiunturale; attraversarla come l’annuncio di uno spazio/tempo in cui la straordinarietà degli eventi sarà sempre più la quotidianità del vivere sulla “Terra condannata”» (pp. 15-17). La condanna è dunque quella dell’oggi, dell’eredità dal passato di un mondo danneggiato che è meglio imparare a non negare, bensì a riconoscere ed affrontare con tutti gli strumenti critici e intellettuali a disposizione. Donna Haraway su tutte insegna a stare nella condanna: Staying with the trouble è il titolo del suo importante lavoro del 2016, che nella traduzione italiana a cura di Claudia Ciccioni e Claudia Durastanti è stato trasformato in Chthulucene: sopravvivere in un pianeta infetto (Nero/Not, 2019). Staying with, quindi, stare con nella con-danna è la strategia da adottare, e il compost è l’esempio perfetto di questa strategia simpoietica, dello stare e del fare insieme per attraversare la turbolenza che a sua volta ci attraversa. Le pratiche politiche della simpoiesi sono per eccellenza sincroniche e diacroniche a un tempo: sono nell’oggi per sopravvivere nel tempo, per farci rendere conto che il futuro «non è innanzi ma tutto intorno» (p. 97). Tra queste pratiche che attraversano in diagonale attivismo, arte e accademia, così come in diagonale si muovono i vermi nel terriccio, Ferrante nomina Trans*plant, «un protocollo di sperimentazioni di transizione verso il vegetale» (p. 63) ideato dal collettivo Quimera Rosa, e Composting the City | Composting the Net, a cura di Shu Lea Cheang, che «mette in parallelo il processo di fermentazione di scarti biologici della vita quotidiana | la frammentazione di un accumulo di dati dell’era delle culture della rete» (p. 85). In aperta opposizione al produttivismo dell’università neo-liberale, ai confini disciplinari e alle gerarchie tra metodi, linguaggi e oggetti di studio, il pensiero di Ferrante si sviluppa seguendo tracce molteplici e movimenti tentacolari, rappresentati in maniera icastica dalle diverse prospettive su un corpo di polpo qua e là tra le pagine del volumetto.
Come
Se l’etimologia stessa di “cultura” implica un movimento verso il basso, di paziente rivolgersi verso il suolo a raccogliere i frutti dello studio e della ricerca (cultura in latino è un derivato di colere, “coltivare”), la cultura del compost riconosce in questo movimento anche la possibilità della caduta scomposta, dell’inciampo. È il sussulto spiazzante che l’autrice intende provocare quando si definisce “terrona”. È l’utilizzo della maiuscola in “Uomo” come «“pietra d’inciampo” che permetta di soffermarsi a pensare che la parola […] non viene utilizzata come termine universale per “umanità” ma, al contrario, come soggetto titolare di specifiche relazioni di potere e sfruttamento nella società capitalista, patriarcale e specista» (p. 30). È la scelta tipografica di fornire le note nelle pagine pari, a sinistra, e il corpo del testo nelle pagine dispari, a destra, innescando un’iniziale confusione che si rivela proficua possibilità di rilettura delle prime pagine, grazie alla quale si impara a considerare le note come parte integrante della trattazione, come elemento fondamentale di una dialettica paritaria con le fonti e le studiose di riferimento. L’inciampo, il sussulto, sono del resto forme di vulnerabilità che il compost insegna a non rinnegare, bensì a rivendicare. Come insegna Ursula Le Guin, altro nume tutelare del discorso di Ferrante – che ne offre in fondo al libro una sua traduzione di “The Carrier Bag Theory of Fiction” (“La teoria narrativa della sacca”) – sin dagli albori la storia non è stata fatta tanto dagli irrequieti «che non avevano un bambino in giro ad animare la loro vita, o abilità nel creare o cucinare o cantare, o pensieri particolarmente interessanti da elaborare» (p. 114) e quindi, annoiati, decisero di andare a caccia di mammut con le loro armi grandi, dure e lunghe. Al contrario, come anche Primo Levi ha rilevato nelle sue riflessioni antropologiche, «il primo dispositivo culturale fu probabilmente un recipiente» (p. 119): una forma uterina, piuttosto che fallica, per conservare tutto quanto fosse commestibile o bello, o in generale utile da condividere. Il compost figura senza dubbio tra le sostanze che, lontane dall’imporre con violenza il proprio stare al mondo, chiedono di essere raccolte invitando al tempo stesso a raccogliersi, a meditare sull’interdipendenza tra gli esseri, su nuove forme di desiderio.
Perché
L’equilibrio dinamico che il compost implica, e che come abbiamo detto prevede un movimento non ordinato, fa esplodere la materia vibrante (categoria proposta nel 2010 da Jane Bennett nel suo Vibrant Matter: A Political Ecology of Things) in una molteplicità di posture e possibili direzioni. La riduzione all’uno non è ammessa in quell’ambiente proliferante forme di vita in continua evoluzione che è la compostiera. La guida unica, l’Uomo solo al comando (o, ed è lo stesso, la Donna sola che abbia introiettato il patriarcato fascista) non hanno posto, perché semplicemente verrebbero disgregati e digeriti da una pluralità di batteri. Jonathan Franzen, nel suo E se smettessimo di fingere? (Einaudi, 2020) – antologizzato anche da Niccolò Scaffai nel recente Racconti del pianeta terra (Einaudi, 2022) – ricorda che per affrontare la catastrofe climatica abbiamo bisogno più che mai di civiltà e sistemi politici in salute. L’assenza di movimento, di reazioni e controreazioni, di fermento e fermentazione rappresenta il contrario di un ecosistema in salute, che si tratti del nostro intestino, del terriccio in una compostiera o di un intero paese. Il parallelo tra il corpo umano e il corpo statale, passando per l’ormai imprescindibile compost, non è casuale. Ferrante a questo proposito introduce nel proprio discorso la SET, Serial Endosymbiosis Theory: un drastico passo in avanti, o positivamente indietro, rispetto al campo dell’evoluzionismo neodarwiniano che prevedeva fossero solo i geni a determinare l’evoluzione degli organismi. «Al contrario, la svolta dell’endosimbiosi sta nel considerare le relazioni ecologiche non come un fattore esterno, ma come un elemento determinante per l’evoluzione genetica stessa» (p. 54). In altri termini, la cooptazione dell’“estraneo” (che sia un nuovo elemento nella comunità simbiotica di microrganismi di un intestino, una buccia di patate nel compost o un essere umano proveniente da lontano nella comunità) non è una possibilità che si possa scegliere di accogliere o meno, bensì è condizione stessa dell’evoluzione. Includendo dunque il compost nell’orizzonte delle nostre conoscenze, comprendendone i meccanismi nei risvolti micro- e macroscopici, i limiti dell’individuo si disgregano, verso una con-dividualità (per dirla con Francesco Remotti) fatta di inevitabili relazioni, di mutualismo e processualità. La natura in questo modo viene disambiguata, demitizzata: non è più qualcosa di esterno alla nostra vita e alle nostre dinamiche quotidiane, qualcosa da salvare e proteggere con un guizzo volontario della coscienza. La natura è la nostra vita, il nostro divenire, il nostro corpo e il nostro compost. E un libro come quello di Antonia Anna Ferrante introduce nuova linfa in questa consapevolezza, dimostrando con convinzione la capacità delle Environmental Humanities di intersecare e proseguire il percorso del femminismo verso una rinnovata, complessa e affascinante prospettiva sull’umano (e, al tempo stesso, sul non-umano).
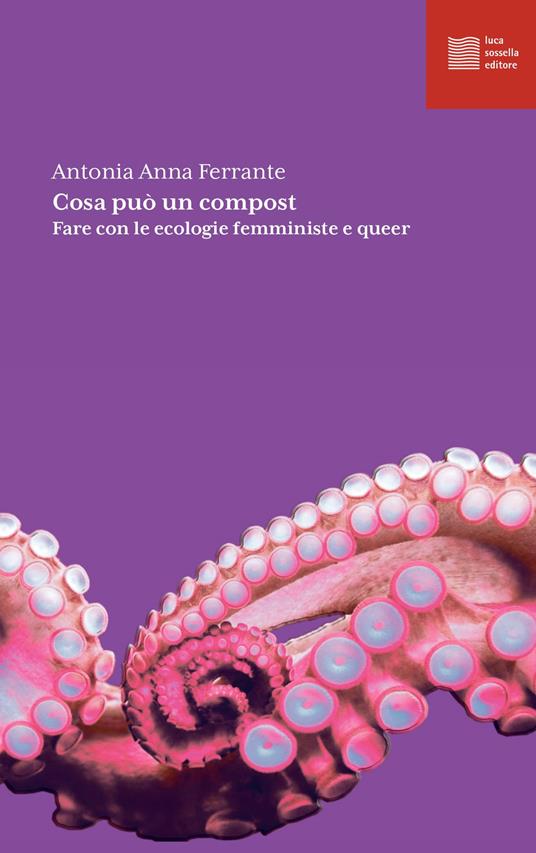
Antonia Anna Ferrante, Cosa può un compost: Fare con le ecologie femministe e queer, Milano, Luca Sossella Editore, 2022, 126 pp., € 10.