Jhumpa Lahiri è una autrice e traduttrice (non per forza in questo ordine) statunitense che, nata a Londra da genitori indiani, si è trasferita e ha vissuto in Italia per alcuni anni. Sembrerebbero dati sterili, se non fosse che per apprezzare la prosa e le riflessioni di Lahiri è fondamentale conoscerne l’identità linguistica, frammentata ed eterogenea, ampiamente raccontata in interviste e articoli, ma su cui riflette in modo definitivo e approfondito nel volume Translating Myself and Others (Princeton University Press, 2022).
Già nell’introduzione di questa raccolta di saggi, Lahiri racconta come essere cresciuta bilingue l’abbia messa precocemente (anche prima di imparare a leggere o a scrivere) davanti all’atto del tradurre (dall’inglese e dal bengalese). Nel 2000 Lahiri comincia a scrivere, in inglese, narrativa (Interpreter of Maladies) e saggistica (To Heaven Without Dying), e riflette sulla sensazione di appartenere a un mondo linguistico spaccato in due, riferendosi alla sua scrittura come a una traduzione culturale («cultural translation») ogni volta che racconta in inglese di personaggi che nella sua immaginazione parlano bengali. Il dottorato in Studi Rinascimentali, il trasferimento in Italia, l’amore per l’italiano e la sua conoscenza più approfondita complicano e arricchiscono l’identità linguistica e scrivente di Lahiri, che a partire da questo momento comincia anche a scrivere direttamente in italiano. Se scrivere in un’altra lingua sembra essere un’urgenza naturale, dall’altra parte non risparmia l’autrice-traduttrice dalle difficoltà ma soprattutto dalle implicazioni personali che questo atto comporta, riaccendendo ogni volta il dolore di essere sospesa tra i due mondi a cui ha sempre sentito di appartenere e non appartenere contemporaneamente.
Translating Myself and Others è prima di tutto una dichiarazione d’amore alla lingua italiana, e ancora di più un’analisi del confine tra scrittura e traduzione e dell’importanza (non sempre riconosciuta) che quest’ultima ricopre nell’ambito letterario. Ma è anche un viaggio introspettivo nella soggettività e nell’identità dell’autrice-traduttrice, alla ricerca coraggiosa del riconoscimento della propria voce e del proprio mestiere. Il libro raccoglie dieci saggi scritti tra il 2015 e il 2021 a Princeton e a Roma (ad enfatizzare, di nuovo, il mondo spaccato in due dell’autrice-traduttrice), tre dei quali scritti in italiano e poi tradotti in inglese («Why Italian?», «Lingua/Language» e «Calvino Abroad»), e i restanti sette scritti inizialmente in un ibrido di italiano e inglese e poi uniformati all’inglese: si tratta delle introduzioni alle traduzioni inglesi di Lacci e Scherzetto e della postfazione alla traduzione di Confidenza di Domenico Starnone, della postfazione alla traduzione inglese de Le metamorfosi di Ovidio, di appunti o lezioni tenute da Lahiri a Princeton, di riflessioni sparse o saggi su Gramsci e Calvino.
Mentre l’eterogeneità dell’indice potrebbe lasciare presagire un’opera slegata e frammentata, come l’identità dell’autrice-traduttrice stessa, stupisce invece quanto testi così vari per genere e cronologia siano posizionati e accostati in modo tale da creare un unico, lungo discorso, la cui fluidità intrappola chi legge, a prescindere dal suo interesse per la traduzione, bilingue o no. La riflessione portata avanti incessantemente da Lahiri nell’arco degli ultimi sette anni trova organicità proprio nell’operazione editoriale di raccogliere testi già editi preceduti da un’introduzione (unico scritto inedito) che fornisce il giusto contesto (spaziale, temporale ed editoriale) e che tira le somme delle sue osservazioni sparse.
Attraverso l’esperienza personale che accompagna sempre il lavoro “filologico” minuzioso su opere amate e studiate, Lahiri denuncia come la traduzione sia stata relegata a satellite della letteratura, mera funzione al suo servizio, falsamente considerata un tradimento (ma Pavese ci ha insegnato che la vita è tutta un tradimento, come ricorda l’autrice-traduttrice in questo volume), quindi senza dignità propria, priva di letterarietà e di autorialità. Condizione che si inasprisce se a tradurre il proprio testo è l’autrice stessa. In questo resoconto personale, scrittura e traduzione si intersecano e sovrappongono proprio nel tentativo di tracciare il confine tra l’una e l’altra: scrivendo di traduzione Lahiri non solo offre pagine di critica letteraria preziose, ma un testo narrativo di valore; scegliendo i concetti e le metafore da usare per parlare di (auto)traduzione, l’autrice non fa altro che tradurre, nel senso di trasportare concetti e immagini già codificati per adattarli (e tradirli?) al suo studio e alla sua esperienza, offrendo l’esempio concreto di quanto l’atto del tradurre sia “immaginativo” (imaginative) più che “imitativo” (imitative).
L’immagine ovidiana di un’isola che emerge dalle acque per ritrovarsi in mezzo a un arcipelago diventa metafora della lingua italiana che è emersa per rimanere nella realtà già frammentata dell’autrice-traduttrice. Di nuovo da Le metamorfosi di Ovidio arrivano Eco e Narciso a spiegare come la traduzione sia solo una voce senza volto e come l’auto-traduzione sia l’atto di guardarsi allo specchio senza riconoscersi. Da Le metamorfosi di Lalla Romano, invece, le porte che perseguitano oniricamente la voce narrante diventano in Lahiri le parti che costituiscono una lingua straniera da conquistare (comprensione, sintassi, grammatica, pronuncia, lessico, scrittura). La “traduzione”, nel senso di trasporto, in carcere di Gramsci è pretesto per ragionare sulla dinamicità della lingua, sempre in movimento.
Questi sono solo alcuni esempi di come Lahiri rielabori e traduca modelli passati per ragionare su se stessa e sull’atto del tradurre, dando loro vita nuova, raccontando e raccontandosi. Insomma, se da bambina ha imparato a tradurre prima che a leggere e scrivere, da scrittrice non può considerare separatamente l’atto della scrittura e quello della traduzione: scrivendo, Lahiri traduce. Questa sovrapposizione è resa possibile anche dalla spiccata letterarietà della prosa saggistica di Lahiri, che può ricordare La framtumaglia (edizioni e/o, 2003)o I margini e il dettato (edizioni e/o, 2021) di Elena Ferrante – e d’altra parte Lahiri stessa annovera tra i suoi modelli letterari italiani proprio quest’ultima e Lalla Romano.
Anche i modelli si intersecano e si incontrano in modo discreto ed elegante. Di Romano recupera concetti che diventano metafore della traduzione e della condizione stessa dell’autrice-traduttrice, come quello della cecità che la scrittrice italiana definisce un vero e proprio punto di vista, o come quello dei margini, nei quali si «trovano le possibilità», che richiamano però anche il cuore dell’ultima opera saggistica di Ferrante, I margini e il dettato, appunto. Di Ferrante, invece, recupera lo stile e il registro poco accademici nonostante il taglio teorico dell’opera, ma soprattutto un approccio tutto personale e mai asettico nei confronti di una scrittura che, come è stato fatto notare a Lahiri stessa (da uomini, specifica in modo significativo l’autrice-traduttrice), dovrebbe vederla meno protagonista se l’intento è quello di riflettere su testi altrui o su questioni teoriche.
Ma proprio la presenza della soggettività dell’autrice-traduttrice (in questo ed altri suoi scritti) amplia la questione analizzata, gettando luce sulla frammentarietà dell’identità femminile (scrivente), che se scrive e traduce è e diventa («to be a writer-translator is to value both being and becoming»), creando la coesistenza problematica di una pluralità di identità diverse che finiscono per annullarsi in una non-identità (“a double or plural identity can be a lack of identity”). Essere scrittrici-traduttrici significa non essere, farsi scomparire, celarsi nel testo, ancor di più se il testo è una traduzione. Ecco, dunque, che un libro già ricco dal punto di vista artistico e teorico diventa prezioso anche da un punto di vista politico. La scrittura di Lahiri diventa attivista, in chiave di genere ma non solo, quando rivendica a voce alta il diritto di inserirsi nei suoi testi, non solo e non più di parlare di sé tramite gli altri, ma anche di parlare degli altri tramite la propria soggettività e la propria esperienza. Non è più sufficiente che la sua voce venga ascoltata, rischiando di rimanere una Eco, ma è forte la richiesta che anche la sua persona e il suo mestiere di scrittrice-traduttrice vengano presi in considerazione, con tutta la loro complessità a frammentarietà, così da poter essere e diventare.
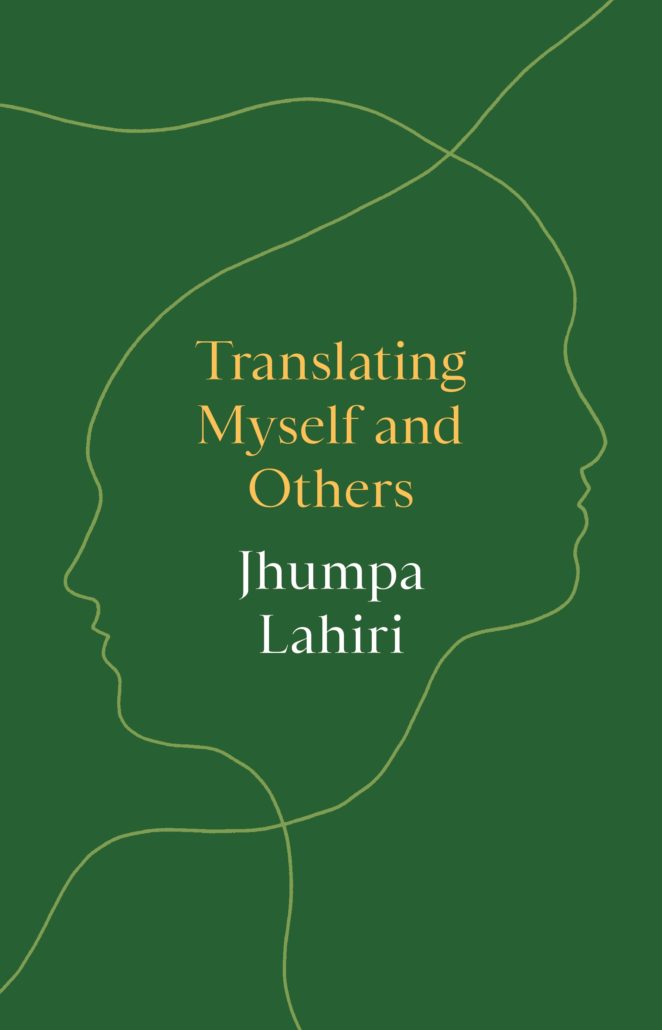
Jhumpa Lahiri, Translating Myself and Others, Princeton UP, Princeton, 2022, pp. 208, $21,95.