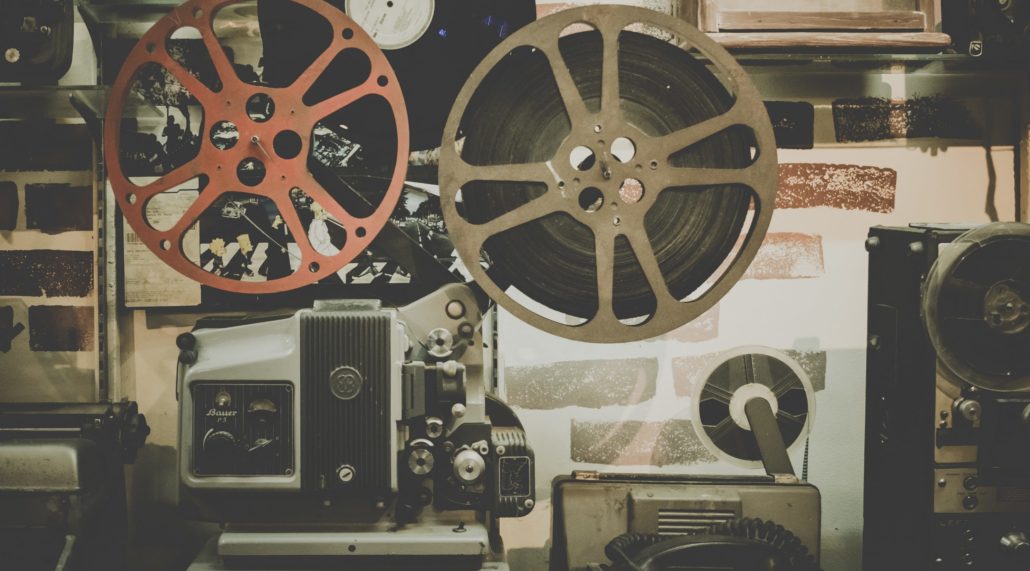Preferisco giocare a carte scoperte. Mi preme dire fin da subito che ciò che mi propongo di fare in questo contributo è parlare di alcuni esempi di cinema italiano degli ultimi vent’anni dove una marcata e percepita presenza di cinepresa e soggettività sembra essere al tempo stesso motivo e risultato di un rinnovato interesse nella forma filmica. Mi esporrò ulteriormente dicendo che tale interesse e il suo uso in rapporto alla relazione tra cinepresa e soggettività ricorda esperimenti e dibattiti che il cinema di Antonioni, Fellini e altri auteurs suscitò negli anni sessanta. Si scansino però fin da ora gli equivoci. Non sto parlando di una nostalgica ripresa di quel cinema e tantomeno ho come obiettivo quello di elencare pedissequamente nel cinema di oggi quello che si trova del cinema di ieri. Tenendo ben presente le dovute differenze, trovo che certe idee usate in quegli anni per comprendere un dato modo di formare come impegno sulla realtà, per usare un’espressione dell’Umberto Eco di Opera aperta, siano utili a mostrare come l’elaborazione formale di alcuni film italiani contemporanei parli un linguaggio eticamente e politicamente significativo nel contesto attuale. La mia riflessione si dividerà in tre parti. Nella prima, mi avventurerò brevemente in alcuni scritti di Pier Paolo Pasolini, Gilles Deleuze e Umberto Eco per definire più precisamente quello che intendo per presenza di cinepresa e soggettività e il loro rapporto. In seguito, analizzerò alcuni esempi di questo rapporto nei film di Paolo Sorrentino e Alice Rohrwacher.
Cinepresa e soggettività
I miei riferimenti teorici principali sono due: da un lato il saggio di Eco a cui ho appena fatto riferimento (1962); dall’altro il saggio di Pier Paolo Pasolini sul “cinema di poesia” (1965), da cui partirò. Prendendo come esempi i film di Antonioni, Bertolucci e Godard, Pasolini definisce il “cinema di poesia” come un cinema dove la soggettività autoriale sfida le convenzioni narrative attraverso un uso personale della cinepresa. Secondo Pasolini, questo uso si manifesta in due modalità: l’uso della “soggettiva libera indiretta” e l’impiego di tecniche autoriflessive che fanno percepire la presenza della cinepresa e il linguaggio cinematografico come tale. Nella prima modalità, il regista usa la cinepresa per dare espressione alla propria soggettività mentre, simultaneamente, costruisce quella del proprio personaggio. I segmenti autoriflessivi, invece, minano dall’interno qualsiasi discorso narrativo e rendono conto dell’esplorazione del mondo da parte del regista attraverso la cinepresa. La lettura del discorso pasoliniano fatta da Gilles Deleuze ci aiuta a vedere la pregnanza etica di queste modalità, in quanto in esse l’io del regista si attualizza attraverso il rapporto con l’altro, umano (personaggio) e non-umano (cinepresa). Questa attualizzazione, sempre secondo Deleuze, è reciproca: come la soggettività del regista si cristallizza attraverso il rapporto con il personaggio e la cinepresa, così il personaggio costruisce il proprio io in relazione alla macchina e la macchina stessa afferma la propria presenza come sguardo sul mondo dante corpo alle soggettività del regista e del personaggio. Perciò, secondo quanto ritroviamo in Pasolini e Deleuze, l’elaborazione formale di un’opera si configura come un insieme di relazioni che coinvolgono simultaneamente molteplici soggettività, le loro relazioni reciproche e la loro determinazione.
Possiamo sviluppare ulteriormente queste considerazioni rivolgendoci al testo di Eco. In esso, Eco sostiene che, molto di più rispetto al contenuto, l’organizzazione formale di un’opera artistica rivela come essa incorpori un modo di vedere e essere nel mondo e, attraverso questo, si relazioni ad altri. Per esempio, secondo Eco, la crisi morale e cognitiva scatenata in quegli anni dalla rapida industrializzazione e le nuove scoperte scientifiche è meglio raccontata da forme che fanno proprie queste incertezze piuttosto che da organizzazioni formali convenzionali e armoniche. Film “senza finale” come L’eclisse di Antonioni si impegnano nella propria realtà perché accettano di definire la propria organizzazione formale a partire dalla crisi della modernità. E questa disponibilità verso la situazione (esistenziale, storica, culturale, politica) in cui l’opera si viene a formare, così come un certo scetticismo a partire dal quale essa guarda a schemi convenzionali e illusori, sono gli ingredienti di quello che Eco definisce come impegno sulla realtà. Le opere aperte di Eco sono opere impegnate perché l’autore rinuncia a trasformare la propria visione del mondo in un principio unificante e, così facendo, fa dell’interazione ambigua di molteplici soggettività con il mondo dell’opera il proprio motore.
I saggi di Pasolini, Deleuze e Eco ci aiutano a vedere l’organizzazione formale di un’opera come un insieme di relazioni che coinvolgono molteplici soggettività in un dato momento storico, sociale e culturale. Dal punto di vista cinematografico, il perno centrale del discorso mi sembra coincidere con il ruolo che la presenza della cinepresa gioca in questo insieme. Per Pasolini, questa presenza autoriflessiva è segno delle peculiarità espressionistiche del regista la cui soggettività si attualizza nelle immagini; in Deleuze, la presenza della cinepresa è il motore di una correlazione differenziale tra diverse soggettività che si costituiscono reciprocamente; infine, in Eco, essa è la via attraverso cui l’opera si auto-dichiara visione parziale e costruita del mondo che, non chiudendosi in sé stessa e rimanendo aperta ad ambiguità e continui mutamenti, favorisce la presa di coscienza di tale parzialità e mutevolezza da parte del fruitore. Con diverse tonalità e sfumature, questi approcci alla presenza della cinepresa ne interpretano la presenza in senso etico e politico, in quanto la tramutano in spunto per la discussione del rapporto con l’altro da sé e le gerarchie o tensioni monopolizzanti che con questo altro si instaurano nell’immagine.
Paolo Sorrentino
Siamo all’inizio di Le conseguenze dell’amore (2004). Per circa due minuti, la cinepresa osserva immobile, imperterrita e da lontanissimo un nastro trasportatore su cui si trova un facchino in divisa che trasporta una valigia. La lentezza del nastro è snervante, il dittico di facchino e valigia statico come due statue di sale. La palette cromatica dell’immagine, grigi, bianchi e beige tutti ricoperti da una patina azzurro ghiaccio, così come le linee geometriche che rimarcano la profondità prospettica del corridoio dove il nastro si estende, danno l’idea di un ambiente asettico, chirurgico, inesorabilmente vuoto. Sembrerà paradossale, ma proprio in questa nettezza scarna e, se si vuole, realistica, percepisco la presenza di uno sguardo, quello della cinepresa, e di una soggettività che articola sé stessa attraverso un rapporto peculiare con tale sguardo. Domandiamoci dunque come la nostra riflessione teorica sul rapporto tra cinepresa e soggettività ci aiuti a capirne l’articolazione.
In primo luogo, è necessario osservare come l’enfatizzare simmetrie, forme geometriche e la staticità apparente o reale di determinati elementi dell’immagine attraverso angoli inusuali e movimenti lenti della cinepresa (soprattutto carrelli) sia tipico dello stile di Sorrentino, dal film citato a Il divo (2008) e i più recenti La grande bellezza (2013) e È stata la mano di Dio (2021). Questo non significa ridurre ad un’unica chiave di lettura tutte le sfaccettature dello stile sorrentiniano. Al contrario, significa riconoscere il tentativo del regista di articolare la propria soggettività e una certa visione del mondo attraverso il proprio rapporto con il mezzo cinematografico.
Si pensi all’ultimo film citato, forse quello dove questo elemento risulta più evidente, viste le dichiarate componenti autobiografiche, e in particolare alla scena della visione di Maradona in macchina. Oggetti e figure umane sono immobili e costituiscono un complesso statuario che mette in risalto la panoramica della cinepresa che, ruotando, si avvicina alla figura del calciatore galvanizzata dai cori da stadio di sottofondo. Una scena di questo tipo non esprime soltanto un’intensità affettiva associata ad una certa soggettività nel suo attualizzarsi, ma dice anche di come tale attualizzazione avvenga attraverso il rapporto con la soggettività altra, mobile, rimarcata della cinepresa. Tuttavia, queste considerazioni non fanno giustizia a quello che avviene veramente nella scena, poiché Maradona è innanzitutto visto da Fabietto, il protagonista, che dicendo “È lui!” in un certo senso avvia la scena descritta. Resta però valida la nostra osservazione sulla presenza di soggettività e cinepresa, in quanto lo sguardo della macchina non corrisponde a quello di nessun personaggio e quindi articola la visione soggettiva di regista, personaggio e cinepresa attraverso una correlazione differenziale che ne evidenzia i legami senza sovrapposizioni nette o totalizzanti. Questa scena può essere un esempio della pasoliniana “soggettiva libera indiretta”, a patto che si tenga presente il tripartito gioco di soggettività tra le figure coinvolte nella dimensione narrativa (il personaggio), a cavallo tra diegesi e extra-diegesi (la cinepresa) e al di fuori di essa (il regista).
Fare questo tipo di discorso risulta facile con un film dove gli spunti autobiografici abbondano (a tal punto da farne un documentario a parte come È stata la mano di Dio attraverso gli occhi di Sorrentino). Nel caso di Le conseguenze dell’amore, però, il regista non ha un alter ego così conclamato come nel suo film napoletano e quindi l’articolazione della soggettività attraverso la resa stilistica risulta ancora più sottile ed elaborata. Titta Di Girolamo, il protagonista, è un commercialista cinquantenne con un ambiguo rapporto con l’eroina che, per conto di Cosa Nostra, deposita periodicamente grosse somme di denaro presso una banca svizzera ed è per questo costretto a vivere in “cattività” in un hotel. La vita di Titta è ripetitiva, monotona, silenziosa, lenta, programmata nel dettaglio perfino nei suoi eccessi (farsi di eroina una volta alla settimana, esclusivamente il mercoledì mattina alle dieci, senza sgarri). Lo stile di Sorrentino non è semplicemente ciò che rappresenta tale monotonia, ma è ciò che la attualizza performativamente, attraverso, per esempio, le simmetrie, le geometrie delle componenti visuali preservate dall’uso di campi lunghi o medi e la lentezza dei movimenti di macchina. Questi sono i momenti in cui il linguaggio del regista vive la cattività che Titta sta vivendo. Eppure, è innegabile che questi siano anche modi per il regista di esplorare le possibilità linguistiche del mezzo cinematografico, di spostarsi nello spazio filmico assumendo una posizione ambigua rispetto alle logiche del suo personaggio o, quantomeno, interpretandole con una dose marcata di espressione personale. Si pensi, per esempio, al movimento rotatorio di macchina durante l’unica seduta di eroina che viola la periodicità del rito. Questo movimento è estremamente lento e altamente disorientante, e quindi quasi in sintonia con lo stato alterato del personaggio, ma al tempo stesso diametralmente opposto agli spostamenti del corpo di Titta e ad una resa convenzionale dell’azione. In qualche modo, sembra qui riprodursi quella dinamica tra personaggio nevrotico e autore che Pasolini notava nel cinema moderno. Il linguaggio stesso, però, problematizza la riduzione delle proprie tecniche alla visione del mondo del personaggio o del regista. Per esempio, l’identificazione tra lo sguardo del primo e quello della cinepresa è ripetutamente smentito da scene che sembrano operare in soggettiva ma poi vedono il protagonista fare il suo ingresso nell’inquadratura. Che questo sia uno stilema già usato da Antonioni negli anni ’60 non è di per sé rilevante. Ciò che conta è che questa dinamica avviene anche in momenti di forte intensità emotiva da parte del protagonista – come quando nel finale Titta cammina in un corridoio che lo porta all’incontro con i capi di Cosa Nostra – e, secondo le convenzioni narrative classiche, di coinvolgimento dello spettatore. È proprio in questi momenti che il regista sceglie di rimarcare la presenza di una soggettività altra che è con il personaggio ma non è del personaggio. La stessa dinamica emerge quando, nel primo degli appuntamenti di Titta con l’eroina mostrato dal film, la cinepresa inizialmente opera un primo piano sul braccio dell’uomo, teso verso la finestra aperta, ma poi lo lascia disinteressandosene e guardando fuori dalla finestra, dove la barista dell’hotel di cui Titta è timidamente infatuato sta camminando. Per tutta la durata della scena la voce fuori campo di Titta parla del suo rapporto con la droga e perciò focalizza la nostra attenzione su quel discorso. La cinepresa, tuttavia, sembra avere un altro interesse o quantomeno sembra avere un interesse autonomo, indipendente, per l’emotività del protagonista, tanto da dedicare il proprio sguardo ad una figura che non ha alcun rapporto logico con l’episodio rappresentato. Perché guardiamo fuori dalla finestra quando l’episodio raccontatoci avviene alle nostre spalle?
In Le conseguenze dell’amore, il rapporto tra soggettività del protagonista e cinepresa disorienta, spiazza, insinua ambiguità nella resa degli eventi. Lo stesso effetto hanno le numerose inquadrature che giocano con gli effetti visivi prodotti da specchi e vetrate. Soprattutto nella hall dell’hotel, la compresenza di immagine reale e riflessa della stessa figura, così come la disillusione creata da uno sguardo rivolto ad un personaggio riflesso che poi si muove e si scopre essere altrove, complicano qualsiasi comprensione razionale degli spazi e, perciò, qualsiasi tentativo di chiusura e controllo. In un certo senso, l’apertura di questi squarci nello spazio cinematografico, così come il discostarsi autonomamente dalle azioni di Titta, è il tentativo della cinepresa di evadere dalla cattività del personaggio e, al tempo stesso, di indicare in un certo modo di esplorare l’emotività una possibilità di scampo dalla prigionia. Ciò che è solo in apparenza paradossale, ma in realtà ha una profonda rilevanza per una riflessione etica al confine tra umano e non-umano, è che questo enfatizzare il ruolo dell’affettività provenga da un’entità, la cinepresa, totalmente priva di emotività. L’eticità di queste considerazioni giace nella disponibilità a riconoscere, in quanto umani, che emotività e affettività, ciò che condiziona e determina la propria soggettività, sono co-determinate da ciò che non è esclusivamente umano – la materia.
Alice Rohrwacher
Nel film di Sorrentino, il rapporto tra soggettività e mezzo cinematografico si articola sullo sfondo dello scontro tra ambiguità, imprevedibilità, mancanza di controllo da una parte, associate con un certo tipo di affettività, e dall’altra calcolo, violenza sulla realtà, presunzione di controllarne ogni fenomeno nel piccolo dettaglio, dal numero di banconote che Titta trasporta periodicamente in banca ai sentimenti. I film di Alice Rohrwacher si muovono su uno sfondo simile, ma rispetto al cinema sorrentiniano scelgono programmaticamente di esplorare questa ambiguità, imprevedibilità e incontrollabilità emotive accompagnando da vicino i propri personaggi e le loro storie. La forza di questi film sta tutta nel loro modo di guardare a queste storie, quasi documentario, cronachistico – e quindi, in un certo senso, ruvido, grezzo – e al tempo stesso intimo, empatico e densamente affettivo.
Corpo celeste (2011), il primo lungometraggio della regista, ha in questo modo di guardare non solo il proprio principio formale, ma anche il motore della narrazione. La protagonista Marta, una ragazzina di tredici anni, si è appena trasferita con la famiglia dalla Svizzera alla Calabria. Lo sfondo della cittadina calabrese dove vive è anonimo, falcidiato dalla cementificazione del paesaggio, mentre le sue relazioni sociali sono tormentate, da un lato, da una sorella maggiore aggressiva e, dall’altro, da un’autoritaria maestra di catechismo, Santa, che arriva perfino a schiaffeggiarla in pubblico. La chiesa, i suoi intrecci con la politica (si veda il ruolo del prete che conta i voti per il candidato alle prossime elezioni) e la cultura dello spettacolo (la foga dell’apparire è costantemente enfatizzata nella rappresentazione delle cerimonie religiose) sono i due apparati ideologici che, nel film, ambiscono a monopolizzare i modi di pensare e agire. Si pensi alla scena che precede di poco lo schiaffo di Santa a Marta. La maestra, nel tentativo di far capire ai ragazzi che cosa significa cresimarsi e diventare un “soldato di Cristo”, suggerisce loro di immaginarsi come Rambo, il personaggio reso popolare dai film con Silvester Stallone.
Il monopolio dello spettacolo sulle culture non solo globali, ma anche locali, sarà tema centrale anche di Le meraviglie (2014), dove un programma televisivo trasforma il paesaggio rurale del centro Italia in una merce che deve essere venduta al pubblico e mette in palio un ricco premio che aiuterà un contadino locale a rendere l’area più attrattiva per i turisti e quindi a fomentarne la mercificazione. La scelta della regista di accompagnare le incertezze dei suoi protagonisti in questi film dice già del suo tentativo di domandarsi se queste logiche monopolizzanti siano veramente tali e fino a che punto. Da una prospettiva cinematografica, in Corpo celeste la risposta assume un carattere fortemente autoriflessivo, in quanto il gesto che rivela a Marta l’esistenza di un altro modo di vivere quella realtà è il guardare. Nell’arco del film, la ragazza trova “rifugio” in cima alla palazzina dove vive o in angoli anonimi dello spazio urbano. Da queste posizioni è in grado di osservare il paesaggio e notare, a più riprese, un gruppo di ragazzini che raccolgono rifiuti ingombranti come vecchie poltrone e bidoni. Elemento fondamentale di queste sequenze è che esse non seguono sempre la successione di inquadrature classicamente associata ad una soggettiva. Seguendo una modalità di accompagnamento del personaggio che si ripete anche in altri momenti di quotidianità e intimità come il lavarsi, la cinepresa mostra il volto di Marta mentre guarda e quello che sta guardando, proponendosi come sguardo con il personaggio e non necessariamente suo. Con questo punto di partenza, e sebbene le immagini che seguono possono essere interpretate come soggettive pure, si è sempre invitati a pensare alla sorgente dello sguardo come molteplice, impura, combinazione di soggettività caratteriale e mezzo cinematografico.
È interessante notare come, nel prosieguo della storia, questa enfasi sullo sguardo si allarghi e includa una più profonda riflessione su altri modi di percepire il mondo. Quando Marta accompagna il parroco a prelevare un crocifisso di legno dal vecchio paese d’origine dell’uomo, paese ormai disabitato, l’incontro tattile con il crocifisso si rivela essere molto più intensamente religioso e intimo dei quiz e test stile “Chi vuol essere milionario?” che Santa propone durante le lezioni di catechismo. Se l’atto inizia come un’esplorazione del corpo legnoso del Cristo, il gesto diventa presto un modo per la ragazza di prendersene cura ripulendolo dalla polvere e dallo sporco. La mano di Marta e il contatto con il legno sono catturati in primo piano, con nessun altro elemento nell’immagine e con movimenti minimi, quasi impercettibili. La sensibilità della cinepresa per il gesto è la sensibilità di Marta per certe entità che vivono ai margini del reale. L’episodio dei gattini trovati per caso in chiesa e poi uccisi barbaramente da un collaboratore del parroco è un passaggio chiave che porterà Marta a scoprire quella fetta di realtà dove la sua sensibilità è accolta. Decisa a scoprire dove questo collaboratore sta buttando i gattini, Marta giunge ad un sottopassaggio allagato. La ragazza non lo attraversa subito, ma vi ritorna nell’ultima scena del film. Echeggiando l’apertura di Corpo celeste, dove la scena notturna di una processione avvia il film in una delle situazioni più ambigue per una ripresa cinematografica, vale a dire in un luogo privo di luce, l’attraversamento del sottopassaggio avviene in un’inquadratura dal contrasto fortissimo tra aree buie e illuminate. Il ritorno alla luce segna la scoperta del luogo dove i ragazzini visti più volte da Marta portano i rifiuti raccolti: una spiaggia dove, a quanto pare, questi ragazzini stanno costruendo una casa riusando i vari materiali. Uno di questi, avvicinandosi a Marta, le mette in mano un animaletto che saltella vivacemente tra le mani della ragazza, che sorride. Corpo celeste si chiude con la possibilità di esperire il mondo attraverso sguardi, affettività e sensibilità altre da quelle delle logiche dominanti dello spettacolo e dell’autorità (religiosa o politica). La storia porta chiaramente a questa conclusione, ma è lo stile di Rohrwacher a metterci in condizione di stare con la protagonista e avere fiducia in questa sensibilità mentre, all’inizio del film, siamo confusi e disorientati dal buio e, alla fine, attraversiamo con lei il sottopassaggio.
Questa disamina di alcune scene tratte dai film di Sorrentino e di Rohrwacher ci ha portati a focalizzarci su un particolare uso della cinepresa in relazione alla soggettività del singolo regista o dei suoi personaggi. Non si può certo dire che questi esempi rendano conto in modo esaustivo di come questa dinamica operi in altri film e nel panorama del cinema italiano contemporaneo. Inoltre, parlare di un ritorno alla forma in questo panorama non significa soltanto ridurlo ad un uso della cinepresa, alle sue posizioni e ai suoi movimenti. L’articolazione di soggettività e sguardo cinematografico può prendere altre vie, per esempio una certa confusione nell’uso di suono diegetico ed extra-diegetico o un particolare aspetto del montaggio, che in questo contributo sono rimasti molto marginali. Perciò, se da un lato questa analisi ha mostrato la rilevanza di un certo approccio analitico, dall’altro essa ha esaminato solo alcune delle molte sfaccettature che l’articolazione della soggettività assume nel cinema italiano di oggi. Queste sfaccettature rimangono in gran parte da esplorare e percorrere facendo reagire forme, stili e temi diversi. Questo contributo rappresenta anche un invito ad avventurarsi in questo percorso, tanto complesso quanto denso di significati etici e politici.