Noi siamo sotto l’incubo di problemi e condanne terribili che non ci fanno piangere e tremare unicamente perché son divenute tanta parte della nostra vita quotidiana che non ci riflettiamo più.
G. Papini, dalla Seconda prefazione (Ai filosofi) a Il tragico quotidiano
Secondo la formulazione ormai celeberrima contenuta ne De l’essence du rire di Baudelaire (che forse più ancora delle Fleurs du mal e in pari con i Petits poèmes en prose inaugura la modernità letteraria e non solo), «l’artiste n’est artiste qu’à la condition d’être double et de n’ignorer aucun phénomène de sa double nature».[1] Una “doppia natura”, quindi, di attore e spettatore, di carnefice e vittima, di grandezza e meschinità. Se a questo rilievo baudelairiano si aggiunge una sorta di titanismo cerebrale dell’intelligenzavista come suprema conquista umana, e soprattutto la lezione nietzschiana di inizio Novecento, si può intendere meglio il senso dell’autoritratto che Giovanni Papini traccia di sé in quella sorta di autobiografia romanzata che è Un uomo finito (1913):
Io sono, per dir tutto in due parole, un poeta e un distruttore, un fantastico e uno scettico, un lirico e un cinico. Come queste due anime possano stare insieme e trovarsi bene, sarebbe troppo lungo a descrivere. Ma veramente è questo il fondo dell’anima mia. (dall’edizione Mondadori, 1964; p. 237)
Molto più di un “semplice” «catalizzatore e volgarizzatore… di temi culturali» come lo ebbe a definire Gianfranco Contini riferendosi soprattutto all’altalenante ed ondivaga produzione saggistico-speculativa e militante dello scrittore fiorentino, il Papini autore di racconti fantastici è stato tra i primi in Italia ad operare un’originale e sincretistica fusione delle maggiori tendenze artistiche e filosofiche di metà e fine Ottocento sulle due sponde dell’Atlantico, prima di approdare ad una personale e visionaria cifra narrativa, basata sulle inquietudini del tragico quotidiano (dal titolo della prima raccolta di racconti del 1906) e su quella «escogitazione intellettuale» che proprio Contini gli rimproverava e invece tanta parte avrebbe avuto, in forme diverse, nella letteratura a venire. Per questo ed altri motivi, la riedizione completa e con puntuali apparati critici dei Racconti di Giovanni Papini (a cura di Raoul Bruni, con prefazione di Vanni Santoni e postfazione di Alessandro Raveggi, Clichy, 2022) è un evento editoriale degno della maggiore attenzione. La ricezione dell’opera papiniana, anche al netto di una pesante ipoteca ideologica che lo ha colpito ben più a lungo di altri, è stata per decenni soggetta ad un paradosso degno di uno dei suoi racconti. Se infatti da più di un quarantennio (all’incirca dagli anni Ottanta, quando la traduzione dell’Introduction à la literature fantastique di Todorov e i saggi di Calvino sdoganarono anche in Italia il dibattito critico sulla narrazione fantastica), Papini è stato “riscoperto” e canonizzato tra i grandi autori del fantastico novecentesco italiano attraverso un numero sempre crescente di articoli e monografie[2], i suoi racconti sono diventati invece via via introvabili, relegati ai negozi d’antiquariato o a qualche bancarella dell’usato sui generis, magari con supremo diletto di striminziti cenacoli di happy few. Per fortuna invece delle sad moltitudes (questo pare essere in definitiva ogni essere umano quando va da solo e non sacrifichi i tre quarti di sé stesso per appiattirsi su un gruppo di “pochi felici”; ma poi, felici di che?), con questa pregevole edizione, leggerissima nonostante le settecentoventi pagine, ritorna in libreria un autore fondamentale. Consapevole della propria posizione liminare, in bilico tra due secoli, con Papini, armato di una sorta di pragmatismo sentimentale o idealismo cerebralista, nonché da giovanile furia iconoclasta non scevra di massimalismo, inizia a consumarsi anche in Italia il definitivo divorzio tra la realtà intesa come codice assiologico di norme, valori e rappresentazioni condivise del mondo e dell’individuo e una realtà altra che affiora nelle crepe, nelle maglie più lasche, negli interstizi e la mina dall’interno. Non sorprende così che se si confronta la nozione papiniana di “tragico quotidiano” con quella appunto di interstizio adottata da uno dei maggiori narratori fantastici di ogni tempo, l’argentino Julio Cortázar, le somiglianze risultino evidenti. Nel corso di una conferenza del 1976 poi pubblicata con il titolo El estado actual de la narrativa en Hispanoamérica, Cortázar parla dell’interstizio come «la experiencia de que las cosas o los hechos o los seres cambian por un instante su signo, su etiqueta, su situación en el reino de la realidad racional». I primi racconti pubblicati da Cortázar risalgono al 1945 (La otra orilla), ma già nel 1906, in una delle tre prefazioni anteposte al papiniano Tragico quotidiano (quella Ai filosofi) e recuperate in questo nuovo volume di Racconti, si legge:
Io ho voluto far scaturire il fantastico dall’anima stessa degli uomini, ho immaginato di farli pensare e sentire in modo eccezionale dinanzi a fatti ordinari (…) li ho posti davanti ai fatti della loro vita ordinaria, quotidiana, comune, ed ho fatto scoprire a loro stessi, tutto quello che c’è in essa di misterioso, di grottesco, di terribile. (…). Vedere il mondo comune in modo non comune: ecco il vero sogno della fantasia. Pensare quello a cui nessuno pensa, stupirsi di ciò a cui nessuno bada – cercare ciò che a tutti sembra naturale -godere di ciò che a tutti sembra insignificante.
Tralasciando l’enfasi sul pronome di prima persona singolare e la scivolosa presa di posizione con cui il Nostro asserisce di non avere predecessori tra i «novellieri fantastici» ottocenteschi (e il Maupassant de Le Horla? E le Memorie di un pazzo di Gogol’?), siamo comunque nella fase pionieristica di quello che poi verrà variamente definito neofantastico o fantastico novecentesco. Papini vuole ad un tempo distruggere e rifondare, mettere il puntiglio di un’esasperata lucidità nel grigiore delle esperienze comuni o in vetusti trucchi letterari, che sono grigie soltanto per chi vi è ormai assuefatto. Così, nel Tragico quotidiano e nelle successive due raccolte (Il pilota cieco, 1907 e Parole e sangue, 1912) una prosa che alterna scatti e falcate, speculazione ed incisi lirici e si compiace di arrovellarsi sul piano concettuale, adoperando invece la lingua come il solido e agile manico della spada, dà vita a brevi, fulminanti episodi costruiti il più delle volte intorno a sorprendenti trovate narrative o su virate del pensiero iper-raziocinante quasi prive di intreccio ma ammantate di un’atmosfera delirante e asfittica. Su queste due direttrici (che non di rado si intersecano) troviamo infatti il miglior Papini, quello ad esempio dei racconti più celebri come Lo specchio che fugge (dove per ribaltare la vulgata del progresso si immagina che il mondo intero si fermi in un dato momento, lasciando l’umanità nel tremendo rimorso di ciò che sarebbe potuto essere e non può più avvenire), Il mendicante di anime (dove emerge tutto l’alienante terrore che può incutere la storia di un “uomo comune” senza alcun guizzo memorabile da narrare). Sempre rimanendo tra i pezzi maggiormente noti, difficile non menzionare l’ideale dittico dove vengono ribaltati i cliché letterari del doppio (in Due immagini in una vasca, in cui l’apparizione del protagonista da giovane non causa alcuno stupore, ma vira comunque verso la “tragedia quotidiana” nel senso sopra indicato) e della “vita inimitabile” dell’artista (in L’uomo di mia proprietà,Amico Dité si mette a disposizione del narratore perché gli faccia finalmente vivere esperienze straordinarie quali ha letto nei suoi libri, ma l’impresa si rivela irta di problematiche). Ma questa edizione, ed è uno dei suoi non pochi pregi, permette anche di riscoprire gemme finora passate troppo in sordina, come Storia completamente assurda (dove il narratore ritrova nell’opera di finzione di uno sconosciuto visitatore la propria vita ricostruita alla perfezione), Il giorno non restituito (una bellissima dama d’altri temi regala un anno di vita al misterioso padre di una ragazzina malata che glielo restituisce “a rate” a seconda del bisogno, ma il tempo passa e la gente crede sempre meno all’impossibile…), Chi mi ama muore (letteralmente) e L’orologio fermo alle sette (intriso di filosofia bergsoniana, un’ode malinconica ai “momenti di vita” partendo da una pendola rotta) per arrivare poi a vere e propri amalgami di struggimento cerebral-sentimentale (in senso positivo) con Elegia per ciò che non fu e Perché vuoi amarmi?
Anche le successive prove papiniane registrano momenti di singolare felicità espressiva. Con La vita di Nessuno (1912) si immagina il concepimento narrato dal punto di vista del feto (quasi un secolo prima, lo hanno notato in molti, del virtuosistico Nutshell di Ian McEwan), mentre in Buffonate (1914) troviamo il narratore alle prese con strampalati personaggi portatori di idee assurde volte spesso alla “liberazione dell’uomo” (La conquista delle nuvole, Il nemico del sonno, mentre arrivati al venerando anno 2022 La legge contro i poeti inizia credo ad essere presa in seria considerazione…), mentre tra i racconti più “narrativi” meritano una menzione Noemi e Milano (dove donna e città sono inestricabilmente legate) e Nein ladro (sin dove può spingersi un pittore per riprendersi i suoi vecchi quadri venduti quando non gli piacciono più?), mentre Il signor Ciù s’inscrive di diritto tra i racconti senza alcun tipo di sviluppo, immersi tuttavia in un clima di raggelante sospensione.
Un’eccessiva schematicità ideologica e proselitistica anima invece le ultime raccolte di Papini, che appaiono dopo un lungo silenzio dello scrittore di racconti in favore di altre voci, il saggista, il polemista e autore cristiano, il mai completamente allineato ma connivente sostenitore del regime fascista. Le prose de Le pazzie del poeta (1950) e La sesta parte del mondo (1954) riutilizzano con esiti più (La città della gioia, Armuria) e meno convincenti i generi dell’utopia/distopia e dell’apologo morale-moralistico che vede nel ritorno ad una qualche “purezza” la sola vera originalità artistica in un mondo dove tutto è esposto. A non convincere, più che i temi trattati sembra più una tangibile stanchezza dell’eterno giovane belligerante della letteratura italiana che indossa le vesti di vecchio saggio della montagna, che infine male gli si addicono. A riprova di questo, si legga in parallelo un racconto a tema “religioso” di Parole e sangue, Il vero cristiano, e si misuri la distanza di inventiva, di costruzione in poche pagine di un personaggio memorabile, lo scarto di ritmo che lo separa, ad esempio, da Il tempio sotterraneo o della monarchia (in Le pazzie del poeta).
Pur con i suoi continui alti e bassi, Giovanni Papini può essere considerato (come giustamente notava Stefano Lazzarin in un articolo del 2010 sulla “funzione Papini” nella letteratura italiana reperibile su Bollettino ‘900 con il titolo Una magia «troppo irrimediabilmente intelligente»: Papini, Bontempelli e il fantastico novecentesco) l’iniziatore di una delle due principali tendenze del fantastico italiano novecentesco. La più grande nevrosi di Papini, infatti, come emerge bene da un altro racconto celebre, L’ultima visita del gentiluomo malato (in Il tragico quotidiano), è quello di essere intrappolato in un labile sogno, e che tutto svanirà non appena questo sognatore-demiurgo inconsapevole aprirà gli occhi. Per questo occorre continuamente ricercare l’impossibile mischiando pragmatismo e mistica, innalzando l’intelligenza a supremo valore e adoperando le parole come armi e rifugio, ripetere all’infinito la parola che sveglia prima che si svegli il dormiente sognatore. A modo loro, il labirinto calviniano e le mille sottigliezze dei suoi racconti fantastici devono molto a Papini, mentre la poetica del “tragico quotidiano” verrà ripresa da Dino Buzzati. In entrambi i casi, certo, si tratta di una lezione epurata da asprezze, slanci superomistici e rivendicazioni iperboliche, con tutti i vantaggi e (perché no) qualche svantaggio che da qui può derivare. Sempre secondo Lazzarin, la seconda linea del fantastico novecentesco italiano è da far risalire a Bontempelli, che tuttavia si distanzierà presto dal fantastico per approdare a singolari incroci con fiabe e folclore e non è immune neppure lui da alcune ascendenze papiniane. Questa seconda linea verrà infatti completamente “presa in carico” da Tommaso Landolfi, che di contro all’autodidatta Papini si è imposto da subito come l’estremo conoscitore e giocatore della letteratura dei secoli passati, impiegata in maniera del tutto originale per dichiarare ormai impossibile non solo il genere fantastico, ma la letteratura tutta e finanche la sfiducia totale nel linguaggio articolato, nella parola, dolentemente maneggiata da artefice massimo. La grandezza di entrambi, Papini e Landolfi, si può ritrovare mettendo a confronto il racconto proemiale del Tragico quotidiano, L’uomo che non poté essere imperatore, con Night must fall, l’ultima prosa dell’esordio landolfiano del 1937, il Dialogo dei massimi sistemi: alla pertinace risoluzione dell’uomo che non riesce ad imporsi sugli altri con la forza e l’autorità e decide di tentare attraverso i mondi di parole dell’immaginazione, fa da contraltare una dichiarazione di impossibilità antipoetica, la consapevolezza di una via antiassiuolesca che si dispera di non poter ripetere immemore sempre lo stesso, melodioso suono, ma è costretta a sporcarsi del fango dell’arte, via via sempre più impraticabile.
Giovanni Papini è l’unico scrittore italiano che figuri nelle recensioni apparse a firma di Tommaso Landolfi e poi raccolte nel volume Gogol’ a Roma (Vallecchi, 1971, ora ristampato da Adelphi). Landolfi recensisce Il Diavolo, appunti per una futura diabologia, un testo del Papini teologo cristiano del 1954, e la distanza tra i due è tanto ampia che il conte di Pico non risparmia le stoccate. Tuttavia, conscio del valore letterario dello scrittore fiorentino (e quasi certamente memore dei vecchi racconti), ad un certo punto Landolfi afferma:
Nella nostra età che come forse nessuna ha orrore del merito (delle questioni), in cui si è propensi a risolvere tutto con uno strizzar d’occhi o un alzar di spalle, sempre noiatamente sottintendendo nozioni soluzioni e insolubilità, e vergognandosi di porre un problema nei suoi termini originari, nella nostra età che la sa tanto lunga, il Papini non teme di rifarsi ab ovo, sottoponendo ad esame i concetti più familiari e, diremo, più acquisiti (…). Infine, poca o molta che sia la sua forza, il Papini la conserva intera.
E di certo questa tensione li accomuna entrambi.
[1] C. Baudelaire, De l’essence du rire et géneralement du comique dans les arts plastiques, in C. Baudelaire, Œuvres, texte établi et annoté par Y. G. Le Dantec, Paris, Bibliothèque de la Pléyade, 1954; p. 728.
[2] Una rassegna di testi si può trovare in S. Lazzarin (a cura di), Il fantastico italiano. Bilancio critico e bibliografia commentata (dal 1980 ad oggi), Firenze, Le Monnier/Mondadori, 2016, alla voce che recensisce l’articolo di G. Tuccini, Il pragmatismo di Gian Falco: Giovanni Papini 1903-1907, «Chroniques Italiennes», série web, 7, 3, 2005, pp. 1-34.
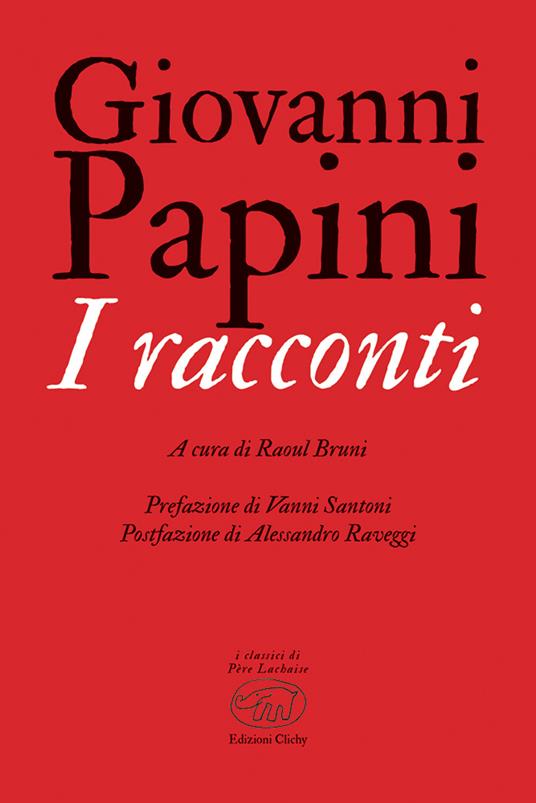
Giovanni Papini, I racconti, a cura di R. Bruni, Edizioni Clichy, Firenze 2022, 720 pp. 25,00€