Secondo una suggestione dello stesso Emmanuel Carrère, potremmo identificare nella sua scrittura l’alternanza di due tipi di sofferenza. «La sofferenza nevrotica», cioè «quella che ti procuri da solo, in una forma spaventosamente ripetitiva»; e «la normale sofferenza umana», «quella che ti riserva la vita sotto forme tanto diverse quanto imprevedibili» (Yoga, Adelphi 2021, p. 37).
Se nel suo penultimo libro Carrère si era soffermato principalmente sul racconto della propria «sofferenza nevrotica», con V13. Cronaca giudiziaria (Adelphi 2023) lo scrittore francese ritorna sulla linea della «sofferenza umana», la quale, a ben vedere, trova non poco spazio nella sua produzione narrativa precedente. Si pensi in particolare a Vite che non sono la mia (2009), incentrato sulla tragedia dello tsunami in Sri Lanka, vissuta in prima persona dall’autore, e sulla malattia di una persona a lui vicina.
Uscito in traduzione italiana lo scorso marzo e vincitore del premio Strega Europeo, l’ultimo libro di Carrère è un resoconto del processo per gli attentati terroristici di matrice jihadista che venerdì 13 novembre 2015 – da cui V13, il nome in codice del processo e il titolo del libro –, causarono la morte di centotrenta persone in alcuni bistrot di Parigi, all’interno del teatro Bataclan e presso lo Stade de France, siti presi di mira da un commando di terroristi dello Stato islamico.
Il processo a Salah Abdeslam, l’unico sopravvissuto tra gli attentatori, e ai suoi presunti complici presenta diversi elementi di interesse per lo scrittore parigino. Da un lato raccoglie e dà voce alla sofferenza individuale delle quasi milleottocento vittime chiamate a testimoniare – tra superstiti e familiari degli uccisi – e dall’altro ha una portata collettiva e storica, in quanto espressione di uno dei mali della contemporaneità, le mutazioni patologiche delle religioni.
La sofferenza testimoniata da centinaia di esseri umani ha per contraltare il mistero del male che l’ha generata, altro perno della scrittura di Carrère. Dal male assoluto e insondabile dell’assassino e impostore Romand, la cui vicenda è al centro dell’Avversario (2000) e sullo sfondo del Regno (2014), allo spettro della guerra che si intravvede in Limonov (2011). Uno spettro che – nella prospettiva ristretta del mondo occidentale – Vladimir Putin ha riportato sullo scenario europeo nel febbraio del 2022, e che fino a quel momento si era manifestato in Europa proprio nella forma del terrorismo islamico.
Non stupisce, quindi, che lo scrittore francese abbia voluto dedicare il suo ultimo progetto narrativo agli attentati di Parigi. D’altro canto, non sorprende nemmeno il modo in cui Carrère ha lavorato alla realizzazione di questo stesso progetto: trascorrendo i nove mesi del processo (da settembre 2021 a giugno 2022) nella maxiaula allestita per l’occasione tra parti civili, avvocati e giornalisti, con il compito di realizzare una cronaca a puntate, uscite con cadenza settimanale sull’«Obs» e riprese in Italia da «Robinson», l’inserto culturale della «Repubblica».
Anche se Carrère non si qualifica come giornalista, bensì come uno «scrittore […] legittimato soltanto dal suo desiderio» (p. 14), non è in realtà nuovo a questo modus operandi. Nel 1990 aveva raccontato sulle pagine del settimanale «L’Événement du jeudi» le vicende giudiziarie di alcuni casi di cronaca nera, mentre per «Le Nouvel Observateur» aveva seguito il processo al pluriomicida Jean-Claude Romand con due articoli che andranno a costituire parte integrante appunto dell’Avversario, libro che lo ha reso celebre e che ha inaugurato la sua particolare forma di scrittura tra ricerca documentaria e racconto autobiografico.
Tuttavia, il ritorno in aula a vent’anni di distanza non si configura come un vero e proprio ritorno alle origini. A differenza dell’Avversario, dove il racconto del processo occupa soltanto una parte del libro, V13 si presenta come il risultato della rielaborazione e dell’ampiamento degli articoli già usciti in rivista e perciò rimane fedele alla struttura della cronaca giudiziaria, ripercorrendo la scansione temporale delle udienze attraverso la suddivisione in tre parti (Vittime, Imputati, Corte) corrispondenti alle altrettante articolazioni del processo e collocate secondo l’ordine di deposizione. Si tratta di una struttura che può vantare celebri precedenti, come quello della Banalità del male (1963), resoconto del processo al gerarca nazista Adolf Eichmann che Hannah Arendt seguì come corrispondente per il «New York Times».
Come già nell’Avversario, anche in V13 stabilire la verità processuale conta meno dell’interesse per le figure coinvolte, vittime e imputati. Sulle vittime Carrère scrive pagine asciutte e commoventi. La forza dei loro racconti produce un’identificazione, favorita soprattutto all’affinità anagrafica con le madri e i padri che negli attentati hanno perso i figli. Ciò porta Carrère ad abbandonare l’“io” insistito dei suoi libri precedenti a favore di un “noi”, che accompagnerà il lettore lungo tutto lo snodarsi del racconto.
È sugli imputati, però, che convergono le maggiori criticità del processo, che vengono perciò problematizzate nella seconda parte del libro. Gli imputati sono il fulcro delle cronache giudiziarie: al centro della Banalità del male c’è Adolf Eichmann, con la sua personalità controversa; al centro dell’Avversario c’è Jean-Claude Romand che finge per diciotto anni di essere un medico e decide di sterminare la famiglia quando la sua menzogna rischia di essere rivelata.
Gli attentatori di Parigi, invece, ovvero «quelli che hanno ucciso», sono tutti morti e anche per questo è stato chiaro fin dal primo giorno che questo processo non sarebbe mai potuto essere «come a volte si dice, la Norimberga del terrorismo», in quanto «a Norimberga gli imputati erano alti dignitari nazisti, qui sono figure di secondo piano» (p. 14). I pochi «pesci grossi» nel box degli imputati, gli unici che potrebbero contribuire alla verità processuale, decidono per lo più di rimanere in silenzio. Osserva Carrère:
Bisogna ammetterlo: chi si appassiona ai processi – cronista giudiziario di professione o cronista occasionale come me – è affascinato dai colpevoli più che dalle vittime. Per le vittime si prova pietà, ma è dei colpevoli che si cerca di capire la personalità. Sono le loro vite che vengono passate al setaccio per scovare il punto di rottura, il momento misterioso in cui hanno deviato verso la menzogna o il crimine. Al V13 accade il contrario. Le cinque settimane di deposizioni delle parti civili ci hanno sconvolto, devastato, e ciò che riaffiora a quasi quattro mesi di distanza sono i loro volti messi a nudo dalla tragedia. E gli imputati, dopo tutto questo? Pensavamo che i loro interrogatori sarebbero stati avvincenti, in realtà non lo sono granché, perché non hanno niente da dire. (p. 146)
Durante tutta la seconda parte del libro Carrère cerca di tracciare un quadro degli imputati: chi sono davvero questi jihadisti? Una banda di ragazzini esaltati dai video delle esecuzioni che amavano guardare in loop nello scantinato di un bar a Molenbeek, il quartiere di Bruxelles a maggioranza musulmana, dove gran parte degli imputati sono cresciuti? O si tratta invece dell’infima parte di un’organizzazione terroristica ben radicata in Europa e pilotata dall’esterno?
E ancora: come dobbiamo leggere il loro silenzio o al contrario la loro accondiscendenza? È pietà per le vittime, come lascia intendere Sofien Ayari, toccato dalla deposizione di una madre che ha perso la figlia in uno dei bistrot presi di mira, rompendo il silenzio per raccontare il suo percorso di radicalizzazione? O è invece soltanto taqiyya, la maschera da musulmano integrato, prescritta dal fondamentalismo stesso, dietro la quale si cela quello «spirito del terrorismo»che secondo Jean Baudrillard è incompatibile con i “valori” dell’Occidente contemporaneo?
E infine la domanda che ricorre più spesso durante tutto il processo, che riguarda Salah Abdeslam, uno dei membri del «convoglio della morte» che avrebbe dovuto farsi saltare in aria come i suoi compagni, ma inspiegabilmente rinunciò all’ultimo momento. «Ci siamo chiesti fino alla nausea io come gli altri, cosa abbia provato Salah Abdeslam. La sua cintura esplosiva ha fatto cilecca? O lui ha avuto paura? O ha avuto un rigurgito di umanità?» (p. 229).
Quest’ultimo rappresenta uno degli elementi più interessanti del processo per Carrère, in quanto sembrerebbe dischiudere uno spiraglio di umanità, oltre a un elevato potenziale narrativo – un «punto cieco» direbbe lo spagnolo Javier Cercas – in cui il giornalista può cedere il passo al romanziere. Qualcosa di simile è presente anche nell’affaire Romand, laddove ciò che interessa a Carrère non è tanto la ricostruzione della verità giudiziaria, quanto sapere che cosa «passasse per la testa [di Romand] durante le giornate in cui gli altri lo credevano in ufficio, giornate che non trascorreva, come si era ipotizzato inizialmente, trafficando armi o segreti industriali, ma camminando nei boschi» (L’Avversario, Adelphi 2001, p. 31).
Ma se quella domanda poteva spingere Carrère a scrivere un libro, gli interrogativi in V13 rimangono in ultima istanza inevasi e mostrano inoltre tutta la loro irrilevanza, finendo per dissolversi in un«mistero misero: un vuoto abissale avvolto di menzogne su cui a posteriori, siamo un po’ sgomenti di esserci interrogati con tanta attenzione» (p. 229).
Se non è possibile sondare i cuori dei jihadisti, che cosa conta per “noi” in questo processo? Come superare questa distanza fra “noi” e “loro”? «È sciocco» – osserva Carrère in un altro passaggio – ritenere che “loro” non abbiano niente da dirci, «perché significa soprattutto che noi non abbiamo saputo ascoltare. Non abbiamo cercato di capire»(p. 146).
Ecco che ritorna la contrapposizione fra “noi” e “loro”, dove il primo termine non è più soltanto il “noi” delle vittime, le madri e i padri che hanno perso i figli con cui Carrère si identifica nella prima parte del libro, ma è il “noi” di un Occidente singolare, una società «vedova del collettivo e della Storia»:
Dobbiamo fare davvero un grande sforzo per interessarci come a singoli individui agli uomini nel box, che restano in silenzio perché non conoscono la nostra giustizia oppure recitano un catechismo che a noi appare demenziale. Questo non significa che non siano interessanti. Significa che ciò che è interessante in loro, ciò che in ogni caso lo è per me, non appartiene al piano individuale ma a quello della Storia […]. Quel che mi interessa è il lungo processo storico che ha prodotto questa mutazione patologica dell’Islam. (p. 147)
Una ricostruzione delle premesse storiche dello jihadismo è stata effettivamente offerta durante il processo dallo studioso Hugo Micheron, autore di indagini non troppo dissimili da quella condotta dal giornalista italiano Gabriele Del Grande e raccontata in Dawla (Mondadori 2018), frutto di una serie di interviste ad ex militanti dello Stato islamico.
Questa storia per noi occidentali comincia nell’agosto del 2014, quando i telegiornali trasmettono le immagini censurate della barbara esecuzione del giornalista statunitense James Foley, secondo un rituale – le inquadrature ad effetto, il coltellaccio, il boia a volto coperto dal passamontagna, la tuta arancione fosforescente del prigioniero – destinato a ripetersi ancora e ancora. Uno scenario che chi, come la sottoscritta, aveva sentito la notizia per la prima volta alla radio non sarebbe mai riuscito ad immaginare.
La dettagliata ricostruzione di Micheron, magistralmente riassunta da Carrère (di questa capacità nel fornire quadri storico-saggistici aveva già dato prova in Limonov), si spinge ben oltre la prima diffusione dei video di propaganda jihadista, indagando le cause e le origini del Califfato. Tuttavia, la sua è ancora una prospettiva parziale agli occhi di Salah Abdeslam, il quale nel corso del processo aveva sorpreso Carrère con una «frase stupefacente», più volte ripresa dallo scrittore francese:
«Tutto quel che dite su noi jihadisti, è come se leggeste l’ultima pagina di un libro. Il libro dovreste leggerlo dall’inizio». Non so da dove abbia preso un’immagine così forte, ma finora la sua è una delle due risposte a mio parere attendibili alla domanda che viene posta regolarmente: che cosa vi aspettate da questo processo? L’altra è stata pronunciata da un superstite del Bataclan, Pierre-Sylvain: «Mi aspetto che quel che ci è accaduto diventi un racconto collettivo». Scrivere questo racconto collettivo, leggere il libro dall’inizio: sono due ambizioni smisurate. Probabilmente irrealizzabili. Ma è per questo che siamo qui. (p. 108)
Delle due «ambizioni smisurate» – «scrivere questo racconto collettivo, leggere il libro dall’inizio» – soltanto la prima sembra effettivamente trovare una piena realizzazione. E questo perché Carrère trasforma – un po’ surrettiziamente – le aspettative che avrebbero dovuto essere del processo in quelle del proprio libro. Perciò la sensazione che rimane a libro finito è quella che ha accompagnato la chiusura del processo. La catarsi delle vittime (o almeno di alcune di loro), che hanno potuto avere ciò che ci si aspetta da un processo, cioè deporre la loro sofferenza, per riceverne in cambio giustizia, «trasformare l’emotività in diritto, anziché lasciare che vada persa» (p. 218).
Tuttavia, in un libro che in definitiva non ha altre pretese – e sia detto senza note di demerito – che quella di descrivere con lucidità e partecipazione emotiva, ma senza retorica, lo svolgimento di un processo epocale, questa sensazione di catarsi tende a lasciare in secondo piano i dubbi che invece Carrère solleva sulla legittimità della sentenza, improntata più all’esemplarità che al principio della proporzionalità della pena. Se gli autori materiali della strage fossero vivi, osserva Carrère, sarebbero toccate a loro le pene severe comminate agli imputati, come l’ergastolo ostativo inflitto ad Abdeslam.
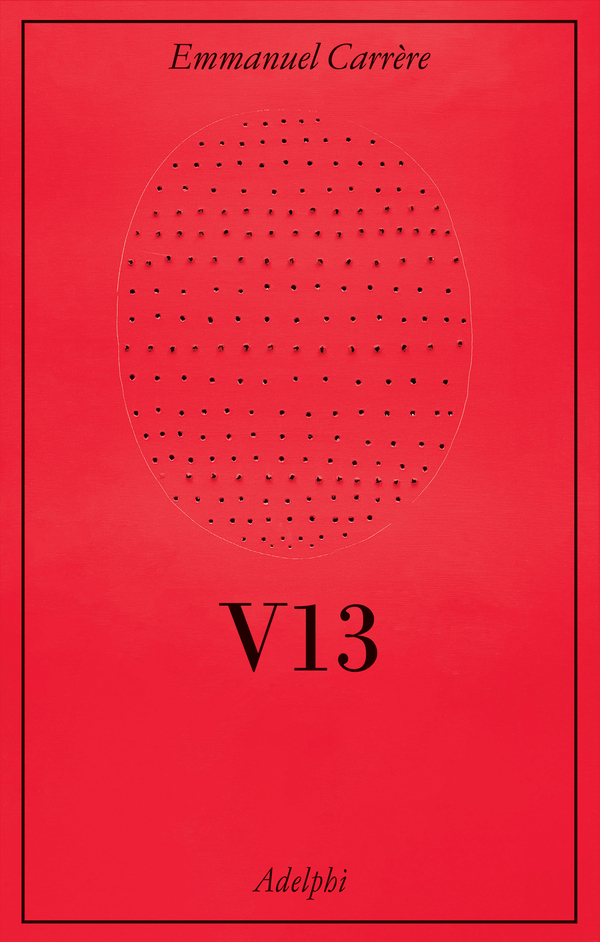
E. Carrère, V13, Adelphi 2023, €19.