Nel 1981 Fabrizia Ramondino faceva il suo esordio narrativo nel panorama delle lettere italiane di tardo secolo con Althénopis, romanzo di rara finezza e maturità stilistica, in grado di coniugare al massimo grado memorialistica e afflato narrativo, affresco storico e lievito espressivo, facendo germogliare sinuosamente sulla pagina una costellazione di immagini, volti, impressioni che si susseguono come fossero parte integrante di un carillon messo in moto dai ricordi. Il romanzo è tornato finalmente in libreria da qualche mese (con introduzione di Chiara Valerio) grazie alle cure di Fazi Editore, che ha preso la meritoria decisione di ripubblicare via via tutte le opere della scrittrice napoletana, ingiustamente finita nell’oblio dopo la scomparsa prematura nel 2008.
Althénopis è un romanzo intimo e al contempo corale, costruito mediante un accostamento alveolare di luoghi, situazioni, scene, che nel processo di rimemorazione portato avanti dall’io narrante, mai identificato lungo l’intero arco della narrazione, subiscono una graduale trasfigurazione immaginativa, capace di sfumare i dati puramente autobiografici. È come se Ramondino sentisse costantemente la necessità di incuneare tra la scrittura e la propria esperienza esistenziale un cuscinetto separativo propriamente romanzesco – presente in declinazioni differenti anche nelle opere successive, sebbene di fattura molto più sottile in libri in cui il sostrato autobiografico è preminente e meno filtrato, come in Taccuino tedesco (1987), Star di casa (1991) e In viaggio (1995) – in grado di allargare il margine di manovra della propria fantasia. Ed è proprio all’interno di questo disavanzo, contrassegnato dallo sconfinamento dei codici e dalla commistione dei generi, che l’operazione di Ramondino cessa di essere solamente ricostruzione di una biografia, per divenire, invece, atto di ricognizione epistemologica, percorso di auto-riconoscimento e auto-individuazione, graduale presa di coscienza del proprio essere nel mondo.
Rifuggendo dalla precisione accertata dei referenti temporali e geografici, la dimensione del ricordo che abita le prime due sezioni del romanzo sembra voler fare a meno del condizionamento deterministico della Storia, sia individuale sia collettiva, per espungerla, ripudiarla ai margini della materia narrata e installare all’opposto un contrordine, non più lineare, oggettivo e diacronico, ma mobile, personale, soggettivo, per cui le esperienze davvero vissute vengono rielaborate proustianamente nel tempo presente della scrittura e riacquisiscono senso e durata in virtù della loro specifica risemantizzazione narrativa. Del resto, come scriveva Simmel in Filosofia dell’avventura, «ciascun segmento del nostro agire e della nostra esperienza veicola un duplice significato. Per un verso ruota intorno al proprio asse e risulta esteso o profondo, piacevole o doloroso a seconda di come lo viviamo nella sua immediatezza; a un altro livello, però, ciascun episodio è anche un momento di un unico decorso biografico. […] Ciascun contenuto vitale, determinandosi all’incrocio di queste due valenze, si inscrive in configurazioni molteplici».[1]
Dunque, se la letteratura mette davvero in forma – cioè “con-figura” – il tempo umano, come sosteneva Ricœur in Tempo e racconto, Althénopis è innanzitutto un romanzo sul tempo che non è passato e non può passare, quello della prima fanciullezza, perché suoi scampoli e filamenti si sono depositati al fondo, hanno messo radici e vivono nel flusso rimescolatore della scrittura. La successione stringente delle micronarrazioni che caratterizza le prime due sezioni dell’opera funziona allora come immersione mitopoietica in un reticolo di luoghi dell’anima – la spiaggia, le ville, la “casarella” –, presentizzati (non bisogna dimenticare che l’autrice, quarantenne quando si accinge a stendere queste pagine, si rivolge ai suoi ricordi d’infanzia con «occhio di vecchia») sulla pagina mediante un ritmo contrappuntistico, basato su una cadenza del dettato raccolta e misurata. In questa prima parte del romanzo, tra i diversi ritratti di famiglia, la figura della madre emerge per assenza, come entità ombrosa, fantasmatica e perturbante che si rivela essere però la vera protagonista occulta del romanzo. Perennemente sfuggente, i suoi tratti caratteristici entrano in netto contrasto con quelli dell’altra figura chiave di queste pagine iniziali, quella della nonna. Se quest’ultima è infatti estrosa, generosa, eccessivamente prodiga, la madre appare, al contrario, parsimoniosa, rigida, tendente alla malinconia; le due allora non possono che entrare in conflitto e una (la madre) è destinata a espungere l’altra (la nonna), assecondando un radicale rovesciamento prospettico di ruolo e posizione, che viene percepito con dolore e triste sorpresa dalla giovane protagonista.
Quello di Ramondino è un realismo trasognato, visionario, mai allucinato o allucinogeno, tanto attento alla superficie mutevole delle cose quanto alla loro sibillina risonanza intima – costruito a partire dalla lezione compiutamente assorbita di Ortese, Ginzburg e Morante –, che nel suo disvelarsi permette all’autrice di scavare sotto l’epidermide dei ricordi per sviscerarne il nucleo radioso o oscuro e al contempo di ricostruire, proprio attraverso il lento germogliare di un tempo “perduto” e poi “ritrovato”, una geografia intima e identitaria. Nell’economia oppositiva del testo – interni vs. esterni, bambini vs. adulti, città vs. paese – è il periodo dell’infanzia ad emergere pavesianamente come realistico e al contempo mitologico, cartina di tornasole attraverso cui osservare il proprio destino in miniatura. La giovinezza assurge a edenica età dell’oro in cui le cose hanno un peso ma solo per gli altri, ogni nome ha un significato e ogni significato un nome e i fatui trastulli della maggiore età rimangono spesso incomprensibili. Al di là di questo orizzonte di condivisione, meraviglia e formazione, in cui la natura è specchio fedele di una umanità ancora primitiva e il regno vegetale è prolungamento rassicurante del corpo, la Storia agisce come mero sfondo, quasi impercettibile. Fa capolino nella seconda sezione del romanzo, intitolata Le case degli zii, che si apre con un’evidente cesura temporale. Siamo in pieno dopoguerra, il padre della protagonista è morto, ma nulla ci viene raccontato dell’accaduto, e la famiglia, in perenne sofferenza economica, è costretta a chiedere aiuto e sostentamento ai numerosi parenti che affollano il ramo genealogico. Obbligata a girovagare nelle case e negli appartamenti del parentado, l’io narrante si è ormai lasciata alle spalle il piccolo e protetto micromondo di Santa Maria del Mare, così come si è lasciata alle spalle il felice periodo dell’infanzia che lì si esprimeva pienamente.
Nella transizione verso la piena adolescenza il mondo circostante diviene urgente, tangibile, acuminato, imponendosi come presenza estranea con cui è ora necessario misurarsi. Ne consegue la presa di coscienza non solo di una fase conchiusa della propria esistenza, ma altresì dell’evento bellico e delle sue traumatiche conseguenze. La città di Napoli, sventrata dalle bombe e occupata dagli alleati americani, diviene simbolicamente una patria straniera che obbliga ad un esilio interiore. Nella girandola frenetica di case e appartamenti che si susseguono in quartieri differenti della metropoli, velata dall’ombra del lutto e delle difficoltà famigliari, l’identità della protagonista va formandosi per divergenze, scissioni e contrasti, secondo una traiettoria evolutiva che si nutre di disarmonie e differenziazioni con quell’universo adulto mosso primariamente da una meccanica coazione a ripetere, rappresentante l’hic et nunc su cui sedimentare per contrappasso il proprio “altrove”.
Nella terza sezione del romanzo[2] questo “altrove” tanto agognato quanto rifuggito torna ad essere – e non poteva essere altrimenti – la casa di famiglia. Nonostante l’astio e il rancore accumulatisi negli anni di separazione – ellitticamente obliati nel testo –, la protagonista, già gravata da un’acuta crisi psichica, quasi ai limiti della schizofrenia, rientra a casa da un generico Nord, dove si era trasferita per lavoro diversi anni prima, per accudire la Madre morente. L’avvicendamento naturale dei ruoli – la Figlia che si fa Madre e la Madre che torna ad essere Figlia – non può compiersi se non avviene prima una liberazione emozionale che attraversa necessariamente l’esplicitazione netta di tutte le colpe e di tutte le accuse rimaste negli anni sepolte e sotterrate, in una schizofrenica altalena di avvicinamento e repulsione. Tutto ciò comporta uno sconvolgimento tellurico dell’intera intelaiatura narrativa. La voce narrante sin lì omodiegetica, con uno scarto improvviso, diviene eterodiegetica spersonalizzata e onnisciente. Il linguaggio da arioso, fluente e colorito si fa claustrofobico, rattrappito, assumendo un andamento sussultorio, a tratti atrofico, sintomo evidente del disagio esistenziale che permea queste pagine. Il periodare si contrae in frasi brevi e contratte. La lingua sembra combattere una battaglia intima con le proprie intenzioni: vorrebbe comunicare, affermare, ma non ci riesce e allora esita, si autosabota. La memoria sembra annullarsi, il tempo cessa di scorrere, si fa assoluto e subisce un processo di spazializzazione, che si esprime attraverso i riferimenti topografici e le descrizioni d’interni – il salotto, il bagno, la camera da pranzo –, che formano una vera e propria mappa cronotopica: la pianta dell’appartamento in cui si svolge lo scioglimento finale della vicenda, dove la grammatica delle differenze esplode definitivamente. In questo tempo solenne e inscalfibile, che è il tempo della recita e del dramma, si genera un innalzamento connotativo dei personaggi, che adesso assurgono a pedine di una scacchiera che contrappone dualisticamente la vita e la morte, il viaggio e la stasi, l’indifferenza e la cura. L’occasione dell’estremo ricongiungimento filiale acquista in tal modo i connotati di una resa dei conti, non solo tra due corpi, uno ormai prossimo all’immobilità e destinato a spegnersi di lì a poco e l’altro invece florido, biologicamente perfetto e pronto a fiorire, ma anche e soprattutto tra due antitetiche visioni del mondo, della società, della famiglia.
La tensione allegorica che procede per esaurimento nello scioglimento conclusivo del romanzo passa attraverso l’atto epifanico del trapasso, equiparabile ad un annullamento, o almeno parziale sospensione, del trauma fondativo – non essere come la Madre, non essere come voleva la Madre – per mezzo di una nuova pienezza di senso, tutta volta e declinata al futuro – il futuro adesso immaginabile della Figlia –, portando a risoluzione un conflitto rimasto latente per anni. Althénopis allora, nonostante le discontinuità e le cesure narrative che ne minano l’intreccio, disvela proprio nel momento di massima spannung la soggiacente struttura «circolare» – per usare un’espressione di Domenico Scarpa[3] –, che trova nel finale, vale a dire nel momento aurorale di affermazione di una voce, di un corpo, di un’identità, la giustificazione del proprio inizio. Le sembianze cangianti della memoria e le disarmonie del mondo si risolvono nella ciclicità infinita del testo, capace di ricomporre, nel suo incessante moto ondoso, il sentimento spezzato della vita.
[1] G. Simmel, Filosofia dell’avventura, in Id., Stile moderno. Saggi di estetica sociale, a cura di B. Carnevali e A. Pinotti, Einaudi, Torino, 2020, pp. 246-61, p. 246.
[2] Nel 1966, dopo aver perso la madre l’anno precedente, Ramondino, suggestionata anche dalla recente lettura de La cognizione del dolore di Gadda, scrive le pagine che compongono questa sezione conclusiva, intitolata Bestelle dein Haus – espressione tratta dalla Cantata op. 106 di Bach. Il lavoro di composizione successivo, che verrà portato avanti a distanza di dieci anni, fornisce dunque l’inizio e la parte intermedia, ossia le prime due sezioni, di una storia in cui l’epilogo è stato già scritto
[3] D. Scarpa, La pietà e la storia. Althénopis di Fabrizia Ramondino, «Nuova Prosa. Quadrimestrale di narrativa», n. 36, 2003, pp. 165-186, p. 182.
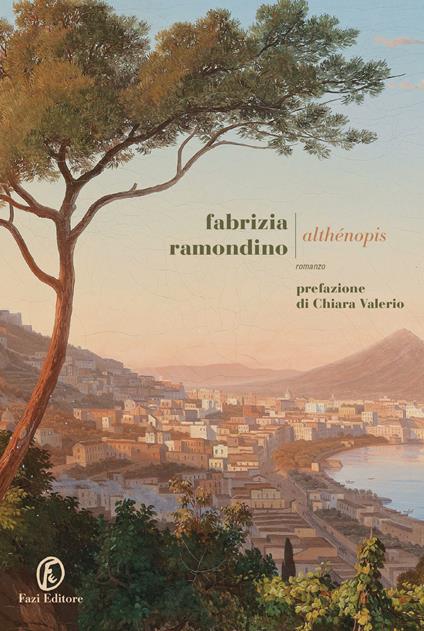
Fabrizia Ramondino, althénopis, pref. C. Valerio, Fazi, Roma 2023, 318pp. 18,50€