«L’India e gli indiani non interessano più a nessuno. Tutti hanno i loro problemi da affrontare nel proprio Paese», afferma uno dei figli della nuova India nel secondo romanzo di Pankaj Mishra (Guanda, 2023) centrando innegabilmente una verità sopita. Negli ultimi vent’anni l’attenzione nei confronti della letteratura indiana è senza dubbio sfumata. Fino ai primi anni 2000 si guardava con maggiore interesse alla letteratura del subcontinente, il mondo non era diventato ancora così piccolo e l’India possedeva l’aura fascinosa dell’alterità e dello spiritualismo. Alcuni grandi autori come Ghosh, Roy e Rushdie apparivano al grande pubblico internazionale come classici di una contemporaneità esotica ma addomesticata. Almeno in Italia eravamo probabilmente ancora vittime delle scritture pregiudiziose e dal sapore orientalistico di Moravia e Pasolini o anestetizzati dalle atmosfere sagge e rassicuranti di Terzani. Da quando il panorama editoriale è mutato definitivamente, travolgendo il mondo della letteratura e dell’editoria e trasformando queste ultime in “esperienza”, “immagine” e “emozione condivisa”, la complessità di una realtà troppo diversa dalla nostra è rimasta vittima di un’incapacità di sintesi e di una tendenza crescente alla semplificazione. Il vantaggio della prospettiva ad ampio spettro di Pankaj Mishra risiede probabilmente nella sua vocazione saggistica e nel suo impegno sociale, spesso invece interpretati come il reale limite della sua scrittura. Collaboratore di testate internazionali come il “New Yorker” o il “Guardian”, già celebre in patria per la sua precoce attenzione alle realtà periferiche del subcontinente, Mishra mette a disposizione dei suoi personaggi alcuni elementi fondamentali della propria esperienza umana e letteraria.
Ho letto molte recensioni di Figli della nuova India e, se mi fossi soffermata su quelle indicazioni sommarie, probabilmente non avrei mai letto il libro. In molti, infatti, si sono concentrati sulla patina di cinismo che ammanta il romanzo che, come recita il titolo, cercherebbe di disattendere le aspettative del lettore occidentale medio disvelando l’immagine di un Paese inaspettatamente secolarizzato. Questo è certamente uno degli aspetti importanti del romanzo, ma forse non rappresenta l’interesse centrale di Mishra. Ciò che invece ho trovato interessante è il ruolo della letteratura all’interno della dinamica romanzesca, sia come spirale narrativa che come fondamento e ispirazione delle ambizioni di una cultura in movimento. Non è un caso che al termine del romanzo l’autore elenchi alcuni testi letterari citati e che risultano fondamentali per la comprensione del testo: la maggior parte di questi appartengono alla letteratura occidentale a rappresentare, in qualche modo, la tensione verso una commistione di culture che parte proprio dalla letteratura per proiettarsi verso ovest. Tra questi, I dannati della terra di Frantz Fanon è una citazione o forse una raccomandazione teorica per il lettore. Il titolo originale, Run and Hide, assai più eloquente dell’italiano Figli della nuova India, sembra voler rimandare forse al più celebre tra i romanzi di formazione della letteratura indiana del ‘900, I figli della mezzanotte di Salman Rushdie. Ma in fondo il richiamo letterario è cogente, perché intorno alla letteratura ruota la costruzione dell’intero romanzo. Tanto che l’unico riferimento cronologico è dato dall’anno di pubblicazione de Il ragazzo giusto di Vikram Seth (maggio 1993), mentre la definizione degli ambienti e la fisionomia caratteriale dei personaggi emergono spesso attraverso i libri: «E a usurpare i volumi rilegati in pelle di Trollope, Thackeray e Dickens, esposti in librerie di noce con le ante di vetro e le sommità scolpite, c’erano variopinte edizioni economiche di Ogni cosa è illuminata, Norwegian Wood e Il punto critico allineate su scaffali a giorno in file sgargianti che spiccavano contro il pallore dell’intonaco» (p. 164).
Chiunque conosca bene l’India non può che riconoscere in queste pagine l’importanza della letteratura in un Paese che vende libri ai semafori e sui marciapiedi, possiede librerie maestose e pubblica romanzi in moltissime lingue locali: il Paese del Jaipur Literary Festival, che ogni anno attrae centinaia di scrittori internazionali e migliaia di visitatori. Non a caso, la maggior parte dei personaggi del romanzo cerca di scrivere o pubblicare un libro.
Virendra, Aseem e Arun, i tre protagonisti, sono giovani provenienti da villaggi ai margini delle grandi città che, grazie alle loro brillanti capacità riescono a entrare nel prestigioso Indian Institutes of Technology, trampolino di lancio e ascensore sociale delle nuove generazioni della cosiddetta nuova India. Ma l’ambizione dei protagonisti sono improntate su testi come L’ansa del fiume di Naipaul o Padri e figli di Turgenev. E proprio il personaggio di Bazarov appare fondamentale per una generazione vocata al laicismo e al nichilismo e che, in qualche modo, spiega e commenta l’India di Modi, l’aggressività delle classi subalterne e della borghesia, le ambizioni internazionali e, al tempo stesso, uno sciovinismo latente ma estremamente produttivo. Virendra, infatti, passerà dalle umiliazioni riservate alla casta degli intoccabili alle vette della speculazione finanziaria internazionale; la sua parabola negativa ricorda effettivamente quella del nichilista esemplare di Turgenev, offrendo l’immagine più cruda delle illusioni derivate dalla globalizzazione del capitalismo. Più sfaccettato il personaggio di Aseem, abile ammaliatore culturale, attivista ipocrita colto da una scrittura pungente nell’intimo delle sue contraddizioni. Si tratta forse del personaggio più credibile dell’intero romanzo, perfettamente calato nella nostra contemporaneità e che risulta convincente soprattutto dalla prospettiva dell’autore/narratore, Arun. Quest’ultimo, al contrario, non riesce a dimenticare le proprie origini e sperimenta l’impossibilità di compiere quel processo di integrazione con l’occidente da cui Mishra mette in guardia anche nella propria produzione saggistica e con cui il romanzo si mostra, quindi, coerente.
Aseem è rappresentato nella goffaggine di un sincretismo impossibile tra Oriente e Occidente, tra classe media e subalterna:
«All’inizio c’era il suo appartamento arredato e decorato rifornendosi da Anokhi e al negozio del museo dell’artigianato: un ambiente pieno di scaffali, pile di Esquire e Time in mezzo a vasi di terracotta Warli e statuette di ottone di Bastar con un poster di Muhammed Ali […] e paratha caldi che uscivano in continuazione dalla cucina che una cameriera a tempo pieno – segno evidente di successo borghese – sgobbava sui fornelli, mentre il padrone di casa apriva innumerevoli bottiglie di whisky Jameson nell’ampio soggiorno» (p. 75).
La stessa impossibilità viene colta suggestivamente dal narratore che per vivere traduce romanzi dall’hindi all’inglese, pur consapevole dell’inattuabilità reale e simbolica di questa operazione: «[…] il mio lavoro era inevitabilmente imperfetto, perché nessuna riflessione, per quanto avveduta, potrà mai valicare l’abisso emotivo che separa l’hindi dall’inglese, né tanto meno catturare ciò che esula dai confini del linguaggio. Ma mi consolavo pensando che ciò che facevo lasciava almeno trasparire un’alterità impossibile da cogliere appieno» (p. 143).
Tra Aseem e Arun si insinua il personaggio di Alia, modella, attivista, giornalista e aspirante scrittrice di origine musulmana che vive e incarna l’ossimoro inconciliabile del privilegio economico e del razzismo religioso. In un certo senso, tutti i personaggi faticano a trovare una collocazione, sono sempre fuori posto cosicché soltanto Arun, alla fine, riuscirà a sentirsi a casa rifugiandosi in un paesino dell’Himachal Pradesh, lontano tanto dalle tentazioni della nuova India e dalle contraddizioni della vecchia, quanto da un Occidente illusoriamente avanzato e democratico. Ad offrire una patria neutra è la rete, territorio della possibilità: «sembravi aver bisogno del nuovo mondo virtuale come gli emigranti del passato avevano bisogno di quello reale: una distesa sconfinata dove cominciare una nuova vita e realizzare le tue vere potenzialità» (p. 239), dice Arun ad Alia in una delle pagine più intense del romanzo.
Mishra contrappone all’India da cartolina, proposta da Modi al recente G20, la dura realtà dei villaggi. Le descrizioni di una natura maestosa e in grado di offrire rifugio e riparo dall’agone delle metropoli contrastano con la narrazione di rapporti umani che non riescono mai a svincolarsi dal non detto e dalla minaccia delle reciproche ambizioni. L’autore sembra rintracciare in una sorta di determinismo politico (e in questo il legame con I figli della mezzanotte è molto profondo) la radice del fallimento delle vite funamboliche dei tre protagonisti:
«Probabilmente tu non ricordi le promesse di sviluppo nazionale con cui siamo cresciuti io e Aseem. Saremmo usciti barcollando da campi e buie stamberghe, ci avevano prospettato, per essere condotti in una modernità splendida e luminosa, avremmo indossato giacche e cravatte, e avremmo lavorato e vissuto in case e uffici di vetro e cemento.
Era stato Modi a gonfiare questa bolla di aspirazioni collettive relativamente modeste: con le sue “smart cities” i “treni ad alta velocità” e le esplorazioni del lato nascosto della luna, profetizzava un miracolo che avrebbe eclissato qualsiasi fenomeno simile nel resto del mondo» (p. 303).
Forse per il lettore italiano risulteranno stranianti alcuni riferimenti estremamente specifici alla cultura e alla società indiane volti a un realismo spesso sarcastico. Inoltre, risulta pertinente e interessante la scelta della traduttrice di lasciare realisticamente nell’originale hindi (accanto alla traduzione italiana) la voce dei personaggi più umili, in contrapposizione a quella mescolanza tra hindi e inglese caratteristica della “nuova India”. L’uso sapiente dell’analessi (spesso intersecata sapientemente da prolessi) e l’espediente di un “tu” che acquisisce lentamente un volto appaiono ben calibrati. Ma è soprattutto il ritmo del romanzo a risultare convincente, mimetico con il contenuto narrativo e dosato nelle parti dedicate alla descrizione della natura e al ritiro spirituale del protagonista. Pankaj Mishra riesce a condensare letteratura e società in una struttura romanzesca avvincente, restituendoci l’immagine di una realtà globale, di caratteri e personaggi in cui possiamo riconoscere il nostro tempo.
Figli della nuova India rappresenta probabilmente un nuovo classico della contemporaneità che, per tradizione e talento individuale, si pone accanto a un romanzo come Il Dio delle piccole cose di Arundhati Roy e a un testo poco conosciuto in Italia come Karma Cola di Geeta Metha, offrendoci finalmente lo scenario pieno di sfaccettature di un Paese che non smette di affascinare ma che forse abbiamo smesso di voler conoscere.
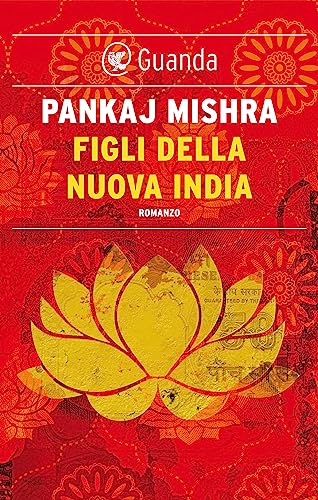
Pankaj Mishra, Figli della nuova India, Milano, Guanda, 2023, 19 €, 352 pp.