Strana tragedia, l’Alcesti di Euripide: non fosse per il fatto che ha un lieto fine.
Per leggere I morticani, romanzo di Francesco Maino da poco uscito per la collana Incursioni di Italosvevo, bisogna tenere quell’opera – V secolo avanti Cristo – in controluce.
È il testo stesso a dichiararlo, con una sfacciata e apparentemente gratuita piroetta nell’ultima pagina «Alcesti era una regina simpatica, le piacevano la pasta al ragù e i brillantini…»: sono le parole di una bambina che solo a quel punto appare, la figlia della voce narrante, che proprio in quel punto si addormenta. E poi è l’editore a venire in soccorso di noi lettori-zero (è così che la voce narrante ci chiama) nell’aletta interna del libro «Lettore-zero, qui saprai di Alfonso della Marca, avvocatino e scrittore d’occasione, il quale, giunto all’acme d’una crisi maniacale, allettato a psichiatria, senza reticenze o timori, snocciola al pubblico la sua personale Alcesti».
Insomma, tutti i segnali ci dicono che I morticani va letto come su un foglio trasparente – “lucido”, così lo si chiamava alle scuole medie – da porre sopra l’Alcesti.
Il tempo.
Sia nell’Alcesti che ne I morticani il tempo è quello assoluto, il tempo senza tempo del mito. Un tempo che – è inevitabile – porta con sé scorie, orme, ombre di un qualche tempo presente.
I luoghi.
La Tessaglia patria di re Admeto, per Euripide. Per Maino, il Veenetken, un ultra-veneto (ultra nel doppio senso di troppo e di oltre); più nello specifico, «una frazione stemmata del demo di Fava sul Dose, della quale non val la pena di rammentare nulla, se non la pieve, la pompa dell’Esso, le Poste e un panificio parificato la cui materia prima veniva maneggiata da migranti pangiabi». Il romanzo ci aggredisce così, nel suo incipit.
La trama, in breve, partendo dall’Alcesti.
Il dio Apollo si ritrova schiavo nel palazzo di Admeto, re di Fere: una punizione per aver ucciso i Ciclopi. Il sovrano lo tratta nel migliore dei modi, il dio gli è grato. Tanto grato che ottiene dalle tre implacabili Moire il rinvio della sua morte, calendarizzata in tempi molto brevi. C’è però una condizione: qualcuno dovrà sacrificarsi al posto suo. Amici, anziani genitori: tutti dicono di no. Il sì lo pronuncia Alcesti, l’amata consorte. Lei muore, il marito si salva. Lutto nel regno, lutto nel palazzo reale in cui, poco dopo, fa irruzione Eracle, in cerca di ospitalità e riposo tra una delle dodici fatiche e l’altra. Admeto è generoso con l’ospite. Che, di contro, non si tiene, mangia, sbraca, si ubriaca. Si rende conto molto tardi che tutto, attorno a lui, era (è) avvolto nel lutto. S’informa sulle tristi vicende. Si commuove. Si sente in colpa. Così decide di dirigersi dritto all’Ade, per riportare la defunta Alcesti tra i vivi, tra le braccia di quel sovrano generoso. Per farla breve, riesce nell’impresa. Lieto fine. Coro finale degli abitanti di Fere: «Molte sono le forme del divino, molte sono le risoluzioni inattese dei celesti; quello che si credeva non si è compiuto, un dio trovò la strada per l’impossibile. E questa vicenda si è suggellata così».
I morticani, la trama in breve.
Alfonso della Marca («l’avvocatino e scrittore d’occasione» citato nell’aletta) si ritrova internato in psichiatria. Si rivolge a un tu, che potremmo essere noi lettori-zero, invece è un dottore. Gli racconta la vicenda di Adamo D’Elia e della moglie Marcella Toffoletto. La coppia ha un factotum, Alessio Apolloni…e già si può intuire il resto; cioè: per Adamo è giunta l’ora della morte, l’hanno deciso le tre zitelle Raimonda «per comodità vengono, qui come in paese, chiamate le Moire, ma solo per comodità». Un infarto, o qualcosa del genere, in automobile, nel garage. Solito accordo: se si trova un sostituto, il D’Elia vivrà. L’anziano padre si sottrae («mi rimane poco, la vita è cortissima, ma non per questo dovrei giocarmela, stronzo d’un figlio mio che ho messo al mondo»). Dunque, anche qui, tocca alla moglie. Ma, questa volta, non è amore, non è il sacrificio supremo di darsi la morte per ridare la vita. Marcella Toffoletto accetta «per desiderio di liberazione dalla vita agra coniugale». C’è una sgangherata iniezione letale, l’entrata in scena d’un certo Bassetti D’Eraclio jr., deus ex machina di un’assai amara resurrezione della donna, eccetera eccetera.
Insomma – per farla breve e tranchant – la trama non conta, o conta ben poco.
Gli snodi narrativi, a Maino, li ha già apparecchiati Euripide venticinque secoli prima; l’autore, piuttosto, s’impegna a distanziarli il più possibile uno dall’altro, fino ad allentare lo spago che dovrebbe unirli e far sprofondare la tensione in un affastellarsi furioso di parentesi, divagazioni, digressioni, iper-descrizioni, di spinte centrifughe geniali ed esasperanti.
Quando si arriva in fondo al libro – e ci si arriva, ma è altro che ti ci porta – puoi dare un’occhiata retroattiva alla struttura, fissata in un indice finale: Preludio, Fuga, Divertimento, Coda.
E dov’è il centro? Lo svolgimento? Non so, il climax?
Che cosa resta di tutto quello che abbiamo creduto di leggere?
La lingua, il ritmo.
Lingua e ritmo non in senso decorativo, ma in senso sostanziale, totale, totalizzante. Il significante è il significato, crea il significato.
E il significante è una lingua iper-veneta che ha attraversato il dialetto (i dialetti), Zanzotto, Meneghello, Parise, qualche secolo più indietro Ruzante, le pompose iperboli de “Il milione” e quelle dell’imbriago al bancone del bar. Una lingua che, rispetto ai modelli assorbiti, è più moderna, più comica, più amara, più indigeribile. D’altronde gli è toccato d’attraversare anche il presente dell’iper-inglese del marketing, dei social, del business che ha penetrato le nebbie, che si è aggiunto ai detriti alluvionali da cui nasce la pianura padana, e ha imboccato le rotatorie, si è infilato nei capannoni protetti dagli antifurti, dalle telecamere, dai padroni e padroncini che – quasi sempre – dormono poco distanti e vengono svegliati dagli smartphone, come tutti noi.
E il ritmo (forse non è corretto dividere la lingua dal ritmo, ma vada), il ritmo di questo romanzo è un impasto – in alcuni passaggi estenuante in altri irresistibile, mai anestetizzante – di una gran varietà di metri. È prosa versificata, talvolta in maniera sfacciata, talvolta preziosa, talvolta sottile e sotterranea: rime, isocoli, allitterazioni, anafore, tutto l’armamentario. Anche la tragedia greca era poliritmica. È un romanzo che qualcuno, di molto abile, dovrebbe leggervi a voce alta.
Chiedersi il perché di tutto questo, il perché di questa forma così esposta, significa tendersi un tranello e cascarci.
La furia della lingua, del ritmo, della superficie non solo si oppone al vuoto, ma è il vuoto che sta sotto. Il troppo pieno è solo l’altra faccia del troppo vuoto. Due facce della stessa medaglia, o solo due modi di guardare in faccia la stessa realtà senza spiragli, senza feritoie. Il vero protagonista del romanzo è il Veenetken, e il suo tempo mitico, il suo presente assoluto che è la resa a un «futuro inumano di una popolazione spolpata, poiché gonfia di palanca ma priva di parola». I personaggi sono creature del suo ventre, che restano nel suo ventre.
Verso la fine, come nel modello euripideo, c’è un coro «composto non da uomini donne nutrie e ispettori, bensì da edifici infissi manifesti resti di boschi», materia inerte e indifferenziata che si mette «a comiziare all’unisono, in virtù di serramenti, tende e maniglie parlanti, a un popolo orfano». E, conclude il protagonista narratore, «quanto disse il coro si può riferire così, dottore, alla lettera: Sono molte le forme degli eventi. Quello che si credeva non si avvera. Un dio trova la quadra a cose di cui non si ha fede; è così che questa vicenda finisce».
Maino ha attraversato anche se stesso, ha attraversato e oltrepassato (non sto parlando di qualità) Cartongesso, il romanzo d’esordio con cui ha vinto il Premio Calvino nel 2013, e poi uscito per i Supercoralli di Einaudi, uno di quei rari testi che – credo – si salveranno nell’affollamento di questi decenni editoriali, si leggeranno ancora a lungo.
I morticani è una farsa che si scrolla pure di dosso le reminiscenze di tragedia: per questo offre ancora meno scampo dell’invettiva colta e complessa – ma che, al confronto, appare composta – di un romanzo come Cartongesso.
Un’esperta persona, una volta, mi ha fornito una base elementare ma utilissima per la degustazione di cognac, whisky e simili. Prima di bere, si deve tenere il naso nel bicchiere. Si deve inalare per più secondi. A più riprese. Almeno tre o quattro volte. Questo per abituarsi agli eccessi anestetizzanti dell’alcol, che è molto volatile. Funziona: dopo questa operazione, la complessità ampia e stratificata di aromi e sapori inizia a schiudersi anche in bocca ai neofiti.
Voglio dire che I morticani è un romanzo che si schiude soprattutto alla rilettura, alle riletture.
Ma non voglio cavarmela così, con la scorciatoia di una metafora facilina.
L’oscurità, il cesello, il virtuosismo parossistico: tutto questo fa parte della tradizione narrativa da secoli, forse da sempre. Il trobar clus dei poeti provenzali, le rime petrose di Dante, quelle irose e giocose di Burchiello, fino a quelle di un certo rap, incomprensibili o sconvenienti solo per chi non ne conosce il codice.
Il codice, appunto. Il codice di questo romanzo è generato e si genera già esausto, con la consapevolezza che non ci sia, non ci sia più, una comunità di interlocutori, di decrittatori, fosse pure comunità ipotetica, disperatamente ipotetica.
È davvero consapevolezza? Oppure è una resa precoce?
Non lo so.
Per fortuna, però, ci sono ancora editori che ci lasciano liberi di porci queste e altre domande.
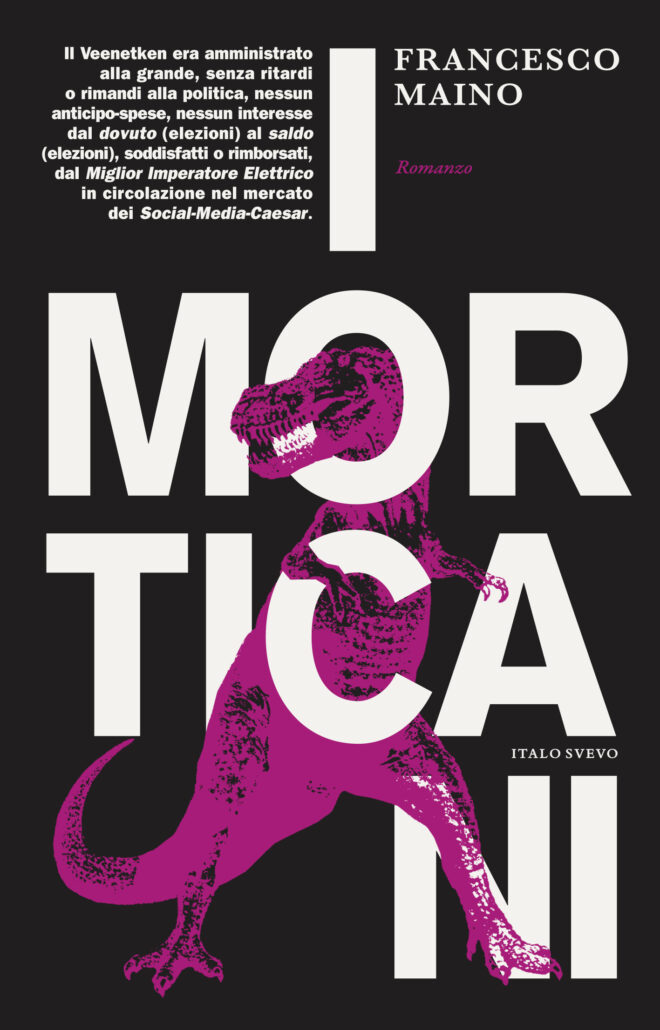
Francesco Maino, I morticani, Roma, Italo Svevo Edizioni, 2023, pp. 296, 20€.