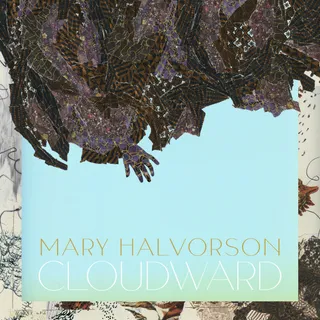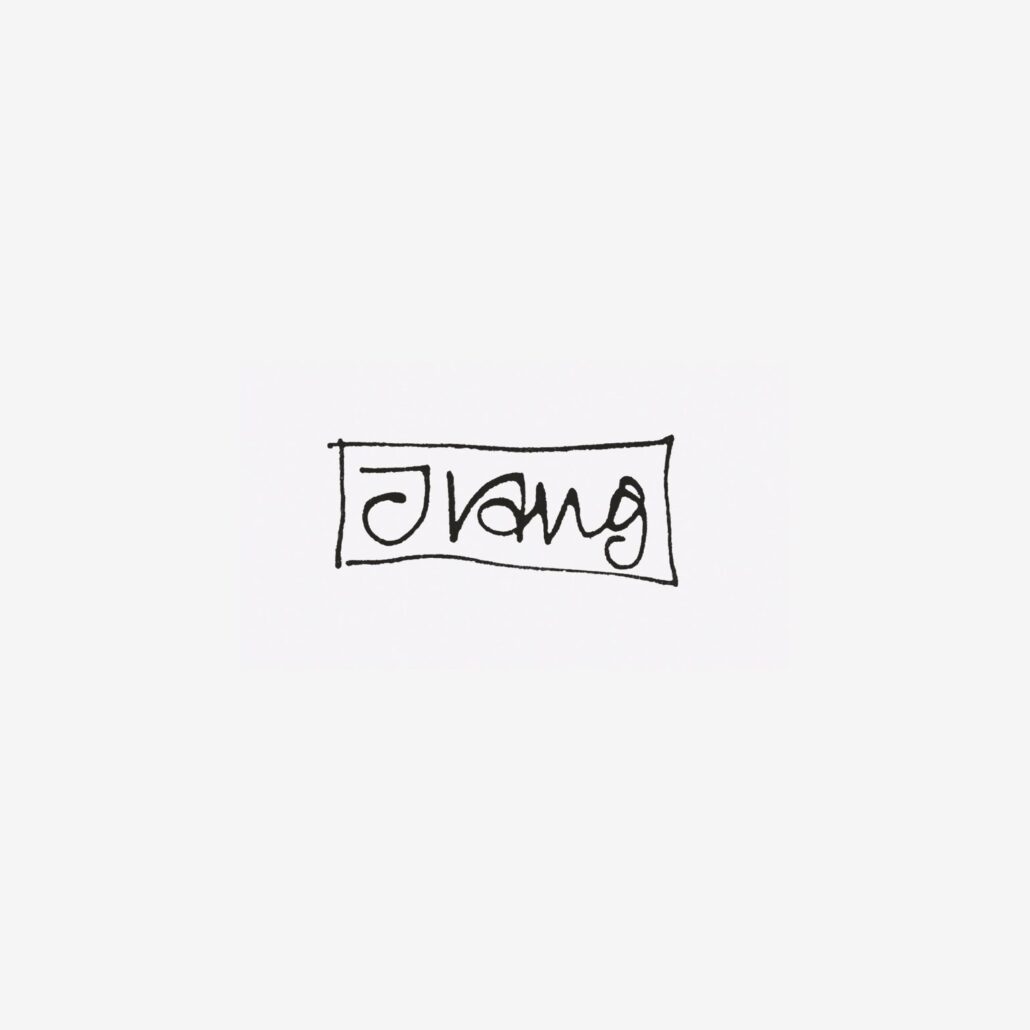Che stiate per imbarcarvi in un viaggio campale o che rimaniate a sorvegliare la città che gradualmente si svuota, ecco alcuni album che potranno farvi buona compagnia. Uscite recenti o recentissime, generi (molto) diversi, diverse provenienze. Buona scelta, buona estate – ma prima non perdete i consigli di prosa e di poesia!
[Il disegno in copertina è di Massimo Cotugno]
John Cale, Mercy (2023) e Poptical Illusion (2024) – Alessandro del Guado
Nel 1963, il primo coinvolgimento musicale del ventunenne John Cale negli Stati Uniti, dove era arrivato passando per il villaggio di minatori gallese della sua infanzia e il Goldsmith’s College di Londra, è stato come parte di una maratona performativa in cui John Cage, per 18 ore e 40 minuti, suonava Vexations di Satie. Sessant’anni più tardi, dopo una carriera segnata dalla rivoluzione musicale dei Velvet Underground, dalla produzione di artisti come Iggy and the Stooges, The Modern Lovers e Patti Smith, da collaborazioni con Terry Riley e Brian Eno, dall’arrangiamento definitivo di “Hallelujah” di Leonard Cohen e da una carriera solista di esplorazione diffidente e volutamente difficile, Cale pubblica il suo diciassettesimo album da solista: Mercy. A giugno di quest’anno, l’artista ormai ottantaduenne ne ha fatto seguire un altro: Poptical Illusion. Entrambi notevoli non solo in quanto esempi di come Cale abiti un mondo che lui stesso ha contribuito a creare, in cui “musicisti pop” registrano e si esibiscono fintanto che la mente e il corpo lo permettono, ma anche per la qualità della musica stessa, a tratti mozzafiato. La vostra estate – il vostro autunno, il vostro inverno! – hanno bisogno e meritano di essere accompagnati dalla presenza meditativa di Cale, gloriosamente punteggiata da canzoni come The Noise of You o I Know You’re Happy (in Mercy) e How We See the Light o All to the Good (in Poptical Illusion). Night Crawling, in Mercy, documenta un periodo degli anni Settanta speso a bere con David Bowie, che purtroppo non si è mai trasformato nella collaborazione che sembrava promettere. Come se Cale non avesse già contribuito abbastanza a quello che sarebbe diventato l’“Art Rock”, o all’evoluzione della musica pop in generale. Il fatto che continui a farlo è esaltante almeno tanto quanto la musica che continua a produrre.
Mabe Fratti, Sentir que no sabes (2024) – Simone Giorgio
Mabe Fratti è una violoncellista guatemalteca che vive a Città del Messico. Sentir que no sabes, uscito a giugno di quest’anno, è il suo quarto album solista negli ultimi cinque anni. La carriera di Fratti è in tumultuosa ascesa, soprattutto per quanto concerne la qualità dei suoi lavori; diverse riviste specializzate, su entrambe le sponde dell’Atlantico, hanno definito questo disco il suo migliore finora. Come detto, Fratti è una violoncellista, e sarebbe ragionevole aspettarsi che questo strumento sia il protagonista dell’album. Difatti occupa un ruolo centrale, ma vanno citati almeno altri due aspetti di queste composizioni: da un lato la sezione ritmica, in particolare la batteria, che accompagna i suoni secchi e spesso troncati dei colpi di violoncello; dall’altro, la voce di Fratti, che viene fuori in modo nitido e cristallino dai tessuti sonori che sono alla base dell’album. Fratti propone un’originale miscela di vari generi declinati appunto attraverso la coppia violoncello-voce: così, ad esempio, nella traccia d’apertura Kravitz troviamo una linea di basso e un’impostazione sonora generale che deve molto al grunge; ma si trovano anche influenze legate al post-rock, alla musica sperimentale, al jazz.
“My music is like when you see yourself in a really good mirror and you see all the pores in your skin”, ha dichiarato l’artista in un’intervista ad «Uncut», e mi sembra un’ottima dichiarazione di poetica per la sua produzione, che nella regolarità di textures che a un primo ascolto richiamano un brillante baroque pop inserisce sempre delle imperfezioni ricercate, che riportano il disco nell’alveo dell’avanguardia. Accade ad esempio nella traccia 6, Enfrente; altri episodi, su tutti Alarmas Olvidadas, virano invece con più urgenza sullo sperimentalismo. L’effetto generale è grandemente magnetico. Per chi volesse vederla live, si segnalano due concerti italiani il prossimo autunno: 12 ottobre a Bologna, al Robot Festival; 2 novembre a Torino, al Club To Club.
Jake Xerxes Fussell, When I’m Called (2024) – Sara Parmegiani
Dopo l’eccellente Good and Green Again del 2022, Jake Xerxes Fussell è tornato con una nuova collezione di canzoni sublimi e distintive. Per Fussell, fare musica sembra essere inseparabile dal trovare e dall’interpretare. Le canzoni di questo album sono state trovate in posti tanto diversi quanto l’arte performativa dello statunitense Maestro Gaxiola, la cui canzone Andy apre l’album, la versione musicale del testo Cuckoo! di Jane Taylor, resa dal compositore inglese Benjamin Britten, così come le canzoni e le ballate della tradizione folk di Inghilterra, Scozia, Irlanda e dei Monti Appalachi negli Stati Uniti. Qualunque sia l’origine, Fussell prende questi brani e, con il supporto del produttore e polistrumentista James Elkington, li interpreta con il suo stile attento, premuroso, caldo e rilassato. Sono, soprattutto, canzoni divertenti. Andy, in particolare, con la sua descrizione ironica della rivalità con Andy Warhol, e con la voce profonda e accogliente e l’esperienza alla chitarra di Fussell, delizia e incanta mentre stabilisce l’umore di base di questo album straordinario: serio, non grave; divertente, non ridicolo; intricato, non ampolloso.
Tommaso Paradiso, Tommaso Paradiso in concerto (2024) – Marcello Sessa
Con la decisione di licenziare per la prima volta un ponderoso e compendiario disco dal vivo, Tommaso Paradiso ha ottimamente assorbito le principali funzioni che la cosiddetta “svolta elettrica” di Bob Dylan aveva impresso, a metà degli anni Sessanta del Novecento, al cantautorato pop-rock; non le caratteristiche del personaggio e dei suoi album, bensì le istigazioni alla rottura di schemi dei cambi di stile dylaniani. L’autore romano denuncia e mette a nudo le difficoltà della propria palingenesi di musicista: scrivere canzoni di ambrata melodia e cantare struggimenti eterni non è facile. E – soprattutto – non sempre riesce; ma bisogna perpetuarlo ostinatamente. Sbandierare il proprio sgraziato Self Portrait è il prezzo da pagare per arrivare alla perfezione di Blood on the Tracks e poi proseguire, potendosi permettere infine di cantare qualsiasi brano decostruendolo sul palco. Se ai concerti di Dylan c’era il suo fan che aspettava la nuova versione di Tangled Up in Blue accompagnato dal suo amico lamentoso che “non riconosceva” Tangled Up in Blue, tra gli ascoltatori di Tommaso Paradiso in concerto ci saranno coloro che si ecciteranno per quanto la chitarra elettrica ingrossi in un magma sonoro tanto le hit più raffinate come Tra la strada e le stelle e Fine dell’estate quanto le novità come Sensazione stupenda e Blu ghiaccio travolgente, e quelli che, focalizzati sul discrimine oltranzista tra tentativi solisti e sepolti anni di gloria della band, non comprenderanno che la musica è in perenne movimento. Ai lamentosi passatisti, inanimati dal live, si risponderà: «La mia malinconia | è tutta colpa tua».
Mega Bog, End of Everything (2023) – Alex Ford
Cosa c’è in un nome? Mega Bog è lo pseudonimo da band/sala di registrazione della cantautrice Erin Birgy. Per chi l’ascoltasse nel Regno Unito o negli Stati Uniti, ad essere “mega” sarebbe una palude (anche se in alcune regioni, colloquialmente, il bog è piuttosto un cesso…). Per chi l’ascoltasse in Russia, invece, non sarebbe niente di meno che Dio. E questo mistero linguistico è estremamente appropriato per la musica di Birgy. Il suo sfilacciato collettivo di amici e collaboratori (che include James Krivchenia dei Big Thief) ha prodotto ancora una volta un album che scaltramente abita, per poi ribaltare, le presunte norme della musica pop. La traccia d’apertura è lì a confermare che il synth-pop è diventato il sottogenere di riferimento per l’hipster dell’Antropocene, con la voce di Birgy che si libra sopra propulsivi ritmi drum ‘n’ synth, capitati qui da qualche parte degli anni Ottanta. The Clown, in particolare, sarebbe potuta essere una grandissima hit pop in un universo costruito con regole diverse da quelle che hanno la meglio oggi (anche se forse solo Birgy potrebbe combinare l’accessibilità del pop a un testo che riflette in modo oscuro sul «decapitare i giovani», completato dall’effetto sonoro di una spada nell’atto di essere sguainata). L’ultima parte dell’album invece abbandona apertamente il pop: dopo la traccia dal titolo significativo di Don’t Doom Me, Now, l’atmosfera si incupisce nell’accettazione della forza delle ansie contemporanee, gli allegri sintetizzatori delle canzoni d’apertura vengono rimpiazzati da onde di ponderosa tristezza, sincronizzate con il registro affettivo di All and Everything, Anthropocene, Complete Book of Roses e, da ultimo, inequivocabilmente, End of Everything. Non un album adatto a ogni umore, bensì un album per i due umori che dominano questi tempi. Twentieth-Century Schizoid Man incontra Twenty-First-Century Schizoid Woman.
Saint Levant, Deira (2024) – Marco Ruggieri
Saint Levant è un sacco di cose insieme: ventitreenne palestinese, madre franco-algerina, padre serbo-palestinese, cresciuto a Gaza ma costretto a trasferirsi in Giordania nel 2007, poi in California per l’università. E ancora rapper, attivista su TikTok, fondatore di una start-up per connettere espatriati palestinesi con aziende in Palestina per aiutarle a crescere, ambassador per un profumo di Dior. E nella sua musica coesiste tutto. I suoni mediorientali, la trap e l’R&B, la guerra, le etichette di Los Angeles, la politica, il rap delle banlieues di Parigi, la nostalgia. Si àncora a idee e generi noti, riconoscibili. Ma li tiene assieme organicamente, e ne contesta i confini. Il suo primo album Deira, dopo tanti singoli ed EP, ha otto tracce che le senti e ti pare di stare a sentire uno a cui gridare in una lingua non bastava. Uno che i meccanismi del successo nel rap li conosce e ci si compromette pur di portare nel mainstream la voce dei palestinesi. «Odio sentirmi più a mio agio in inglese, ma tutti i giorni mi dico che è un privilegio perché posso parlare del modo in cui la mia gente vive, e lo faccio su questo beat perché so che lo vorrete ascoltare», dice all’inizio della prima traccia, On This Land. Se Deira ti piace, ascolta anche Sultan di Shabjdeed e Al Nather – più scuro, crudo, meno pop, più drill.
Sufjan Stevens, Seven Swans (20th Anniversary Edition) (2024) – Giulia Sarli
Ho ascoltato per la prima volta una canzone di Sufjan Stevens al cinema. Era estate, la città deserta, la sala vuota. Era il 2011 e il film si intitolava Restless, di Gus Van Sant. La canzone Rake. Sufjan Stevens è diventato uno dei miei cantautori preferiti e forse quello che ascolto di più da quell’anno. Da pochi giorni è uscita la versione Deluxe del suo album Seven Swans, che compie 20 anni, con l’aggiunta di due brani inediti, I Went Dancing With My Sister e Waste Of What Your Kids Won’t Have. È un album prevalentemente acustico, in cui alla chitarra si alterna il banjo. I testi sono ispirati da un forte senso religioso dell’esistenza e il timbro dolce della voce di Sufjan Stevens riesce a trasmetterlo in pieno. È un disco adatto ai tramonti di luglio sdraiati nei parchi con le cuffie alle orecchie. Ma ci sono musiche che salvano da ogni stagione.
Gastr del Sol, We Have Dozens of Titles (2024) – Matthew Houston
Dal 1993 al 1998 Gastr del Sol, progetto di David Grubbs e Jim O’Rourke e collaboratori, ha prodotto una serie di lavori geniali e pionieristici alla giunzione tra musique concrète, punk rock, minimalimo, improvvisazione libera, drone, computer music e chitarra primitivista americana. Questo album mette insieme tracce da studio inedite e esibizioni live da tutta la troppo breve carriera del duo, offrendo l’ennesima dimostrazione di quanto i due musicisti siano poco interessati alla distinzione tra generi e, soprattutto, di quanto profondamente e ecumenicamente amino il suono, il rumore, il silenzio e la miriade di forme e non-forme che questi possono prendere. Ursus Arctos Wonderfilis è una performance dal vivo esilarante sulla linea della musica zigzagante da duo di chitarre che ha caratterizzato i primi lavori di Gastr del Sol. The Bells of St. Mary’s, invece, è un pezzo stupendo che unisce sintetizzatori analogici e un piano dolceamaro, creando i più bei quattro minuti di musica sperimentali mai sentiti. L’ultima traccia, Onion Orange, lunga diciotto minuti, è una coda adeguata con la sua paziente e gentile miscela di improvvisazione alla chitarra di Grubbs e luccicante processo e sintesi digitale di O’Rourke. Come tutta la migliore musica d’avanguardia, questa collezione ricompensa il nostro ascolto aprendo a nuove possibilità e rifiutando di legarsi alle regole di realtà passate.
King Hannah, Big Swimmer (2024) – Michele Turazzi
Il secondo album del duo di Liverpool King Hannah (che già si era fatto notare con l’esordio I’m Not Sorry, I Was Just Being Me del 2022) è un lungo viaggio su una highway americana in compagnia di una ragazza che ti ha chiesto un passaggio da qualche parte ai piedi degli Appalachi, lei e il suo vecchio backpack. Mentre la tua auto – una rigorosa Buick decapottabile del ’77 – attraversa deserti infuocati, città brulicanti, foreste centenarie, questa ragazza si mette a raccontarti dei suoi viaggi, delle persone che ha conosciuto, di tutto il mondo che le ruota attorno, e di altri deserti e altre città e altre foreste. Così, anche se i riferimenti dei King Hannah sono manifesti (post e alt rock, Yo La Tengo e Sonic Youth, Lou Reed e Velvet Underground, tutto un immaginario che ruota attorno agli anni Novanta), il mix non è quasi mai derivativo, soprattutto grazie alla voce di Hannah Merrick, sempre credibile tra spoken word, folk e country, e accompagnata fedelmente dalla chitarra a volte ruvida e a volte minimalista di Craig Whittle. (I King Hannah, dopo essere stati costretti a cancellare il tour americano, saranno in Italia questa settimana, con quattro date, Bologna, Genova, Siena, e gran chiusura il 21 giugno ai Giardini della Triennale a Milano.)
Cinder Well, Cadence (2023) – Carolina Crespi
Cinder Well – progetto musicale di Amelia Baker, polistrumentista e cantautrice californiana – sarà in tour in Europa il prossimo novembre. Per ora non ci sono date italiane, ma mai dire mai. Le composizioni di Baker si distinguono per la profondità che si annida con riverenza negli arrangiamenti espansivi e dilatati; un doom quieto e paziente, che ricorda la tensione glaciale di artisti come Bell Witch. A questo si aggiunge l’interesse specifico di Baker per le ballate tradizionali irlandesi; la cantautrice ha infatti vissuto per qualche tempo nell’Irlanda Occidentale, imparando i pezzi tradizionali della comunità di Clare. Baker ha esordito sulla scena anarco-punk DIY di Santa Cruz, in California; il suo primo disco The Unconscious Echo risale al 2017. No Summer (2020), più cupo e spoglio, ha riscontrato ottime critiche. L’ultimo, Cadence (2023), abbraccia paesaggi sonori più ampi e di adagia nello spazio, con chitarra elettrica baritonale, batteria e arrangiamenti d’archi; un disco ispirato e magnetico capace di rimanere accessibile e relativamente pop, con ritornelli perfetti e memorabili, come quelli di Overgrown e Returning.
Kim Gordon, The Collective (2024) – Marco Longo
A distanza di cinque anni dall’ottimo No Home Record, disco che aveva inaugurato la sua carriera solista dopo più di trent’anni di militanza nei Sonic Youth, una delle band seminali dell’universo alternativo, Kim Gordon è tornata con l’altrettanto sorprendente The Collective. Ascoltando le basi industrial e le chitarre affilate dell’apripista Bye Bye, nella quale scandisce un elenco come fosse una mantra, non ci si aspetterebbe di trovarsi al cospetto di un’artista ormai settantenne. In The Candy House la base quasi da videogame del produttore Justin Raisin, suo collaboratore e sodale di questa nuova avventura discografica, ci trascina in territori trappisti che bilanciano l’atmosfera sinistra che pervade in tutto il disco. In effetti, è proprio la contemporaneità delle sonorità di queste undici canzoni che spiazza anche chi conosceva bene il suo amore per la musica urbana e d’avanguardia. The Collective è «un disco figlio dei nostri tempi», come dice l’autrice, che utilizza un linguaggio musicale giovane per graffiarci con la sua ansia.
Mary Halvorson, Cloudward (2024) – Greta Scutti
L’ultimo album di Mary Halvorson, il secondo con la sua attuale band, Amaryllis, è il più entusiasmante gruppo di composizioni che abbia scritto da Code Girl del 2018. Con una produzione gestita da John Dieterich dei Deerhoof, Mary e la sua band sembrano del tutto a proprio agio nel giocare e improvvisare attraverso una raccolta di canzoni che si sporgono con sicurezza sul ciglio del jazz. È notevole quanto bene chi suona si ascolti e risponda a vicenda attraverso tutto l’album. Un pezzo come The Tower può iniziare con la chitarra solista di Halvorson, processata attraverso un effetto ritardato molto riconoscibile, prima che entri la band: nel corso di diversi minuti, si passa da uno stile gentile e sognatore a uno irrequieto e erratico, senza mai perdere in focus. The Tower è, in miniatura, una dimostrazione perfetta di ciò che questo gruppo può fare. Detto questo, forse la sequenza tra Desiderata, con l’assolo assolutamente pazzo di Halvorson, e Incardine (con Laurie Anderson al violino) è per me la più esaltante dell’album, perché lascia intravedere ciò che questa band potrebbe avere in serbo per il futuro: composizioni squisite, attenti ascolto e risposta da parte di chi suona, esplorazioni emozionanti al confine tra musica pianificata e non-pianificata.
Bòsc, Bòsc (2024) – Bernardo Tournier
Parte della musica più interessante degli ultimi anni proviene dalla regione storica dell’Occitania, da artisti che lavorano con e attraverso le tradizioni musicali occitane. Bòsc è un esempio ideale di questa musica. Gruppo immerso nelle tradizioni locali del fare musica che sono sopravvissute alle ondate di omogeneizzazione culturale del diciannovesimo e del ventesimo secolo. Allo stesso tempo, Bòsc incorpora nella musica tradizionale una sensibilità di composizione espansiva e inventiva, che prende in prestito elementi sia dalla musica pop che dall’avanguardia. Una musica come questa ci insegna che il passato e il futuro possono in effetti coesistere e che questo, proprio questo, è il significato del prestare attenzione al presente: tenere vive le tradizioni di bellezza che ci hanno preceduto, mentre si ricevono con gioia le sorprese che emergono di fronte a noi, e in qualche modo congiungerle.
Arooj Aftab, Night Reign (2024) – Eloisa Franchi
Nelle notti d’estate tutto può accadere – un regno a parte dove si incontrano spiriti, memorie, amori perduti e intossicanti. Della dolcezza, del mistero e della bellezza di queste notti è tessuto Night Reign, il nuovo disco di Arooj Aftab dopo la collaborazione con Vijay Iyer e Shahzad Ismaily per Love in Exile. Prendere le tradizioni, distruggerle per farle rivivere, che siano i suoni delle poesie in urdu e del ghazals o il coraggio di affrontare in maniera gigantesca un classico dei classici come Autumn Leaves. Collaborazioni di eccezione, che siano il piano del già citato Iyer, le chitarre di Kaki King o i versi di Moor Mother, ma con sempre al centro la voce ammaliante di Aftab, a volte usignolo del mattino a volte sogno perturbante – come tutti i sogni estivi.
Ivan Graziani, Per gli amici (2024) – Claudia Dellacasa
Se anche per voi le vacanze estive negli anni Novanta significavano lunghi viaggi in macchina verso il mare, e nell’autoradio cassette di cantautori italiani, l’album in questione è qui a ricordarvi che di tempo ne è passato, ma non è cambiata la qualità di quegli ascolti. A suo modo defilato eppure potentissimo in vita, Ivan Graziani lo è ancor di più a ventiquattro anni dalla sua morte. Tanto da riuscire persino a regalare un disco di inediti, rimasti a lungo in un cassetto e ora prodotti dal figlio Filippo. Otto tracce dai toni delicati e dalle melodie dolci, sostenute dalle inconfondibili voce e chitarra di un artista che ancora oggi, di un’Italia (o Italianina) di cui non ha visto le ultime evoluzioni, restituisce un ritratto sognatore, a tratti surreale, e proprio per questo estremamente contemporaneo (si ascolti in particolare Tv). Il brano che dà il nome alla raccolta è una scanzonata meta-riflessione sull’attività di cantautore («a me una patente da buffone e una corda buona quando mi si rompe il mi»), arricchita da riferimenti incrociati – melodici e testuali – a canzoni diverse della produzione dello stesso Ivan Graziani. Non a caso posta in fondo all’album, Per gli amici sembra salutarci e, da questo strano avamposto nel ventunesimo secolo, invitarci a tornare ai pezzi che hanno reso unica la carriera di Ivan, e con questa la scena cantautoriale italiana tutta.