All’ombra dei Lumi: genealogia della mostra d’arte
Nonostante prenda avvio con una pungente critica nei confronti dell’Illuminismo e delle sue profezie sul tramonto della religiosità, il recente libro di Giuliano Zanchi, Lo spirituale dell’arte, fa sua – paradossalmente – la cifra stilistica dei philosophes: è un libro dissacrante. A patto che per “dissacrazione” non si intenda, superficialmente, la volgare attitudine denigratoria verso le credenze religiose, bensì quell’atteggiamento critico capace di rivelare la genealogia delle nostre spontanee concezioni spirituali ed estetiche, spogliandole della loro ovvietà, privandole di quell’autorevolezza invisibile che permette al “senso comune” di sopravvivere indisturbato.
Questo sguardo dissacrante si rivolge, nel saggio di Zanchi, a quell’insieme di pratiche che chiamiamo “arte” e a quei rituali che attorno all’arte gravitano: le mostre, con i loro titoli altisonanti; le visite guidate, a cui si sottopongono, con penitenziale abnegazione, i visitatori dei musei; gli articoli dei critici e il lavoro dei curatori di esposizioni, graniticamente convinti della scientifica neutralità del loro sguardo; l’ostensione dell’opera d’arte, specialmente del “grande capolavoro del passato”, trattato come un “corpo santo” o una reliquia. Questi riti vengono interpretati da Zanchi con una sensibilità quasi etnografica, nel tentativo di decifrare la funzione sociale e antropologica di quegli spazi e di quelle retoriche entro cui si consuma oggi la fruizione delle opere d’arte. Questa, dunque, l’angolatura da cui Zanchi osserva l’odierna cultura artistica, aggirandosi per i musei e le mostre con un’irriverenza che ricorda quella del critico musicale Reger, protagonista dello straordinario romanzo Antichi Maestri di Thomas Bernhard. Con una scrittura colta e ironica, Zanchi ci invita a guardare l’arte e la sua musealizzazione come un fenomeno complesso, una sorta di specchio in cui si riflettono le contraddizioni della nostra epoca rispetto alla dimensione della spiritualità e delle grandi domande esistenziali. Positivisticamente concepito come luogo di diffusione della cultura e del sapere, il museo somiglia sempre più al «bazar archeologico» di Gianni Celati, un luogo dove gli oggetti, privi del loro contesto di significazione originario, finiscono per diventare in modo involontario degli “oggetti surrealisti”, degli esperimenti di delocalizzazione, o con le parole di Zanchi «relitti deposti sulla spiaggia dopo un naufragio». Alle considerazioni di Bauman o di Valéry, che parlano del museo come di un cimitero, Zanchi aggiunge sarcasticamente che i musei, se non proprio cimiteri, sono quantomeno diventati degli orfanotrofi. Si riferisce specialmente all’arte sacra, orfana della sua funzione di icona religiosa e trasformata, all’interno del contenitore museale, in puro oggetto di ammirazione estetica. Sembra che i capolavori del passato, tolti dalle chiese e privati della loro “aura”, possano sopravvivere solo nella forma desacralizzata del puro oggetto di contemplazione; o che viceversa siano le chiese a doversi trasformare in musei, perdendo la loro funzione di luoghi di celebrazione e preghiera. Arte e religione, un tempo perfettamente integrate, si sono ormai inesorabilmente separate?
Si tratta di un divorzio solo apparente. In realtà, e questa è una delle tesi centrali del testo, l’elemento sacrale agisce ancora in modo mascherato, abitando segretamente i luoghi dell’arte, nuove cattedrali: l’esposizione d’arte assume «i caratteri dell’ostensione sacramentale, laicizzando nei termini della contemplazione artistica il vecchio atteggiamento della venerazione religiosa». Scrutando a fondo nei comportamenti simbolici che circondano il consumo dell’arte, ci si rende conto che il museo, la mostra e il suo allestimento, il commento critico, le visite guidate, non assolvono soltanto a una funzione didattica, scientifica, espositiva, ma rispondono anche a nuovi bisogni di ritualità, di mitopoiesi, di spiritualità, anche se affrancati dall’ancoraggio a uno specifico credo religioso.
Quel che resta del sacro nell’età postsecolare
L’indagine dell’autore si spinge dunque ben oltre il limitato perimetro del mondo dell’arte, per sondarne i legami profondi con le dimensioni della spiritualità e del sacro. Il tema che il saggio sviluppa, con numerose variazioni, è proprio quello del rapporto fra la dimensione spirituale e quella estetica, sullo sfondo di quel processo storico che prende il nome di “secolarizzazione” o – volendo usare la celebre espressione di Max Weber – di «disincantamento del mondo», una lunga transizione storica in cui, a partire dalla tarda età moderna, si assiste al progressivo imporsi della scienza galileiana e dell’esprit de géométrie in ogni ambito della cultura e al correlativo arretramento della scienza aristotelica (e dei suoi sviluppi scolastici), del pensiero magico-alchemico rinascimentale, della teologia cristiana. Un processo che travolge, trasformandoli alla radice, sia il campo dell’estetica che quello della religione. Con l’avvento dell’era secolare e il declino delle tradizioni religiose dominanti, la civiltà occidentale vive una profonda crisi del proprio rapporto con la trascendenza, che getta anche l’arte in una straniante crisi di senso. Una crisi che, con l’avvento della post-modernità, sembra farsi più profonda, con l’indebolimento delle grandi sintesi politiche e ideologiche novecentesche, che nel “secolo breve” avevano fornito alla pratica artistica un potente orizzonte di senso in cui dispiegarsi. Quindi, con la crisi delle “grandi narrazioni”, dobbiamo aspettarci la scomparsa del sacro e l’evaporazione dell’aura che da sempre circonda le opere d’arte? Non è così. Il sacro non muore ma sopravvive in una sorta di scenario post-apocalittico, come un solitario eroe cyberpunk, evitando la luce del sole e operando silenziosamente, nell’ombra. Nonostante il processo di secolarizzazione, l’età contemporanea resta caratterizzata da una diffusa ricerca di senso e di spiritualità. L’arte, nell’epoca postsecolare, risponde a questa esigenza in due forme: la canonizzazione dei suoi luoghi ufficiali e «l’estetizzazione generalizzata di ciò che prima stava fuori dal bello» (come scrive Morin), la sua disseminazione in ogni pratica sociale. La consacrazione del museo e dei “grandi capolavori d’arte” da un lato, l’estetizzazione del quotidiano dall’altro.
«La mia personale diagnosi» dice Zanchi «è che i grandi eventi espositivi abbiano ereditato la funzione sociale e antropologica della vecchia ostensione sacra e dell’antico pellegrinaggio religioso, laicizzato nel culto dell’arte e destinato a ospitare una forma secolare di devozione, che si esprime per molti nell’assolvere il precetto sociale di un collettivo dovere di contemplare».
Il ritorno dell’aura
Tuttavia, di fronte a questo panorama, Zanchi non conclude moralisticamente, descrivendo il pubblico come una massa acefala e passiva, riducendo le liturgie dell’arte a imitazione grottesca delle antiche funzioni sacrali della religione. Nemmeno si abbandona a stomachevoli elegie sulla decadenza morale dell’arte e dello spirito umano. Egli suggerisce, piuttosto, che queste nuove forme di “devozione artistica” possano essere viste come pratiche creative e dinamiche, attraverso le quali il pubblico interagisce con il mondo istituzionale dell’arte, cogliendo nelle immagini la capacità di generare bellezza, al di là della loro funzione storico-documentale, e di animarsi, come direbbe il Poeta, “per incantamento”, offrendo rifugio a quelle dimensioni del senso che faticano a trovare spazio di rappresentazione nell’età del disincanto:
«sopravvivono momenti della cultura e prassi delle arti in cui la natura ancipite dell’iconico, materiale e simultaneamente altro, cioè trascendente, si conferma come esperienza fondamentale del vedere nel suo tratto tipicamente umano, e in cui la differenza iconica dell’immagine forte mantiene il suo diritto di cittadinanza nella civiltà del metaverso».
L’arte diventa un mezzo per accedere a esperienze di profondità e mistero, offrendo una via di accesso al sacro che va oltre le tradizionali pratiche religiose. Come direbbe Michel de Certeau, l’arte, nel suo incessante gioco di produzione e riproduzione del senso, si trasforma in un campo di “invenzione del quotidiano”, dove il sacro si manifesta in modi nuovi e spesso inattesi. Uno degli aspetti più interessanti del testo è dunque la scoperta, sulle orme delle riflessioni di De Certeau ne L’invenzione del quotidiano, della chimica imprevedibile che si genera fra i luoghi di culto dell’arte e la loro ricezione “creativa” da parte del pubblico, fra la pervasività del valore estetico e la sua reinvenzione quotidiana da parte dei “consumatori”. In questa prospettiva, sia la musealizzazione dell’arte che la sua diffusione in ogni strato dell’esperienza, assumono una valenza progressiva ed emancipativa. Il “pubblico” non è una massa passiva, addestrata da processi di inculturazione unilaterali ai nuovi riti dell’arte, bensì il soggetto di una “ricezione creativa”, capace di interpretare e rinegoziare continuamente i significanti artistici. Questo punto meriterebbe ulteriori approfondimenti, prendendo in considerazione un altro aspetto fondamentale dell’estetica contemporanea, cioè la disomogenea stratificazione sociale del gusto. Come spiega magistralmente il sociologo francese Pierre Bourdieu in un importante studio intitolato La distinzione, lo sguardo verso l’arte non è un prodotto naturale, ma il risultato di un articolato processo di costruzione identitaria che si verifica all’interno del proprio gruppo sociale, o meglio dei propri gruppi sociali di appartenenza, un processo mediato soprattutto dai dispositivi di educazione scolastica e familiare. Su quest’idea poggiano anche le ricerche di Nathalie Heinich, allieva “rinnegata” di Bourdieu, che sottolineano l’intrinseco elitismo dell’arte contemporanea e del discorso dei critici. Il pubblico, spiega Heinich, spesso non possiede il codice per decifrare il linguaggio criptico dell’arte contemporanea, che pure di questa oscurità fa il proprio tratto distintivo (come spiega bene Giacomo Raccis nella sua recensione di Nathalie Heinich, Il paradigma dell’arte contemporanea. Strutture di una rivoluzione artistica). L’arte si trova dunque costretta, come nota Zanchi, a “produrre i suoi catechismi” (manuali, libri di divulgazione, documentari…), nello “slancio etico” di avvicinare il pubblico. Per comprendere a fondo le dinamiche dell’universo estetico odierno, è sempre più opportuno avvicinare il fenomeno del gusto a partire da questa consapevolezza, per svelare la logica interna ai diversi canoni estetici che si fronteggiano nello spazio pubblico: prendendo congedo, come giustamente suggerisce De Certeau, da categorie pseudo-sociologiche come “massificazione”, “consumismo”, “omologazione del gusto”. Se il “popolo” del boom economico doveva accontentarsi, contro il logorio della vita moderna, di un noto amaro al carciofo, contro il logorio della vita postmoderna i consumatori trovano invece un nuovo spazio di sublimazione nell’arte, uno spazio che produce uno strappo nel nostro modo consueto di vedere la realtà, una sospensione del nostro senso comune, «il rifugio nel quale possono ritrovarsi a casa gli dèi».
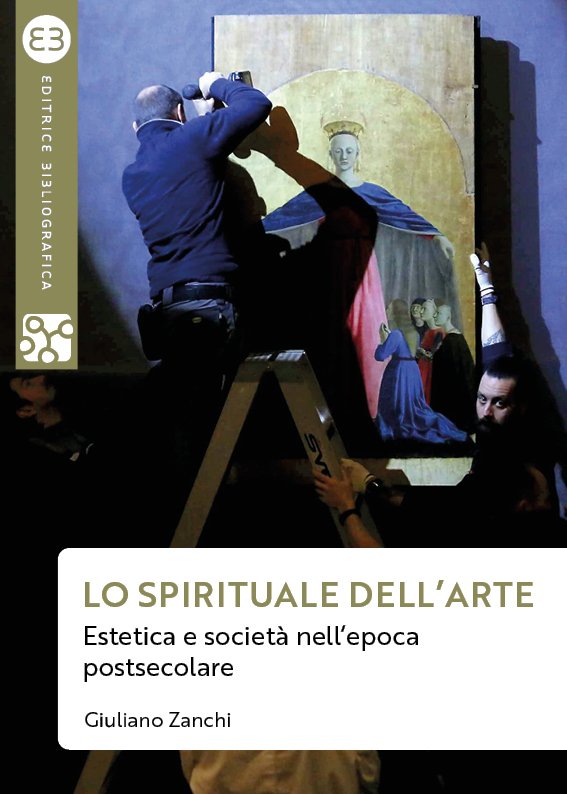
Giuliano Zanchi, Lo spirituale dell’arte. Estetica e società nell’epoca postsecolare, Editrice Bibliografica, Milano, 2023