Si legge Vajont e si pensa disastro, tragedia, crollo. Se si è grandi abbastanza da ricordare il monologo di Marco Paolini del 1997, andato in onda su una Rai lontana anni luce da quella di oggi, forse si popolano queste parole – disastro, tragedia, crollo – di storie e destini individuali e collettivi. Se di queste storie si ha ormai solo un vago ricordo, e se addirittura ci si confonde pensando che il 9 ottobre del 1963 al Vajont sia crollata una diga, allora è il caso di leggere La tragedia del Vajont: Ecologia politica di un disastro, saggio di Marco Armiero pubblicato nel 2023 da Einaudi. Grazie a questo libro si capirà che è giusto, è legittimo parlare di disastro, di tragedia e di crollo, ma che nessuno di questi è un concetto neutro, né tantomeno apolitico. E che al Vajont la diga è rimasta in piedi. È stato tutto il resto a crollare: il monte Toc su cui la diga insisteva, il connubio tossico di potere scientifico e politico, la fiducia nelle istituzioni.
Il libro di Armiero è attraversato da storie e memorie, dati scientifici e atti giudiziari: narrativa, storia, scienza e diritto che, attraverso il focus sul Vajont, vengono efficacemente presentate per quello che sono o dovrebbero essere, ossia pratiche partigiane. Troppo spesso viene evocata una presunta oggettività e autonomia dei saperi, per cui sarebbe possibile fare letteratura prescindendo dal contesto sociopolitico che questa produce, oppure appigliarsi al sapere tecnico-scientifico come a una dimensione scorporata, in grado di dirigere un progresso apparentemente auspicabile, o ancora ricorrere alla magistratura come a un organo di affidabile neutralità. Il lavoro di Armiero è invece lì a ricordarci che qualsiasi narrazione che si presenti come pacificata, univoca e neutrale nasconde in realtà dinamiche di potere che a quella visione delle cose hanno deciso di dare spazio e autorità, a discapito di altre. Laddove una divisione di campo dunque esiste, pur nascosta sotto il manto rassicurante del buonsenso che presenta una sola realtà come “normale”, tanto vale decidere di prendere parte, di prendere una parte, di farsi partigiani nella pratica letteraria e storica, ma anche scientifica e giuridica: di dare voce a chi di solito non ne ha, scoprendo presto che quella parte è, in fin dei conti, molto più vicina al tutto di quanto non lo sia la parte dominante, vicina solo a pochi (ricchi).
Già nel precedente Le montagne della patria (Einaudi 2013) Armiero era entrato nel dettaglio delle disuguaglianze e dei conflitti che hanno attraversato i paesaggi montani dall’unità d’Italia in poi. La costruzione del bacino idroelettrico del Vajont rientra a pieno titolo in questa storia problematica e tutt’altro che conclusa. Un progetto visionario, messo insieme per la prima volta nel 1926 dall’ingegner Carlo Semenza, poi a più riprese modificato e ampliato, approvato in assenza di sufficienti votanti, modificato ancora e ultimato nel 1959. A riprova che di immaginazione l’uomo contemporaneo non è davvero sprovvisto, o almeno fintanto che questa si applichi alle più assurde tra le «magnifiche sorti e progressive». Se è forse vero che, per molti, è più facile immaginare la fine del mondo che del capitalismo, come sostenuto da Mark Fisher in Realismo capitalista (Produzioni Nero 2018), d’altro canto il capitalismo stesso non è mai stato timoroso di immaginare opere prima inimmaginabili, di sfidare le leggi della natura dando ossigeno ad arroganti manie di grandezza. Forse non a caso, l’energia sprigionata dalla frana del Vajont è stata spesso quantificata in relazione a un altro disastro della storia del capitalismo moderno: la bomba atomica di Hiroshima, il doppio della potenza della quale si è abbattuto sulla cittadina di Longarone in quel famigerato 9 ottobre.
Durante quella che Armiero chiama un’«apocalisse di periferia» (p. 30), un mondo intero incontra la propria fine, di nuovo a parziale smentita della visione di Fisher: in effetti di mondi che scompaiono, al tempo della sesta estinzione di massa, ce ne sono stati e continuano ad essercene molti, come raccontato con acume anche da Fabio Deotto in L’altro mondo (Bompiani 2021), discusso qui. Sta alla letteratura e alla storia, quando praticate come esercizi di resistenza, rendere conto di questi processi. All’intersezione tra letteratura e storia, Armiero si sofferma a lungo sul concetto di memoria. Contro la memoria irreggimentata e ufficiale (quella che ha portato alla costruzione nel 2003 del memoriale del Vajont «come un luogo anodino, asettico, dove il dolore deve essere composto e la rabbia anestetizzata», pp. 118–119), lo studioso propone una serie di memorie diverse, plurali, insorgenti e irregolari (che avevano spazio nel precedente cimitero di Fortogna, curato dai parenti delle vittime, in cui si potevano leggere iscrizioni come questa: «Barbaramente e vilmente trucidati per leggerezza e cupidigia umana attendono invano giustizia per l’infame colpa. Eccidio premeditato», p. 87). Una lezione di storia partigiana da tenere bene in mente durante il prossimo Giorno della Memoria in tempi di genocidio inverso.
Come si diceva, il Vajont ha rappresentato, in fase di progettazione, la peggiore versione della creatività tecnologica post-umana, che ancora oggi si illude di poter affidare ai techno-fixes la soluzione a una crisi socio-ecologica estremamente complessa – e dalla quale bisognerebbe cercare di uscire in levare più che in battere, più attraverso la decrescita che per mezzo di una presunta crescita verde. Nel suo crollare e uccidere circa duemila persone, invece, il monte Toc si è trasformato in una diga post-umana di diverso tipo, fatta di alberi e travi, mobili e fango, bestiame morto e cadaveri umani. L’interconnessione tra diverse forme di vita si è resa evidente in forma di morte, anzi in forma di scarto, di waste – da cui Wasteocene, alternativa alla definizione di Antropocene proposta dallo stesso Armiero, in quanto «era dominata da relazioni socioecologiche che producono comunità umane e non umane di scarto attraverso processi di estrazione di valore e alterizzazione» (p. 16). Eppure la montagna stessa aveva parlato, nella sua lingua ambigua, di quell’interconnessione ignorata: i sussurri degli alberi, le frane, i movimenti delle rocce, gli animali spaventati, tutti avevano segnalato il cedimento progressivo di quel monte che già nel nome (Toc, in dialetto veneto e friulano, significa ‘zuppo’, ‘marcio’, ‘guasto’) portava il segno della paleofrana ben nota tra la popolazione locale, ma “scoperta” ufficialmente solo tra il 1959 e il 1960, a lavori praticamente ultimati.
Si intrecciano così due dei discorsi di maggiore interesse discussi ne La tragedia del Vajont: da un lato la prospettiva di una narrazione (e di una lingua) alternativa per parlare di ambiente al di fuori da dinamiche estrattive, dall’altro il bisogno di un ripensamento drastico della pratica scientifica.
Se la narrazione idroelettrica rappresentava le montagne come una sorta di terra vergine da “sviluppare”, la realtà, invece, parlava di vallate affollate di uomini, piante e animali. Trasformare una vallata alpina in un motore idroelettrico significava anche questo: mettere fine al complesso insieme di relazioni socioecologiche che costituivano la vita di quei montanari e del loro ecosistema (p. 90).
Armiero si sofferma a più riprese sull’infrastruttura narrativa tossica che ha normalizzato e invisibilizzato l’ingiustizia perpetrata ai danni dei montanari, dalla fase di progettazione a quella di compianto delle vittime. Laddove ogni principio di precauzione è stato ignorato, si è dovuto imbastire un discorso che naturalizzasse le scelte scellerate dello Stato e della SADE (Società Adriatica di Elettricità), ridicolizzando al contrario i legittimi timori della popolazione locale. Firme di prestigio come Dino Buzzati, Giorgio Bocca e Indro Montanelli, persino di fronte al disastro compiuto, hanno mantenuto la linea dell’imprevedibile evento naturale – linea che scagionava i colpevoli facendo evaporare il concetto di responsabilità umana tout court – laddove voci coraggiose e informate come Tina Merlin avevano da tempo messo in guardia sulle prevaricazioni e sui cedimenti strutturali manifestatisi ai danni della popolazione e del territorio intorno al Vajont. Il monologo di Paolini nominato in apertura (Vajont 9 ottobre 1963), ma anche il Teatro popolare di ricerca fondato da Lorenzo Rizzato nel 1964, nascono proprio per illuminare la statura morale e il valore della disobbedienza civile di figure come Merlin e Rizzato stesso (tecnico e disegnatore presso l’Istituto di Idraulica dell’Università di Padova, che fece circolare documenti fondamentali per dimostrare le responsabilità del disastro). Lo stesso libro di Armiero si inscrive in questa genealogia, e i relativi riferimenti alla lingua della montagna e al lessico stratigrafico offrono spunti di riflessione a più ampio spettro, in direzione di una letteratura ecologica in grado di prestare attenzione e elaborare linguaggi altri rispetto a quelli umani, creativi e partecipativi.
Così come partecipativa è la pratica scientifica proposta da Armiero, in opposizione alla collusione tra politica e scienza ufficiale, potere scientifico e tecnico, che al Vajont ha dato il proprio peggio. Bruno Latour ci ha insegnato quanto il sapere, incluso quello scientifico, sia sempre politico e mai del tutto scorporato dal contesto anche materiale in cui viene prodotto. Nel suo saggio Armiero compie un passo ulteriore, introducendo correttivi possibili a questa apparente impasse:
il Vajont sembra davvero l’esperimento perfetto per capire cosa sia la scienza post-normale teorizzata da Silvio Funtowicz e Jerry Ravetz ormai trent’anni fa. Per Funtowicz e Ravetz, la scienza post-normale entra in gioco quando l’incertezza è alta, i pareri discordanti e le comunità coinvolte domandano una partecipazione nelle scelte – praticamente sembra di essere al Vajont tra relazioni geologiche divergenti e cittadini preoccupati dai presagi di sciagura. In casi come questo, Funtowicz e Ravetz vorrebbero un extended peer review, ovvero un coinvolgimento non solo degli esperti – come avviene nel peer review tradizionale – ma anche delle comunità interessate nella costruzione e legittimazione del sapere (p. 45).
Molto utile, in questo senso, anche il concetto di strong objectivity, introdotto dalla filosofa femminista Sandra Harding e chiosato da Armiero come «una obiettività più forte che faccia leva sul punto di vista del ricercatore invece di provare a nasconderlo sotto una presunta neutralità» (p. 14). Non siamo troppo lontani dalla nozione già husserliana di intersoggettività, in base alla quale il metodo scientifico, piuttosto che ambire a un’impossibile oggettività indipendente dalla consapevolezza e dalla soggettività di chi indaga, permette piuttosto di avvicinarsi a una sempre maggiore conoscenza di ciò che può essere esperito da molti soggetti diversi (umani e non-umani).
In chiusura, e intrecciando un’ultima volta il contesto narrativo e quello scientifico, varrà la pena di ricordare, con Armiero, che l’unico geologo italiano ad avere il coraggio di denunciare la prevedibilità della frana fu Floriano Calvino, fratello di Italo. Quando il giudice istruttore Mario Fabbri, non convinto dalla tesi dell’imprevedibilità del disastro portata avanti da una commissione di esperti italiani corrotti, decise di nominare un altro collegio di periti, che in effetti non ebbe poi dubbi sulla tesi opposta, il nome di Calvino spunta come un’eccezione in un gruppo di studiosi altrimenti esclusivamente stranieri. Armiero non aggiunge molto se non, in nota, che questa scelta di campo costò a Calvino la sua posizione di precario presso l’Università di Padova. Per i curiosi, si riporta qui una lettera a Carlo Castagnoli, ex ordinario di Fisica all’Università di Torino, contenuta nel Meridiano delle Lettere di Italo Calvino, che aggiunge dettagli a questa vicenda dolorosa e paradossale:
Torino, 5 febbraio 1970
Caro Castagnoli,
non ci vediamo da tanto tempo e inaspettatamente ti scrivo per una questione di concorsi di cattedra. E per di più di materia lontana dalle tue e ancor più dalle mie specialità: geologia applicata. So che il 12 le Facoltà di Scienze votano i membri della commissione per un concorso di geologia applicata e io vengo a pregarti di votare per Sergio Conti (Università di Genova) e Bruno Zanettin (Università di Padova).
La ragione è che a questo concorso si presenterà mio fratello, Floriano Calvino, attualmente incaricato a Genova e che nonostante la mole e la qualità dei suoi lavori non viene mai ternato per una ragione molto semplice: è quello della perizia sul Vajont, cioè ha rotto l’omertà dei geologi legati ai gruppi idroelettrici. Da quando ha accettato l’incarico della magistratura, nonostante le minacce aperte, e l’ha condotto con uno scrupolo straordinario facendo della sua perizia un piccolo capolavoro di storia della nostra tecnologia, non si è visto intorno che strade sbarrate. I due nomi che suggerisce sono i soli che gli diano garanzie di rompere il fronte avversario. […]
Sarebbe bello pensare che l’accademia italiana fosse nel mentre cambiata. Il fatto che uno studioso del calibro di Armiero abbia sviluppato gran parte delle proprie ricerche all’estero fa temere il contrario.
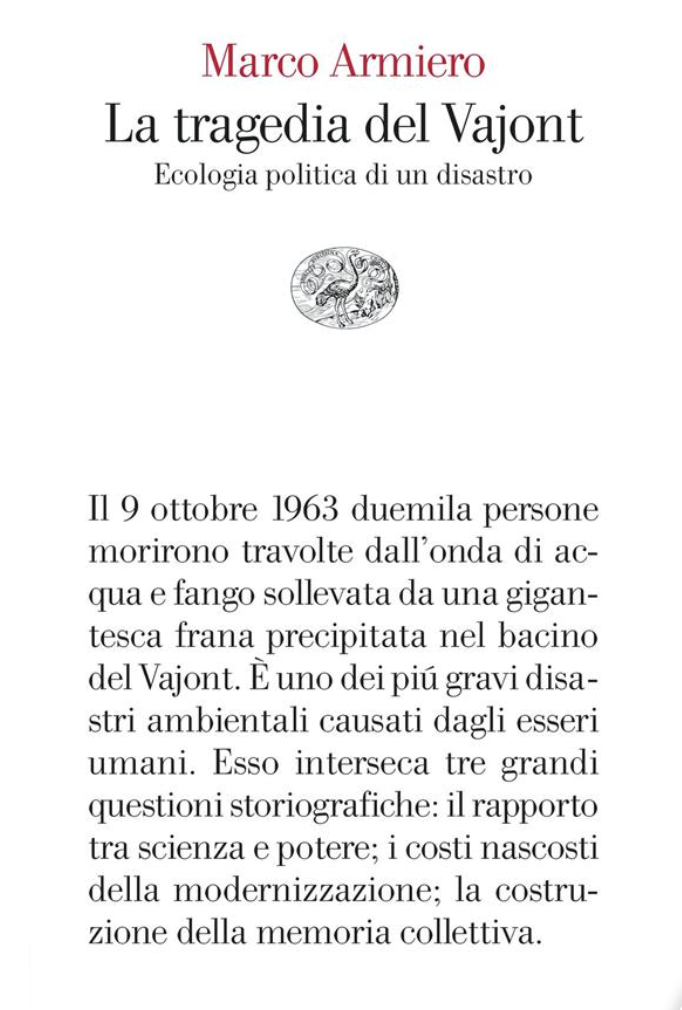
Marco Armiero, La tragedia del Vajont: Ecologia politica di un disastro, Torino, Einaudi 2023, 12€, 160 pp.