Nell’accingermi a scrivere questa recensione, è un peccato dover notare che Wang Xiaobo è un autore perlopiù sconosciuto a gran parte dei lettori italiani interessati alla narrativa cinese. Malgrado questo pubblico sia già, a modo suo, un pubblico specialistico, anche a questi lettori interessati, se non leggono il cinese, resta purtroppo preclusa una notevolissima gamma di scrittori che hanno portato contributi di alto livello alla letteratura cinese contemporanea. Ciononostante, lo sforzo di alcuni editori, compreso Carbonio, sta producendo rilevanti sviluppi: tra questi c’è l’arrivo, finalmente, di Wang Xiaobo in traduzione italiana (nell’ottima resa di Alessandra Pezza).
Nato nel 1952 da una famiglia di intellettuali, Wang Xiaobo, come molti altri giovani della sua generazione, non ha ancora vent’anni quando inizia la Rivoluzione culturale (1966-1976), che lo vede presto esiliato nelle campagne prima, e in fabbrica poi, come “giovane istruito” – categoria che denotava i laureati mandati a svolgere lavoro manuale. Con la fine del tumultuoso decennio lo troviamo redattore del Guangming ribao, uno dei principali quotidiani nazionali; poco dopo, completati gli studi universitari, diventa professore.
Parallelamente comincia a scrivere, facendosi notare per lo stile fortemente umoristico e il tocco kafkiano – essendo lo scrittore ceco, tra le grandi “scoperte” del mondo letterario cinese degli anni Ottanta, uno dei suoi punti di riferimento, insieme ad altri tra cui Calvino. Lo contraddistinguono anche la sua attenzione agli umili, agli esclusi e, su piani diversi, una propensione alla trasgressione: trasgressione rispetto agli stili, alle interpretazioni storiche, ai temi. Uno dei suoi ultimi lavori, prima della morte prematura sopraggiunta nel 1997, lo vede sceneggiatore del film East Palace, West Palace, che contribuisce a rompere il tabù della rappresentazione dell’omosessualità in Cina; appena prima aveva curato, con la moglie Li Yinhe (nota sociologa e sessuologa), una pionieristica inchiesta sulla condizione delle persone gay nel Paese.
L’età dell’oro è tra le principali opere di Wang Xiaobo: romanzo con una marcata impronta autobiografica, dopo una gestazione di circa dieci anni esce finalmente nel 1994, inaugurando la famosa (ma non ancora tradotta, purtroppo) Trilogia delle Età, seguita da L’età dell’argento e L’età del bronzo (entrambi del 1997). La narrazione segue Wang Er, inviato nella campagna del remoto Yunnan come “giovane istruito” (configurazione in cui già si intravede il respiro autobiografico), dove intraprende una relazione con una dottoressa più grande di lui, Chen Qingyang. Con questa «scarpa sfondata», cioè considerata una poco di buono dal punto di vista della morale imperante, scopre il sesso, ma i due vengono scoperti e redarguiti dalle autorità, in linea con il paradossale puritanesimo del periodo. La narrazione balza poi negli anni Novanta, dove i due, la cui relazione si era interrotta quando Qingyang cominciava a chiedere qualcosa di più serio, riprendono un rapporto di amicizia, non senza che Wang Er abbia intanto intrapreso altre relazioni più o meno serie, che a vario modo costituiscono un’occasione di riflessione sul tempo trascorso e sulla propria posizione del mondo.
Il fulcro della narrazione, nonché forse il segmento più interessante del romanzo, è proprio la Rivoluzione culturale, con l’esperienza rurale di Wang Er che corrisponde alla sua maturazione personale e postadolescenziale. Se, da una parte, emergono in maniera inappellabile le violenze e le privazioni che caratterizzarono quell’esperienza per milioni di cinesi, d’altro canto a stupire è il tono estremamente leggero con cui Wang Xiaobo le narra: per i protagonisti – e questo potrà sorprendere – quella è anche un’epoca di avventura, addirittura di libertà. Se da una parte l’autorità politica è onnipresente, dall’altra viene meno quella non meno pervasiva e opprimente della famiglia, e per moltissimi cinesi ciò si traduce in una burrascosa maturazione personale, fatta spesso di scoperte anarchiche e improvvise – una situazione emozionante ben descritta anche da altri autori, in primis Wang Shuo, il cui racconto è stato portato al cinema dal bellissimo In the Heat of the Sun (Jiang Wen, 1994).
C’è chi ha letto questa leggerezza come un tratto conseguito nonostante la pesantezza dell’epoca, ma credo che dietro questa scelta estetica ci sia ben altro rispetto alla mera risposta a una situazione di oppressione autoritaria (l’unica lente attraverso cui fin troppo spesso viene interpretata la letteratura cinese). Non a caso, l’elemento centrale su cui si impernia il racconto è il sesso: strategia certamente di desacralizzazione dell’intero periodo e pungente sarcasmo letterario, ma anche atta a restituire un’immagine fedele della quotidianità di giovani uomini e donne nel fiore degli anni.
A contribuire a questa desacralizzazione della severa solennità che permeava la Rivoluzione culturale – e che tutt’ora ne caratterizza la memoria, o meglio l’oblio, in Cina – c’è la reazione degli organi locali del partito: quando Wang Er e Chen Qingyang vengono messi alla berlina per la loro condotta riprovevole, devono, com’era in uso all’epoca, scrivere lunghe confessioni per esporre i propri misfatti e manifestare pentimento. I dirigenti chiedono però sempre maggiori dettagli, e quella che sembra essere una situazione del tutto verosimile nel contesto dell’epoca (quando agli accusati si chiedevano sempre nuove e più minuziose autocritiche), scivola in un voluto parossismo, trasformandosi in un evidente voyeurismo da parte dei quadri di partito, che leggono le confessioni quasi come racconti erotici. Ecco dunque la forza della narrazione di Wang Xiaobo: l’erotismo, se non proprio veicolo di autodeterminazione, diventa una forma di compromesso con il potere, che si aggiunge ai mille altri compromessi quotidiani affrontati durante la Rivoluzione culturale (e non solo). L’età dell’oro riesce dunque a restituire il punto di vista di una larga fetta di giovani che crebbero durante il periodo: gli slogan politici restano sullo sfondo, mentre i giovani vivono l’adolescenza con le condizioni a loro date dall’epoca storica in cui si sono trovati a crescere.
C’è un significato profondo in questo, nell’ulteriore dimostrazione di come l’uomo riesca sempre ad adattarsi alle circostanzee a sopravvivere. Ma c’è anche un evidente valore storico: benché ampi settori di gioventù abbiano preso parte attiva al movimento, anche nella forma delle famose guardie rosse, la Rivoluzione culturale fu ben lungi dal mobilitare l’intera società. Se è vero che i suoi dichiarati obiettivi antiburocratici alimentavano la rabbia e la passione di milioni di giovani (intercettando peraltro un fenomeno globale: fermentava e poi infuriava il Sessantotto), tutto ciò avvenne comunque sotto il saldo controllo di una parte dell’apparato del partito e dello Stato, che si guardò bene dall’accompagnare questo afflato sino in fondo, arrivando presto a spegnere ogni entusiasmo. Ciò è tanto più significativo se si pensa che Wang Xiaobo scrisse il romanzo in una fase in cui la rappresentazione letteraria della Rivoluzione culturale era dominata perlopiù da narrazioni di sofferenza e sopraffazione, rispondenti all’intento politico della nuova leadership di chiudere i conti con quella fase e traghettare il Paese verso le riforme di mercato.
È però lo stile unico con cui Wang Xiaobo scrive L’età dell’oro che consente al romanzo di fare il salto dalla testimonianza (quale comunque non sarebbe, visto che il ricordo della Rivoluzione culturale è solo una parte della narrazione) alla letteratura vera e propria. L’ironia e il sarcasmo fanno infatti da puntello alla rivendicazione di una memoria personale, prima ancora che collettiva, anche se i confini sono più sfumati di quanto vorrebbe molta critica letteraria. Il punto di vista individuale, il primato dell’esperienza di vita e delle percezioni dell’individuo e la sua negoziazione con le circostanze dell’epoca sono ben espresse in brani come questo:
Siamo fatti della stessa pasta, lei e io, nessuno dei due è capace di seguire la via della gloria e del successo. Chi lo era, in quegli anni pensava ai due terzi oppressi dell’umanità anche quando dormiva. Io invece mi dicevo: “Ma chi li conosce questi oppressi?”. E poi: “Soffrono, d’accordo, ma io no? L’altra sera ho messo un piede in un formicaio. Siccome a forza di stare a mollo nelle risaie la tigna mi ha fatto marcire la pelle tra le dita dei piedi, i loro morsi erano come stilettate al cuore!” (p. 204)
Chi, come il sottoscritto, della lotta alle oppressioni ha fatto il senso della propria militanza, dovrà fare uno sforzo per vedere in queste parole non tanto una glorificazione del menefreghismo e del qualunquismo, quanto una netta dichiarazione in difesa del valore dell’esperienza individuale (quantunque limitata nella prospettiva o ristretta alle minuzie della quotidianità) in un contesto in cui quest’ultima era invece sistematicamente oscurata o svalorizzata.
Che questo però non sia l’unico orizzonte del romanzo lo dimostrano altri punti della trama che sembrano andare nella direzione opposta. Più volte il narratore Wang Er (o Xiaobo?) si chiede se quanto sta narrando sia accaduto davvero, addirittura se lui stesso sia mai esistito, fino a sfumare nella dimensione del sogno o della metaletterarietà, per esempio nelle pagine in cui il narratore arriva a immaginarsi una narrazione alternativa di sé stesso. Cosa abbiamo di fronte? Una conferma del proprio soggettivismo, spinto fino all’estremo per cui ognuno è libero di immaginarsi cose effettivamente non esistite, o una sua negazione, dato che l’esperienza individuale sembra essere, in ultima analisi, inaffidabile? E perché non entrambe le cose? Qui torniamo al punto: la distinzione tra esperienza individuale e collettiva è tutt’altro che rigida: anzi, tra le due dimensioni c’è un rapporto dialettico che Wang Xiaobo sembra cogliere quando scrive:
[…] in questo romanzo, nemmeno un nome corrisponde al vero. Campanellina forse non si chiama ‘Campanellina’, ma ‘Grande Campana di Yongle’. Wang Er non è ‘Wang Er’, ma ‘Li il Butterato’. L’Istituto Minerario non è l’‘Istituto Minerario’ ma ‘la scuola di medicina dell’università Sun Yat-sen’. Filetto non ‘Filetto’ ma ‘Sacco di iuta’. Il signor Li non fu mandato ad Anyang ma da un’altra parte. I nomi non sono reali, i luoghi nemmeno; i fatti però sì. (p. 181)
Ci sta forse suggerendo, Wang Xiaobo, che la sua è una storia che può riguardate tutti i cinesi, visto che i nomi e i luoghi possono mutare, ma non i fatti? E se è pur vero che il narratore si riferisce qui a fatti reali avvenuti nelle minute vite di queste persone comuni, è possibile che l’osservazione sia valida anche per fatti di portata storica?
In effetti, questo rapporto biunivoco tra esperienza individuale e collettiva si manifesta anche nella temporalità del romanzo. La trama si sviluppa su livelli temporali distinti, dalla Rivoluzione culturale degli anni Settanta agli anni Novanta, passando dall’uno all’altro non in modo progressivo, ma per balzi. I lettori si trovano spiazzati di fronte a questi salti temporali, ma a far loro compagnia ci sono i personaggi stessi: nelle fasi posteriori, infatti, il narratore si ritrova spesso a riflettere sul passato, identificandone i segni nel presente, ma anche cogliendo gli enormi cambiamenti avvenuti. Se probabilmente ciascuno di noi, fermandosi a riflettere sull’immensità del tempo trascorso rispetto al passato più remoto della propria vita, può facilmente ritrovarsi in questa dimensione, ciò è tanto più vero per un lettore cinese: in questa progressione per balzi troviamo infatti riflessa la turbovelocità dello sviluppo economico dei vent’anni trascorsi (oggi quaranta) dall’inizio delle riforme. La Cina ne è uscita trasformata così a fondo e così velocemente da disorientare chi ha vissuto questa marcia a tappe forzate, un po’ come un europeo nato all’inizio della rivoluzione industriale che si ritrovasse all’improvviso nella seconda metà del Novecento.
È, forse, proprio questa inafferrabilità del tempo che Wang Xiaobo vuole tentare di acciuffare con la scrittura de L’età dell’oro – e, del resto, il tempo è già nel titolo. Se tendiamo a vivere con lo spirito espresso da Wang Er quando si dichiara assuefatto «a quello che h[a] attorno. Il passato è passato e il futuro non […] stupisce più» (p. 180), la letteratura può invece richiamare la nostra attenzione sul fatto che «Gli anni che scorrono come acqua sono tutto ciò che possediamo, l’unica cosa che davvero ci appartiene» (p. 212).
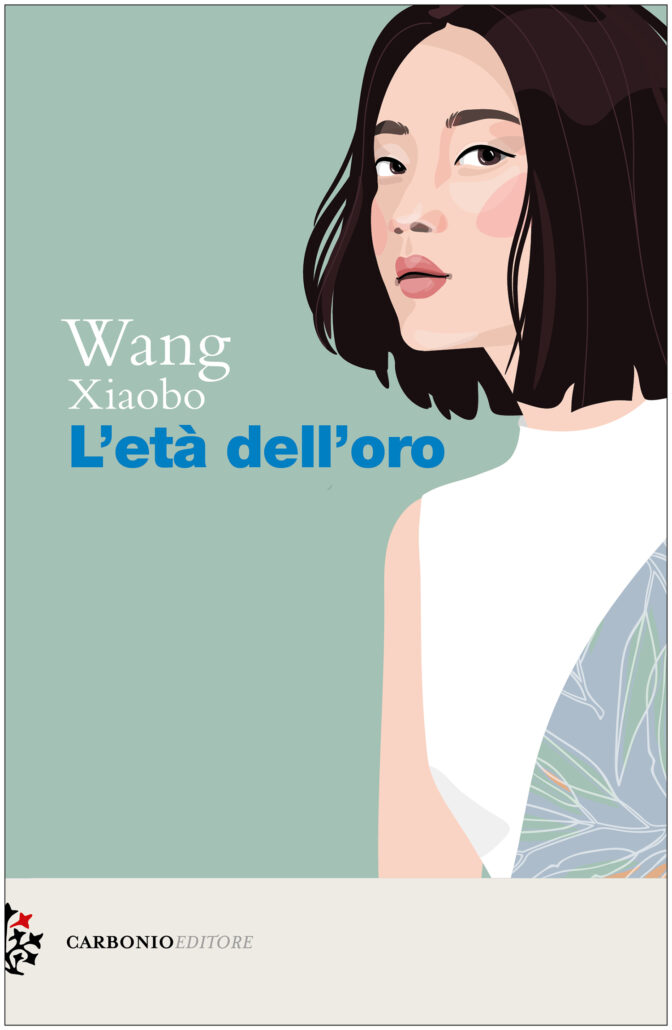
Wang Xiaobo, L’età dell’oro (1994), trad. Alessandra Pezza, a cura di Patrizia Liberati, Carbonio Editore, 2024, 254 pp., € 21,00.