«Gli avvenimenti si verificano in un senso e noi li raccontiamo in senso inverso. Sembra che si cominci dal principio: “Era una bella serata dell’autunno 1922. Io ero scrivano di un notaio a Marommes”. E in realtà si è cominciato dalla fine».
Scriveva così Jean-Paul Sartre nella Nausea (1938). Si riferiva alle condizioni materiali, spesso occultate nel linguaggio, ma al contempo così decisive nel determinarlo. Di lì a poco, la storia avrebbe esposto fino a dove si può spingere la verità di questa frase. Parlare di Gargoyle. Cronache di Guerre, Prigioni e Rivolte di Jake Hanrahan (Nero 2024) – tradotto quest’anno da Mattia Salvia, fondatore di Iconografie – significa parlare di condizioni materiali; e per farlo vorrei concedermi un piccolo détour, partendo a mia volta da una fine: la fine della Storia.
È nota la tesi di Francis Fukayama, formulata nell’epoca che vedeva la trionfale vittoria del “primo mondo” sul blocco comunista, e che di anno in anno si è mostrata essere più fallace. Le guerre balcaniche stavano lì a dire che la fine della guerra fredda non aveva portato al termine dei conflitti fra popoli. L’11 settembre ha colpito l’idea stessa di un’intoccabilità dell’impero statunitense, e la crisi finanziaria del 2008 ha fatto vacillare la convinzione che i sistemi liberal-capitalisti fossero ormai giunti a perfezione.
A dispetto di ciò, gran parte della narrazione mainstream ha perseverato nel raccontare il mondo come se la Storia fosse finita. Mentre il mondo andava avanti, giornalisti, analisti, politici e politologi analizzavano i processi in corso come se fossero dei bug del sistema, dei momenti di default temporanei prima che tutto ritornasse alla normalità, e che verso occidente l’impero continuasse a dirigere il suo corso. Gargoyle dà invece occasione di riflettere su come invece la prosecuzione della Storia si annidasse in nuce proprio in quelle zone d’ombra, invisibili agli occhi del mainstream, dove stava nascendo una nuova forma, ambivalente ma potenzialmente positiva, di barbarie.
Di questo parlava Esperienza e Povertà (1933), testo di Walter Benjamin che affronta la dissoluzione del racconto generazionale. Amara questione, l’immiserirsi della capacità esperienziale dell’umanità uscita dalla Prima guerra mondiale, muta davanti al trionfo di una tecnica ormai capace di dominarlo, costretta a vivere in un mondo «in cui niente era rimasto immutato tranne le nuvole, e nel centro – in un campo di forza di esplosioni e correnti distruttrici – il minuto e fragile corpo umano».
Benjamin trovava una via di fuga dalla crisi della modernità nella nascita di una nuova barbarie – che, dopo aver assunto la propria miseria, agisse in maniera trasformativa sul mondo:
A cosa mai è indotto il barbaro dalla povertà di esperienza? A ricominciare da capo; a iniziare dal nuovo; a farcela con il poco: a costruire a partire dal poco e inoltre a non guardare né a destra né a sinistra. Tra i grandi creatori ci sono sempre stati gli implacabili, che per prima cosa facevano piazza pulita.
Gargoyle fa parlare i barbari contemporanei, altrimenti disprezzati, scherniti o ignorati. Perché, come dice Hanrahan stesso nell’introduzione, “Chi è così fortunato da vivere al caldo e al sicuro debba quantomeno rendersi conto di quello che c’è fuori”. Questa stessa povertà dell’esperienza oggi assume caratteri totalizzanti ed egemonici nelle narrazioni collettive, che raccontano ciò che accade a interi popoli come qualcosa di inscritto in un eterno presente impossibile da modificare in maniera sostanziale.
Così è anche delle narrazioni apparentemente più dinamiche, come le analisi geopolitiche tanto in voga negli ultimi anni. Non potendo più glissare sui conflitti in corso come “altro da sé”, questi discorsi utilizzano il frame dei rapporti fra Stati-Nazione come unica chiave di lettura, presupponendo una sostanziale fiducia nel fatto che “tutto tornerà a posto”, e sottintendendo la precisa volontà di negare importanza alle classi sociali e degli individui.
Se infatti lo zeitgeist è effettivamente rappresentato dal mero rapporto fra Nazioni, il cittadino può cullarsi nell’idea che niente è in suo potere e coltivare la speranza che, dopo le crisi economico-sociali o le guerre, tutto torni come prima, all’anno zero eterno di cui parla Fukuyama. Il “geopoliticismo” ci parla quindi sì di “Storia”, ma della storia del movimento astratto di ciò che domina ogni uso qualitativo della vita, la narrazione dello spettacolo del dominio come sola possibile sua levatrice. Ma, come scrisse Bertold Brecht in Domande di un lettore operaio:
Dove andarono, la sera che fu terminata la Grande Muraglia,
i muratori? Roma la grande
è piena d’archi di trionfo. Chi li costruì? Su chi
trionfarono i Cesari? La celebrata Bisanzio
aveva solo palazzi per i suoi abitanti?
[da Poesie di Svedenborg (1939), in Poesie, vol. II, Einaudi, Torino 2005, tr. it. di Franco Fortini]
La storia non è fatta solo di nazioni, dominatori, artisti e intellettuali organici, ma delle classi che si agitano all’interno delle società, talvolta per costruirle, talaltra per distruggerle. Ignorare questo fatto è sempre più difficile, e ne un esempio la questione dei separatisti del Donbass – sostanzialmente dimenticati dai grandi media, oggetto di interesse solo da parte di realtà politiche estremiste (di destra, di sinistra, di centro) e divenuti non soltanto il casus belli che, il 24 febbraio 2022, ha portato all’invasione russa dell’Ucraina, ma anche dei soggetti centrali nel dibattito storico.
Se dovessi andare a pattinare
Sul ghiaccio sottile della vita moderna
Trascinandoti dietro il silenzioso rimprovero
Di un milione di occhi rigati di lacrime
Non essere sorpreso quando una crepa nel ghiaccio
Appare sotto i tuoi piedi
Pink Floyd, The Thin Ice (The Wall, 1979)
In definitiva, i versi dei Pink Floyd sono la profezia di un’era in cui tutto viene raccontato come immobile finché non ci si schianta contro l’inevitabilità dei mutamenti, prodotti nella maggior parte dei casi dalle minuscole variabili impazzite che muovono la storia.
Torniamo così a Jake Hanrahan. La deriva da fine della Storia che continua a caratterizzare le narrazioni di massa è stata messa in discussione a partire dallo scorso decennio da una nuova generazione di giornalisti che, muovendo i loro primi passi sui nuovi media per poter competere coi grandi monopoli dell’informazione decidono – invece che seguire pedissequamente i loro passi – di concentrare la loro attenzione dai grandi eventi ad altri fenomeni, apparentemente marginali ma potenzialmente rivoluzionari.
Fra questi, uno dei più noti è proprio Hanrahan. Classe 1990, britannico, esordisce su «Vice» con un reportage sulle rivolte in Turchia che gli costa l’incarcerazione nelle prigioni di Erdogan. Da lì, i suoi viaggi lo condurranno in Rojava, in Ucraina, in mezzo a narcos marocchini e a nazisti americani, riuscendo (grazie al suo approccio quasi gonzo) a portare le loro storie sulle pagine di «Wired», «Rolling Stone», «The Guardian» e, per l’appunto, «Vice».
Nel 2018 fonda il collettivo di giornalisti indipendenti «Popular Front», che racconta i conflitti che avvengono nel mondo in presa diretta e in maniera cruda, senza mai banalizzare e senza dare loro una lettura preventivamente ideologizzata, divenendo con gli anni un vero e proprio caso mediatico e raccogliendo un inaspettato successo social.
Ed è con un tempismo pressoché perfetto, in un anno (com’è il 2024) in cui i giornalisti mainstream ci raccontano che tutto va bene mentre nel mondo migliaia di civili vengono sterminati, che Nero Editions – altra testata divenuta virale per la sua capacità di mostrare le immagini più bizzarre, peculiari e (per utilizzare un’espressione ormai abusata) iconiche del nostro tempo – ha dato alle stampe Gargoyle, libro d’esordio di Hanrahan, apparso per la prima volta nel 2021.
Il libro è una raccolta di alcuni dei migliori reportage di Hanrahan, pubblicati fra il 2012 e il 2021, e che lo vedono muoversi come già ricordato fra Turchia e Rojava, Ucraina e USA, incontrando figure che incarnano quella capacità di anticipare il corso della storia che la filosofia moderna ha definito spirito del tempo (e che, in assenza di una definizione migliore, potremmo continuare a dire tale).
Per fare soltanto alcuni esempi: i nerd anticivilizzatori che su internet creano il fanclub di Unabomber (al secolo Theodore Kaczynski) precorrono di almeno un lustro la rinnovata esplosione di popolarità del neo-primitivismo (poco importa se declinato in salsa ecofascista o anarchica). Allo stesso modo, il gruppo neonazista Atomwaffe Division, attivo dal 2013, sembra essere una sinistra anticipazione della nazificazione ormai tanto popolare in tutto il mondo occidentale, dove partiti di estrema destra come Alternative für Deutschland o il Rassemblement National (e non solo) sbancano alle elezioni.
Leggendo oggi Gargoyle, e osservando le macerie di questo mondo in rovina, viene da pensare a quello che spesso si domandano i parenti e amici di un assassino dopo che ha compiuto una strage: “C’erano tanti piccoli segnali, ma noi non ce ne siamo accorti. Come abbiamo potuto?”. Ecco: questi brevi reportage gettano lo sguardo proprio su alcuni piccoli segnali destinati a deflagrare in veri e propri tumulti storici. Ma anche su come vi agiscano dentro gli individui e le classi sociali.
Il reportage nella Repubblica Popolare di Donetsk, il cui titolo (Niente è vero, tutto è possibile) parafrasa il celebre motto della setta sciita degli Hashishins, ci offre la possibilità di vedere cosa diventino le persone in guerra. Come nel racconto La Guerra Invernale del Tibet di Dürrenmatt, infatti, il combattente vede il nemico ovunque, mentre a noi lettori (come anche all’autore) sorge il sospetto che stia combattendo contro sé stesso, vittima di uno show orchestrato da altri per giustificare la riproduzione del complesso militare-industriale.
Ovviamente la guerra non è solo questo. In Donbass ci sono stati 14000 morti fra il 2014 e il 2022, senza fare distinzioni forzose fra ucraini filogovernativi e separatisti. Eppure, nel corso di quest’ultimo anno (e soprattutto alla luce della strage perpetua in Palestina, a cui stiamo assistendo inermi) è diventato particolarmente difficile negare che la maggior parte delle operazioni militari combattano non tanto contro un nemico, ma per la propria riproduzione economica e spettacolare, mentre falcidiano indiscriminatamente quantità immani di civili.
Il miliziano filorusso, l’anarchico scozzese volato in Rojava per partecipare alla Rivoluzione libertaria dei curdi, la polizia turca che ammazza ragazzini minorenni e lo spacciatore che muove le dosi sul web: le voci dei reportage di Hanrahan non raccontano solo sé stesse, ma ci dicono ciò che noi siamo – nel bene e nel male – oggi, e qui sta la vera bravura dell’autore di Gargoyle: lasciar parlare l’esperienza, senza annacquare le storie con analisi o giudizi.
Questo libro, oltre a offrirci vari spunti su come si fa giornalismo indipendente, ci dà in ultima istanza una lezione di classe, dimostrandoci che è ancora quel significante vuoto che chiamiamo popolo a muovere il sottosuolo della storia. E lo fa rinfocolando una lunga tradizione giornalistica, che va dal Popolo degli Abissi di London a Dynamite! di Adamic, e che da troppo tempo sembrava essersi spenta.
Sulla tomba dell’architetto settecentesco britannico Christopher Wren si legge l’epitaffio: Si Monumentum Requiris, Circumspice, “se cerchi un monumento, guardati attorno“. Così è anche per la storia, e per ciò che la fa avanzare.
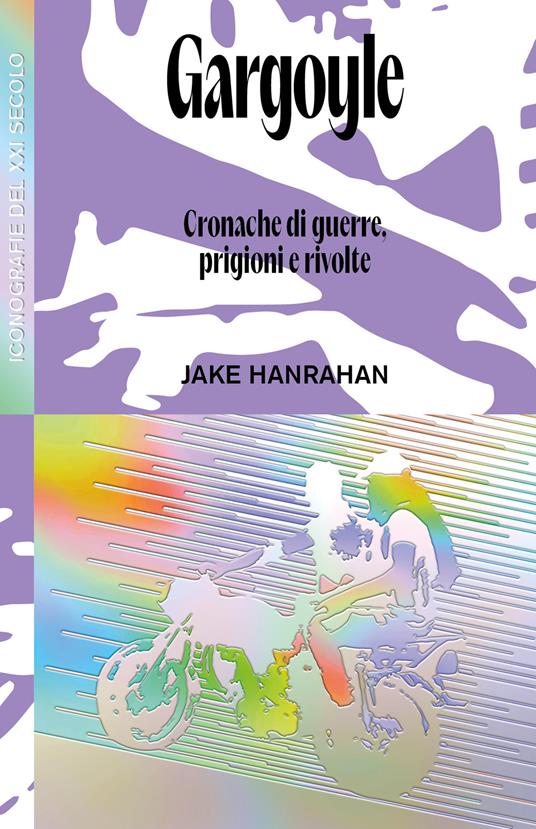
J. Hanrahan, Gargoyle. Cronache di guerre, prigioni e rivolte, tr. di M. Salvia, Nero 2024, 160 pp., €15.
(in copertina: J. Hanrahan, “Concrete frames sit at the side of the road, that’ll later be used by the YPG to build underground defence tunnels – Syria, 2019”)