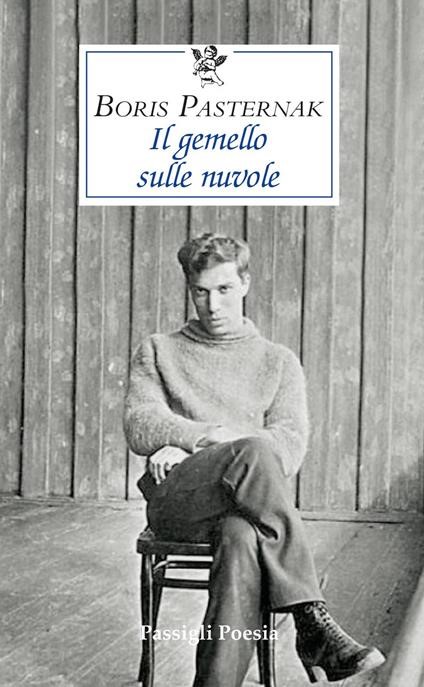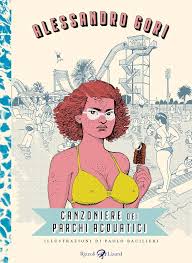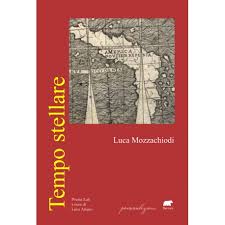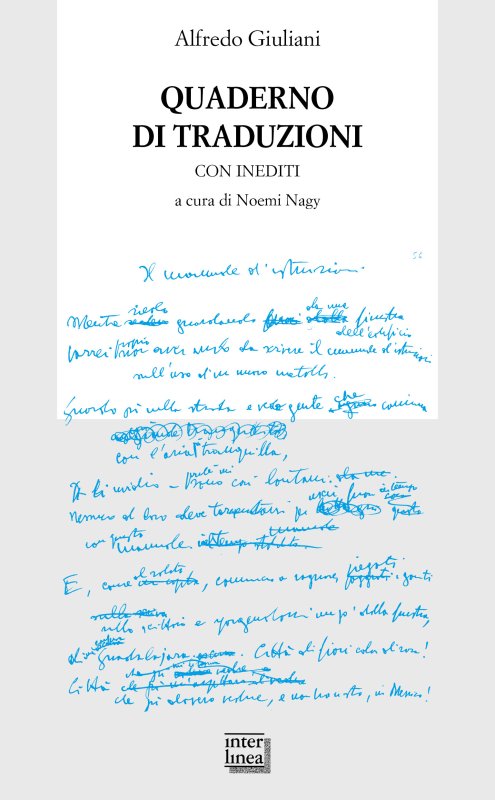Il governo, il futuro, pare sempre più nero: piovono querele e decreti sicurezza, tagli all’università e bombe sulle tende. Forse non sarà la poesia a salvarci, ma una piazza, col suo perimetro sfuggente, («come se ormai nessuna geometria | fosse non dico praticabile | ma neanche concepibile | più che una piazza vera e propria | […] il rimpianto o il rimorso d’una piazza»). O forse no, nemmeno, ma qui dodici titoli come molotov disperate, piene di chiodi e cocci.
Italo Testa, Se non sarò più mia, Pordenonelegge – Samuele Editore, 2024 (Lorenzo Cardilli)
Si può essere Montale ai tempi di Chat GPT e del quantum computing? Che ne è dell’epifania come strenuo, nobile conato dell’io, che cerca di raggiungere a forza, a testate, il miracolo delle cose – cento anni dopo? Dismettiamo il mito esistenzialista del soggetto contro tutti, pensiamo la sua dispersione nel mondo come fatto normale. Concediamo l’agency alle cose, pensiamo al singolo come un’emergenza non solo della specie, superando (a sinistra?) l’individualismo ma anche un vittimismo sempre comodo e spesso contundente, ricattatorio, una vergogna-clava. Pensiamo a tutto quanto come interstizio, come periferia. Come soglia in cui cose e persone si attraversano e sporcano a vicenda, trasferendosi l’un l’altra un po’ di essere, nel gioco indecidibile della “terza natura”. Leggiamo quindi, a Natale 2024, Se non sarò più mia di Italo Testa. Il titolo già dice molto su versi in cui ipotesi e scene sfilano in un legato rapidissimo, sono mondi possibili annodati dalle molte “o” additive, dall’onda lunga dell’iterazione e da una sintassi enorme, ininterrotta, monoperiodale. La stessa tecnica usata ne La divisione della gioia (della cui sezione eponima la plaquette risulta un’espansione) ma qui meno rigida, più matura, ultra-montaliana e insieme scoppiettante di un’euforia trasformativa e un po’ porno. «c’è un altro ordine, il rovescio | di questo nostro inquieto andare», un ordine che non sta in un cielo diverso o in una tempesta sul mare (Arsenio) ma – più che deangelisianamente – adesso. Un qui e ora democratico e non tragico, che si apre per ciascuno ma insieme indica tutti i tempi tutti gli spazi e tutte le persone. Posizione insostenibile? No, perché abbiamo davvero sospeso il giudizio, rinunciando a qualsiasi dover essere ideologico, aprioristico, prescrittivo (che non vuol dire anything goes, ma un più di impegno, di comprensione, di ragionamento). Possiamo quindi scrivere o leggere versi d’amore in cui un vorticoso unanimismo sta dentro e accanto l’esperienza singola, intrasferibile, in una miscela che genera «vana meraviglia»: «noi pulviscolo, noi ondate | di calore, miraggi dell’asfalto | noi segni a matita sulla carta, | figure a scomparsa nel tempo, […] | noi minime macchie di colore, | tu e io, effetti di luce | e adombramenti sulle foglie | ci condensiamo in un punto stiamo | per dire qualcosa».
Boris Pasternak, Il gemello sulle nuvole, traduzione di Paola Ferretti, Passigli, 2024 (Martina Morabito)
Crescevo: come Ganimede, a portarmi
erano le intemperie, erano i sogni,
mentre via dalla terra le catastrofi
dissipatrici in alto mi spingevano
Per sbirciare nel laboratorio poetico d’un poeta «di sensazioni iniziali, di improvvisi stupori, di incantamenti» (così lo disegnava Ripellino), che quattordici anni dopo l’esordio del millenovecentoquattordici si cancella, si riscrive, si corregge (e in questo libretto abbiamo entrambe le versioni, il debutto e il suo ripensamento, per la prima volta); per essere trasportati nello spazio lirico della stazione (cassaforte di congedi), del bosco (centicefala pineta), della Venezia stellare (accordo sconosciuto alle mani di pianista), del caminetto di maioliche dell’inverno (mesi di chiocciola e conchiglia, avvoltolati, concavi), della città bislacca di inizio secolo (sobborgo di oggetti smarriti, insonnia, balcone sulle onde, con i passages che ti fanno sbucare nell’afelio); ma, soprattutto, per alzarsi in alto, nella densità della volta celeste, tutta ricamata di orbite lunari, passaggi di stagioni e costellazioni (i Gemelli delle stelle doppie, lo Scorpione che rima con l’orizzonte, l’Acquario ardente del sé), allora si dovrà leggere questo «consanguineo delle stelle in transito», Boris Pasternak, con Il gemello sulle nuvole (Bliznec v tučach, Passigli), rispecchiato nell’italiano-caleidoscopio onirico, e audace, e prodigioso, di Paola Ferretti.
Doireann Ní Ghríofa, Bugie, traduzione di Antiniska Pozzi con Marco Sonzogni, Universale Biblion, 2024 (Pier Franco Brandimarte)
Dickinsoniana flying attitude, dal porto domestico a un altrove arioso, ma più sociale, che convoca amici, amanti, relazioni d’ogni tipo nel qui e ora lanciandole poi nelle dimensioni mutevoli del tempospazio. Disgorgare i termosifoni, pulire i pavimenti, pelare le patate, diventano manutenzioni sorprendenti che servono a rintracciare varchi e passaggi segreti tra le cose visibili e invisibili. Ricordi familiari che si connettono a storie libresche d’esplorazione, leggende che risorgono nel rumore notturno di una lavastoviglie. Negli oggetti familiari come la carta stagnola si ritrova la personalità fatata di un Odradek di kafkiana memoria. I testi scritti in gaelico e affiancati dalla versione inglese per mano dell’autrice acquistano un ulteriore passaggio di stato con la traduzione italiana rendendo ancora più marcato il tema della mutazione, del passaggio di stato delle sostanze, dei corpi che sublimano nel vapore, delle storie che vaporizzano la notte. E Lies, il titolo originale, bugie (che sottolinea forse le perdite della traduzione), fa pensare a una rima con ties, nel senso di legami, di quei legami immateriali che si muovono come spiritelli tutt’intorno e dentro di noi; e ci rivelano gli altri, e ci rivelano l’altro.
Florent Coste, Grammatica della letteratura, traduzione di Michele Zaffarano, Tic edizioni, 2023 (Stella Poli)
«Ogni teoria letteraria dovrebbe essere accompagnata e attenersi in maniera rigorosa a una filosofia del linguaggio adeguata e coerente», (p. 5): così inizia l’introduzione ai, frammentari ma non desultori, saggi di Coste raccolti nel volume (che rielabora alcuni interventi editi in francese, con integrazioni originali, creando un «italo-remix» inedito di Explore (Investigations littéraires), Questions théoriques, 2017). La filosofia adottata è quella wittgensteiniana: quello che Coste si propone di fare è di mostrarci come – adottando una concezione agentiva, e non sostantiva, del linguaggio – si possa ripensare i giochi di linguaggio letterari, fra cui la poesia, non a partire dal canone, ma a partire da pratiche ordinarie, senza disperderne però la «specificità potenziale», p. 6. Scagliandosi via via contro il mito espressivo dell’interiorità, quello dell’intenzionalità autoriale, della singolarità o della lettura solitaria, «sport d’alcova» (p. 7 e infra); provando a comporre «l’annoso divorzio fra letteratura e vita» (p. 27); Coste propone una politica letteraria, che parta dalla constatazione che «quella che abbiamo fra le mani non è una buona forma di vita, e non è nemmeno l’abbozzo di quella che potrebbe essere una buona forma di vita» (p. 47), per iscrivere infine la poesia in una «logica di resistenza» (p. 53), rivolta soprattutto a immaginare quel che non è ancora esistente, quel di cui, ancora, non è capace.
Alessandro Gori, Canzoniere dei parchi acquatici, illustrazioni di Paolo Bacilieri, Rizzoli Lizard, 2023 (Giulia Cittarelli)
«Stefania | vita mia» è la destinataria delle 32 “epistole d’amore” che scandiscono a intervalli regolari il tragitto del Canzoniere dei parchi acquatici, la raccolta in cui la macchina celibe Alessandro Gori si misura con il grado zero della scrittura in versi: brevità, rarefazione, accapo. Il mittente delle lettere è un turpe campione di manipolazione affettiva che tenta di ottenere il perdono per i propri adultèri ricorrendo ad argomentazioni dissennate, ribaltamenti del senso comune, autolegittimazioni a partire da una supposta superiorità intellettuale: se solo Stefania avesse letto Gente di Dublino o «il conte di carmagnola | (bellissimo questo | cosa ti sei persa!)».
La mimesi linguistica e dello stile di pensiero ci conduce ancora una volta entro quel registro caricaturale declinato in direzione del sinistro, interpolato da segni lugubri e disperati, che è la cifra dell’umorismo di Gori. In questa raccolta di poesie, la vis satirica di personaggi e situazioni deriva dalla presenza di coordinate di realtà mai completamente rovesciate, per cui il surreale non è che sollecitazione «laterale» di un fatto, il riscatto di un evento la cui espressione parziale nella realtà trova compimento di figura nella fantasia dell’autore.
Il libro si apre con l’immagine inquietante delle «lamette inserite nelle giunture degli scivoli dei parchi acquatici», ad anticipare il repertorio sadico che domina in molti di questi testi, la rappresentazione di una violenza che ha forse finito per contaminare la sacralità dei non-luoghi dell’infanzia cari all’autore: la Romagna delle «emozioni di plastica», degli stabilimenti balneari, dello Stecco Ducale Sammontana. «Solo quello che è replicabile non ci tradisce, non si ammala, non invecchia, non ci lascia soli. […] mentre le persone care che erano intorno a me o non ci sono più o si sono sfasciate sotto i miei occhi». Diversi testi della raccolta, difatti, indugiano sul recupero elegiaco di figure fantasmatiche e affetti morti: notevole, in questo senso, Civette, dove il gioco parodico e allusivo inziale («mi sono appollaiato | tra le fronde dei salici») sterza in explicit nell’affondo melanconico («ho scoperto | di aver inciso | la voce lontana | di mia madre morta»). Ne trova conferma la matrice luttuosa che in tanti hanno già riconosciuto al comico-grottesco dell’autore, al suo immaginario surreale popolato di oggetti-feticcio, giochi da tavola, fumetti, cultura televisiva, cronaca e storia recente. In questa raccolta troverete, oltre al noto dottor kevorkian, papa Giovanni Paolo II che canta Eccezziunale veramente, giri in moto con Cofferati, romantici amplessi con Forlani, salami che emettono strani rumori «tipo sguicci sguicci». Insomma, questo Natale leggete il Canzoniere di Gori oppure Il Conte di Carmagnola, che io comunque non ho mai letto, però anche quello bello, ve lo consiglio.
Isacco Boldini, Because it’s there, peQuod, 2024 (Roberto Batisti)
Il libro d’esordio di Isacco Boldini, classe 1991, è tanto generoso d’empito narrativo-descrittivo (e potenzialmente distruttivo) quanto parco di notizie paratestuali: dalla brevissima nota imparo solo che questi testi sono stati scritti nell’arco di dieci anni «tra Lione, Padova, Brescia e la sua provincia e sul treno che collega questi luoghi». E su un treno sto scrivendone ora: un treno arenato in mezzo alla pianura padana a séguito d’un incidente, con tanto ritardo accumulato che le ferrovie hanno ormai rinunciato a calcolarlo. Credo che alcuni viaggiatori stiano ormai pensando di prendere la residenza qui sopra. Ecco, anche se nulla so dell’autore, incagliate nella nebbia di una stasi surreale sono ormai le vite di tante persone della nostra generazione; c’è chi ormai ha arredato il vagone fantasma, disperando di scenderne, e c’è chi – forse la stessa persona – sogna di farlo saltare in aria.
Boldini, con una lingua poetica duttile e scaltrita, che evita la medietà o la genericità del poetese, parte proprio da una galleria di vite provinciali sospese fra l’abbrutimento e una futile eccentricità: dal Franco Rossi campione di mediocrità, «di casa tra i senza infamia e senza lode, | […] mimetizzati nei paesaggi circostanti», all’Uomo Cavallo, alla Teacher Wanda col suo italoinglese, all’indimenticabile Maga Bardelloni, alle cui “avventure” è intitolata la sezione, salvo che questa cassiera della Conad «non ne ha di avventure. | In questo momento è anche single».
A questa sezione, che forse deve qualcosa alla tradizione dei matti padani (ma con una comicità più amara e sferzante), segue l’eponima because it’s there – l’unica giustificazione necessaria per voler scalare l’Everest, secondo George Mallory. E qualcosa di verticale e atletico(/ascetico) c’è nella scrittura di Boldini, che alterna meditazioni neobarocche sul Male di Testa o sulla morte delle «bestie gigantesche» (dinosauri, mammut, autobus) a un’attesa quasi mistica della rivoluzione, scandita dai molti testi dedicati a Robespierre, M. de Guillotine, Prospero Gallinari…
L’autore, il cui verso lungo cede volentieri il posto alla prosa, corona il libro con due lunghi poemetti, anch’essi in prosa, che mostrano un’ottima capacità di costruire una tensione per frammenti e sussulti, e ribadiscono il clima di attesa apocalittica che entra nei polmoni di chi legge, ma in cui Boldini sembra respirare benissimo. L’ultima sezione, significativamente intitolata Uscita (memore dei Nuovi modi per uscirne di Simone Burratti?), consta di un solo testo, lucidamente geometrico nel delineare le due alternative a disposizione «mentre speriamo che il cielo non ci cada sulla testa» («Altro non si può fare»): accelerare l’entropia, o combatterla «ogni giorno, ogni ora, ogni minuto». Due scommesse, due vocazioni. Tertium non datur. Qual è la scelta di Boldini, e quale sarà la nostra?
Luca Mozzachiodi, Tempo stellare, Bertoni, 2024 (Massimiliano Cappello)
Tempo stellare (Bertoni 2023), ovvero «il miglior libro e mai recensito dell’anno 2024», se non mi sono perso qualcosa. Ma se ha senso oggi parlare di una distinzione tra raccolta e libro, tuttavia, propenderei per questo primo termine: distanze cronologiche, tematiche, “accordali” e forse addirittura timbriche fanno di questi testi una costellazione più che non un sistema. Un’adesione totale al proprio oggetto metaforico. Sembra rimandare pressoché direttamente all’epoca ‘stellare’ di cui Mario Tronti, in una pagina famosa, ha detto:
Differenza fine Settecento-fine Novecento: allora dietro le spalle, la Terreur rivoluzionaria, oggi dietro le spalle la Glorious Restoration. E noi, antilluministi, non possiamo permetterci il lusso estetico di essere romantici. Allora, la Sehnsucht del passato antico si nutriva di speranza della nuova vita, o della nuova libertà. Oggi, la nostàlghia dell’antichità moderna non può che soffrire di una «disperazione storica».
C’è bisogno di tornare meglio e a lungo sopra libri come questo, perché individuano un’estremità precisa dello spettro delle scritture contemporanee. Mozzachiodi affronta le medesime, cruciali e ben note questioni che tormentano le migliori espressioni del genere; e, su tutte, l’estrema guerra tra la propria indefinita proliferazione e l’impossibilità di esistere o di incidere compiutamente sul tessuto storico, metafora (se ce n’è una) d’altro. Ma lo fa con un sentimento (e una nostalgia) nei confronti del passato – con le spoglie marcescenti dell’istituzione letteraria (metro, ritmo, sintassi, figuralità) – che, pregiudicandola da subito, liberano l’espressione di ogni responsabilità nei confronti dell’innovazione. E alludono a direzioni ulteriori. Cum mortis in lingua mortua.
Noëmi Lerch, Benvenuti nella valle delle lacrime, traduzione di Anna Allenbach, sottoscala, 2024 (Noemi Nagy)
Noëmi Lerch (1987) è nata a Baden, in Svizzera. Vive in una fattoria della Valle di Blenio ed è pastora e scrittrice. Benvenuti nella valle delle lacrime, edito quest’anno da edizioni sottoscala nella traduzione italiana di Anna Allenbach, è il suo terzo libro. Si compone di quattro sezioni (Vita / Natura / Lavoro / Morire) che raccolgono al loro interno brevi o brevissime schegge narrative, tra prosa e verso. Queste rappresentano – per singoli nitidi quadri – le vicende di tre personaggi (lo Zoppo, il Tuinar e il Lombard) all’interno di uno spietato scenario campestre in cui «le croste nere della polenta si staccano dai bordi come una seconda pelle». Ciascun frammento è accompagnato da un’illustrazione in bianco e nero: l’apparato iconografico è curato dal duo Walter Wolf, composto dagli artisti Alexandra Kaufmann e Hanin Lerch. Il dialogo tra testo e immagini viene valorizzato dal particolare formato allungato del volume (11 x 24).
Elisa Ruotolo, Alveare, Milano, Crocetti editore, 2023 (Anna Taravella)
«Se stessero ferme – se per poco si quietassero | diventerebbe forse semplice | ipotizzare un destino». L’umanità vista dall’alto, come un frenetico, brulicante alveare. Ripercorrendo un topos classico della poesia, Elisa Ruotolo ci ritrae come piccole api: assorbite, risucchiate, dalla «furia del dovere». Lavoriamo sapendo di non avere scelta, ci sacrifichiamo per un bene più grande, che tuttavia non possiamo vedere. Nel ciclo di vita della Città del miele ogni ape ha un compito preciso e racconta la sua storia, confessa desideri, affronta paure. Nel nero del giorno, dove il rinnovarsi della terra sta nella distruzione, il veleno si rivela come « – la promessa che nulla resiste | allo schianto». In questa laboriosità funesta, unica urgenza è ripopolare, per essere spremuti fino all’ultima goccia: «non esiste un potere singolare | contro il morso selvaggio della pluralità». Sempre, in agguato, un futuro di morte. In questa raccolta ogni verso è una lama, le parole sanguinano, e la verità attraversa gli occhi, affondando nel cuore.
Alfredo Giuliani, Quaderno di traduzioni. Con inediti, a cura di Noemi Nagy, Interlinea, 2024 (Marcello Sessa)
I maligni spesso affermano, a ragione, che gli anniversari cadano perché ce ne si scordi, e che le messe a suffragio siano buone solo a vilipendere i morti. Tuttavia, in un panorama in cui gli studi umanistici – l’italianistica in particolare – sono calendarizzati dagli eventi, qualche ricorrenza tra le tante fa eccezione. Il centenario dalla nascita di Alfredo Giuliani ha fattualmente contribuito a una seria riconsiderazione della sua figura (capitale) oltre agli steccati della Neoavanguardia, e una nuova conoscenza e reperibilità del suo lavoro. Dal versante poetico, due sono i frutti più succosi: Poesie (uscito per Marsilio a cura di Luigi Ballerini, Federico Milone e Ugo Perolino), e il Quaderno che riunisce le sue traduzioni edite e qualche inedito (per cure filologicamente assai scrupolose di Noemi Nagy). Nagy, infatti, ha avuto il compito di mettere insieme molti pezzi: fondamentalmente, porzioni apparse in volumi già pubblicati (molti introvabili), e campioni del fondo dell’autore, conservato a Pavia. Il libro intero riesce in esiti extra-filologici perché, di un poeta e scrittore celebre per la sua multiforme inflessibilità, restituisce un’immagine nuova: ma soprattutto viva. Si guarda dall’alto il suo banco di lavoro e si toccano i singoli attrezzi con cui, sostanzialmente dai primi Cinquanta, Giuliani ha studiato con il verso forzando quella presunta oggettivazione del transito che è la traduzione. Le lingue principali sono due (francese e inglese, con una parentesi dal greco antico e una dal tedesco), e il lettore è convocato con lo sguardo a vedere quanto, sia con l’una sia con l’altra, il poeta renda duttili versi altrui, adoperando rigorosa fantasia. Il rigore viene dallo studio approfondito degli autori di partenza, e la fantasia è quella musicale, quasi, romantica, secondo cui da una prospettiva giulianiana la poesia – se ri-détta – si debba pure ascoltare, a costo di aggiungere crome e biscrome. Il risultato più stupefacente è forse la restituzione di un Henri Michaux affabulatore e misteriosofico, cosa che riusciva pochi, tanto che Carla Vasio, che nel 1961 aveva visto sfregiata la sua versione di Ailleurs da una mano altra imposta da Rizzoli, ha affermato che quest’ultima «il francese corrente certo lo sapeva ma il francese di Michaux è un’altra cosa». Giuliani, mutando gli a capo e sopprimendo poche preposizioni, quel francese invece lo fa suonare: «[Il mio sangue…] | con la tosse, l’atroce, la trance | mi costruisce castelli, | che illumina di tele, trame, macchie».
Pierluigi Cappello, Come un sentiero di matita – Poesie, prose interventi, Rizzoli, 2024 (Giulia Sarli)
Dal settembre di quest’anno ormai finito è nelle librerie Come un sentiero di matita, la raccolta integrale di poesie, prose e interventi di Pierluigi Cappello, poeta friulano che ha dovuto convivere con la sofferenza del corpo a seguito di un incidente in motorino avuto da ragazzo e che lo ha costretto sulla sedia a rotelle fino al primo ottobre 2017, giorno della sua morte, a cinquant’anni.
In un suo testo che ha titolo Cassacco, anno zero scrive che «c’è come un’intercapedine di luce […] tra le parole e le cose che sottolinea con ogni evidenza la nostra separatezza dal mondo» (p. 425). In questa intercapedine si avvera il tempo della caduta: il poeta-veliero «imbarca acqua, il fasciame danneggiato, la chiglia nella tempesta quando tenta di doppiare Capo Horn» (p. 425). Qui abitano le sue poesie: «fra l’ultima parola detta | e la prima nuova da dire | è lì che abitiamo» (p. 134). A me ricorda il principe Andrej di Guerra e pace che, gravemente ferito durante la battaglia di Austerlitz, si ritrova sdraiato in terra, nel campo brulicante di soldati. Crede che la morte venga a prenderlo e, osservando le nuvole sopra di sé, scopre come in una rivelazione il senso delle cose del mondo e di se stesso. Cappello scrive in quel tempo sospeso e le sue parole, sia nelle opere in italiano che in quelle in dialetto friulano, hanno un profilo dimesso («attieniti alla misura dell’erba» p. 127), prediligono il segno di matita, perché «L’anima di grafite non conosce sorte, esitazioni: | nel suo stesso procedere in avanti | ci chiama alla possibilità del ritorno, | nel suo segno scuro riposa la dolcezza del bianco» (p. 291). E in un’altra poesia, come quella precedente tratta da Azzurro elementare, è ancora più esplicita questa condizione liminale: «Scrivere come sai dimenticare, | scrivere e dimenticare. | Tenere un mondo intero sul palmo | e dopo soffiare». Cappello sa cogliere il margine in cui viviamo, i nostri gesti, le nostre voci, che nel momento di apparire già scompaiono. E sa dar vita a un paese, come in Parole povere, dove le strofe sono un montaggio di scene in cui si realizzano i movimenti minimi degli abitanti e che si chiude con tre versi con cui chiudo anche io: «perché non ho nessuna pietà di voi | perché ho soltanto i miei occhi nei vostri | e l’allegria dei vinti e una tristezza grande», (p. 251).
Jean-Marie Gleize, Tarnac. Un atto preparatorio, traduzione di Michele Zaffarano, Tic edizioni, 2024 (Simone Biundo)
Tarnac. Un atto preparatorio di Jean Marie Gleize, uscito per Tic nell’ottobre 2024 con la traduzione di Michele Zaffarano è il decimo volume della collana UltraChapBooks. Sul sito della casa editrice il box promozionale afferma che Tarnac «è un libro che non ha paura di sporcarsi le mani con i due luoghi più osceni del letterario, ossia il lirico e il politico». Uscito in Francia nel 2011, porta come titolo il toponimo di un piccolo paese di trecento abitanti della Nuova Aquitania, epicentro di un “affaire” repressivo finito in un nulla giudiziario ma esemplare come potente atto intimidatorio: Julien Cupat e i suoi compagni, cui il libro è dedicato, furono accusati di terrorismo e arrestati l’11 novembre 2008 dopo un sabotaggio compiuto ai danni delle ferrovie francesi (SNCF) nella giornata dell’8 novembre dello stesso anno sulla linea Paris-Lille. Tarnac, in 17 capitoli, una carta geografica, uno schema del giardino, quattro scure e grigie immagini di bosco, riporta una sorta di fascicolo d’inchiesta personale e collettivo, disarticolato, frammentato, appassionato, antiretorico, che «scorre dentro come fosse polvere». Reminiscenze individuali e lacerti burocratici, analisi critica e squarci lirici, teoria rivoluzionaria e artistica, elenchi oggettivi e pagine di diario si alternano e si rispondono componendo un macrotesto affascinante che mette sullo stesso piano l’atto poetico e l’atto resistenziale e che interroga il lettore sullo stato delle sue libertà e sui margini che può abitare in un mondo sempre più ostile a qualsiasi forma di dissidenza.