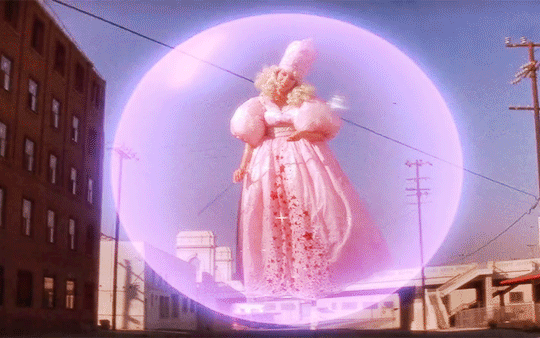La scomparsa di un regista come David Lynch ha bisogno di tempo per essere elaborata. A distanza di alcune settimane siamo ancora qui a parlarne. In questi giorni abbiamo rivisto i suoi film, le sue interviste, riascoltato la sua musica e ci siamo scambiati pareri e condoglianze. In particolare i balenieri Massimo Cotugno e Michele Turazzi hanno deciso di mettere per iscritto una loro conversazione su Lynch, in cui hanno riflettuto sul significato dell’opera del cineasta americano, scavando nel suo mondo a partire dalle immagini più evocative.
Massimo Cotugno: La prima scena che mi è passata per la mente quando ho saputo della morte di David Lynch è stato il capanno che brucia nel deserto in quella magnifica scena di Strade Perdute, il suo settimo film. Forse perché il fuoco è stato sempre il principale elemento nella personale tavola periodica di Lynch o forse perché se n’è andato mentre nella sua Hollywood divampavano gli incendi.
Nella scena le fiamme avvolgono l’edificio per poi essere inghiottite nuovamente dal buio, in reverse. Troppo facile lasciarsi andare a romantici collegamenti, in queste circostanze. Non esagero se dico che la notizia della sua scomparsa mi ha scosso come la morte di un parente. E proprio come in quei casi, sono stato colto dall’assurdo dispiacere di aver lasciato qualcosa in sospeso, di non avergli potuto parlare. Non ho idea di quali domande gli avrei posto – Lynch era uno che nelle interviste non metteva a proprio agio l’intervistatore – ma di certo avrei dovuto mettermi in fila, una fila chilometrica di persone che, come me, saranno rimaste con questo desiderio insoddisfatto. Perché dietro tutta quell’architettura onirica, quel buio misto a folgorazioni, Lynch sapeva parlare a ciascun spettatore singolarmente, attraverso un lessico ben specifico. Tu, Michele, cos’hai pensato quando hai ricevuto la notizia?
Michele Turazzi: Ho saputo della sua morte poco prima di ricevere il tuo WhatsApp (“e niente, ci ha lasciato Lynch. Ci metterò un po’ per riprendermi”). Ero al solito bar, mentre attendevo la birra appena ordinata ho dato uno sguardo al feed, e l’ho scoperto così, perché si stava riempiendo di frame dei suoi film. Non mi è servito leggerlo, sono bastate le immagini per capirlo. Quando la birra è arrivata, ho detto al gestore: «È morto Lynch», e pure lui ha avuto un attimo di smarrimento, poi ha detto qualcosa a proposito del fatto che adesso, a poco a poco, inizieranno ad andarsene tutti. Intendeva dire: tutti quelli che ci hanno formato, tutti quelli con cui siamo cresciuti. Quelli che da ragazzini credevamo immortali. Ho annuito, ma poi ci ho ripensato. Era come se fossi convinto che Lynch lo fosse davvero, immortale, pure se sono un adulto. Credo avesse a che fare con la vaga idea che lui vivesse già in una dimensione altra rispetto a chiunque di noi e dunque non ci fosse motivo per cui la sua vita finisse come quella di tutti gli altri. A quel punto ho pensato alla sua musica (probabile che dipendesse dal fatto che il solito bar ha un palchetto su cui, di tanto in tanto, si suona e delle chitarre appese alle pareti), o meglio al modo in cui utilizzava la musica nei suoi film. Quelle sferzate improvvise, a un volume altissimo e del tutto incongrue rispetto a quello che lo spettatore stava guardando fino a un attimo prima: le schitarrate elettriche che, in Cuore Selvaggio, fungono da contraltare ironico, i Rammstein di Strade perdute che invece preannunciano scoppi di violenza. A come, in fin dei conti, Lynch riuscisse a utilizzare lo stesso espediente retorico per dar vita a effetti opposti. E poi, subito dopo, il theme di Angelo Badalamenti di Twin Peaks. Ovvio: difficile immaginare qualcosa di più iconico. Ma prima di eccedere con la retorica ti vorrei chiedere se ti va di fare un gioco. A Lynch della coerenza e dei rapporti di causa-effetto gli è sempre interessato il giusto (aka: niente): e se provassimo anche noi, in questa conversazione a procedere per immagini e associazioni d’idee?
Luci elettriche e tacchi alti
MC: Ci sto. La prima immagine che mi viene in mente è quello della luce di una torcia che danza nel buio. A muoverla con grazia, quasi fosse una bacchetta magica, è Louise Dombrowski, una ragazza di cui non conosceremo molto altro se non la sua silhouette danzante in controluce. Si tratta di un’immagine rievocata dai fratelli Horne, in un episodio di Twin Peaks. Jerry è andato a trovare Benjamin arrestato come sospettato per l’omicidio di Laura Palmer, ma i due finiscono per divagare, perdendosi nei ricordi di infanzia. Quel momento dello show, così squisitamente slegato, del tutto gratuito, è la quintessenza della libertà creativa di Lynch. Si tratta di una scena ammaliante che gioca con elementi semplici, come la luce elettrica, il buio, una musica rétro e lo sguardo di due bambini ipnotizzati dalla danza di una giovane.
Credo che tutti gli spettatori si siano ritrovati in quell’istante catapultati in un momento perfetto della loro infanzia, quell’istante decisivo che credevamo di aver dimenticato. Con Lynch in fondo si tratta sempre di ripescare frammenti, andare in immersione per recuperare qualcosa che luccica nell’oscurità. A proposito di torce che illuminano corpi e oggetti nel buio, ricordo anche la morbosa sequenza delle bad girls, emanazioni che compaiono all’improvviso nella stanza di Laura Dern, in Inland Empire. Se nell’immagine precedente l’elemento erotico rimaneva sottinteso, qui lo sguardo è decisamente più esplicito. La luce fredda della torcia indaga nel buio sguardi desiderosi e, come in un interrogatorio, ascoltiamo confessioni scabrose.
MT: Erotismo che, d’altra parte, in Lynch è spesso, per non dire sempre, presente. Nel ballo, come hai giustamente sottolineato, nel canto, negli sguardi e nei primi piani, ma anche grazie a numerosi elementi secondari che vanno, di volta in volta, a enfatizzarlo. Uno di questi sono i tacchi alti: zeppe, spilli, stivali, ma sempre e comunque arrivando ad altezze vertiginose. Quelli di Isabella Rossellini, che, una volta rientrata nel suo appartamento dopo essersi esibita in quella sua indimenticabile interpretazione di Velluto blu (ne parleremo più avanti, di certo), davanti agli occhi di un Kyle MacLachlan nascosto nell’armadio, si spoglia di tutto, tranne che delle sue scarpe con il tacco; quelli di Patricia Arquette che, nella mezz’ora iniziale di Strade perdute, quando interpreta Renée, vengono indossati, in maniera del tutto incongrua, sempre e comunque, pure quando avvolta in una vestaglia da camera va alla porta per raccogliere, insieme al giornale, la videocassetta che darà avvio all’intero impianto narrativo; il campionario indossato da Laura Dern in Cuore Selvaggio, mentre noi spettatori la seguiamo nel suo road trip insieme a Nicolas Cage. La lista potrebbe essere infinita: se è pacifico dire che Quentin Tarantino sia letteralmente ossessionato dai piedi nudi, a cui ha dedicato centinaia di inquadrature, non sarà avventato affermare che David Lynch (al cui già citato Cuore selvaggio Tarantino deve moltissimo) fosse un vero fan del più tradizionale tacco alto.
Giacche di pelle e trucco
MC: Sì, le storie di Lynch sono piene di femmes fatales che sembrano uscite da romanzi noir o da fumetti di Dick Tracy. Magnetiche e seducenti, portano alla perdizione (come Isabella Rossellini) o alla salvezza (come Laura Dern), o si collocano in entrambi i luoghi, come Laura Palmer. In ogni caso, lo spettatore riconosce subito il loro valore da tratti e accessori vistosi. Lo stesso vale in un certo senso, anche per i personaggi maschili: quelli pericolosi, ad esempio, indossano giacche di pelle e guidano moto o auto veloci, da James a Bobby Briggs in Twin Peaks, fino ad arrivare a Sailor di Cuore Selvaggio (“Questa è la mia giacca di pelle di serpente. Rappresenta il simbolo della mia individualità e la mia fede nella libertà personale”) e più di recente abbiamo visto il Cooper cattivo nell’ultima stagione di Twin Peaks riprendere questo cliché. Gli uomini di potere invece sono sempre in uffici semibui, parlano attraverso interfoni e restano distanti da tutto. Credo che queste descrizioni stilizzate dei personaggi facciano parte di un codice, elementi ricorrenti con cui Lynch permette allo spettatore di riconoscere un mondo con le sue regole. A proposito di segnali disseminati lungo le storie, mi viene in mente anche il ricorso a certi usi del trucco, quasi fossero delle maschere di un teatro antichissimo. Penso alla spaventosa scena di Cuore Selvaggio, dove Marietta (Diane Ladd), resasi conto di aver condannato a morte il suo amato Johnnie (Harry Dean Stanton) si copre l’intera faccia con il rossetto, trasformandola in una dolente maschera di sangue.
Oppure il cerone bianco sul volto dell’uomo misterioso in Strade perdute, mimo spettrale e inafferrabile. Per non parlare delle maschere di pece dei demoni della terza stagione di Twin Peaks, giunti da un abisso talmente profondo da conservarne il buio sul proprio volto.
Serve pazienza e spirito di osservazione per decifrare il lessico di Lynch, per questo il regista dilata il tempo delle sequenze, in alcuni casi a dismisura, quasi fossimo in PlayTime di Jacques Tati (amato molto da Lynch). Quello che mi è sempre piaciuto dell’esperienza visiva di un film di Lynch (in particolare dei suoi ultimi lavori) è quell’invito a entrare in un intero universo, dove lo spettatore può perdersi, curiosare e tornare indietro. Oppure fermarsi al solito bar e ascoltare una canzone.
Il solito bar
MT: Già, il bar, il solito bar – proprio come quello in cui mi trovavo io quando ho scoperto che David Lynch ci aveva lasciati. Che sia il Bang Bang di Twin Peaks o lo Slow Club di Velluto blu, i suoi locali hanno caratteristiche così precise da sembrare lo stesso identico luogo teletrasportato di volta in volta in contesti diversi; e forse, è proprio così, dal momento che ogni scena girata da Lynch in qualsiasi suo lavoro può essere vista come un pezzettino di un’opera-mondo assemblata lungo una vita intera. C’è un palco, c’è un’insegna al neon rossa, ci sono pesanti tendaggi e c’è un’atmosfera rarefatta, fumosa, che richiama i vecchi film noir. Soprattutto, c’è qualcuno che, su quel palco, sta cantando (e altri che stanno suonando), dando vita a interpretazioni intensissime e sofferte. La già citata Isabella Rossellini, per esempio:
Ma non sono momenti di alleggerimento come accade in tanti altri film, e come fanno tanti altri registi; tutt’altro. È sufficiente soffermarsi sulle reazioni di chi ascolta: le lacrime di Dennis Hopper, l’intensità di Kyle MacLachlan. Insomma, la scena musicale, per Lynch, lungi dall’essere semplice sottofondo, è generatrice di senso, a tratti soverchiante, ed è strettamente collegata al modo in cui le sue opere vengono costruite: il significato si forma tramite giustapposizioni alogiche, intuizioni sensoriali. E che cosa c’è di più splendidamente intuitivo della musica? C’è poi, almeno credo, un secondo livello: la performance musicale stessa ci suggerisce che il mondo è teatro, finzione. Ciò che stiamo guardando non esiste davvero; e, se esiste, esiste in maniera rovesciata e irriconoscibile. Come in Fuoco cammina con me, dove l’ingresso di Laura Palmer nel Bang Bang ci conduce dritti alla sala rosa e al suo incubo di erotismo e violenza. Ma è nel Club Silencio di Mulholland Drive che la visione di Lynch si esplicita fino in fondo (oltre a dar vita a una delle scene più incredibili di quello che è stato eletto nel 2016 “miglior film del secolo”). No hay banda, non c’è la banda; eppure, la musica continua e continua e continua.
Suonala ancora, David
MC: È chiaro che per Lynch la musica è elemento portante e non accessorio. Del resto parliamo di un vero musicista, che ha saputo esprimersi come voleva anche con tastiere e sintetizzatori. Dalla collaborazione con John Neff per l’album BlueBob (di cui abbiamo anche uno spassoso videoclip con Naomi Watts, Eli Roth e lo stesso Lynch mascherato), fino ai suoi album solisti e alle ultime collaborazioni con Chrystabell (ultima sua musa che compare anche in Twin Peaks – Il ritorno).
Ma credo sia altrettanto importante ricordare la musica che ascoltava e che inseriva a commento nei suoi film. Si trattava di brani della sua giovinezza, da In Dreams di Roy Orbison a Blue Velvet di Bobby Vinton. Musiche che Lynch amava autenticamente, benché inserite nei contesti più stranianti. Del resto lui la paura la distillava dal quotidiano, dai momenti di apparente serenità. Lo immagino ora finalmente in un paradiso di eterna giovinezza anni Cinquanta, piena di interminabili e lenti pomeriggi tra amici e primi amori.
MT: Lo dici perfettamente: Lynch si circondava di musica che amava. E anche di musicisti che amava, come nella terza stagione di Twin Peaks – Il ritorno. Ogni puntata si chiude infatti con un’esibizione (completa!) di un artista sul palco del mitico Bang Bang. Qui la musica mi sembra davvero voler essere semplicemente un omaggio agli artisti che ama e a cui si sente affine, molti dei quali sono amici con cui aveva già collaborato in passato: dai Nine Inch Nails (il cui leader, Trent Reznor, ha prodotto la colonna sonora di Strade perdute) alla voce eterea di Sharon Van Etten, dal carismatico frontman dei Pearl Jam Eddie Vedder a Moby, di cui in precedenza Lynch aveva diretto il video di Shot in the Back of the Head. In Twin Peaks – Il ritorno avrebbe dovuto comparire anche David Bowie (che in in Fuoco cammina con me ha interpretato il misterioso agente Phillip Jeffries, e con la cui voce si apre Strade perdute): purtroppo non ne ha avuto il tempo. (Per chi ne volesse sapere di più sulla musica della terza stagione di Twin Peaks, qui c’è un bell’approfondimento, qui invece si può ascoltare la colonna sonora.) Ok, mi sembra che ci abbiamo girato attorno abbastanza. Di cosa stiamo parlando quando parliamo di Twin Peaks? So che la pensi come me: perché chiamarla serie tv è riduttivo?
Benvenuti a Twin Peaks
MC: All’epoca, Twin Peaks è stato come un virus. Un’invasione di ultracorpi perfettamente mimetizzati all’interno del paesaggio televisivo. O forse si potrebbe dire che, come il demone Bob abitava il corpo di insospettabili cittadini, Lynch è entrato nei salotti della middle class di tutto il mondo portando il caos. Il regista del Missoula aveva capito prima di chiunque altro che il mondo del cinema stava cambiando e che le storie sarebbero state fruite in modo diverso. Ma da persona profondamente ottimista e da esploratore qual era, il suo atteggiamento di fronte a questa rivoluzione non fu reazionario – atteggiamento in cui cadono molti registi oggi e a volte anch’io – ma di chi vuole comprendere le potenzialità del nuovo mezzo. Lynch amava montare e rimontare le cose, capirne il senso, per poi finalmente controllarle e farle esplodere dall’interno. È così che dà alla luce Twin Peaks insieme a Mark Frost: una bomba travestita da detective story. Chi ha ucciso Laura Palmer rimarrà sempre un dettaglio secondario nella ben più stimolante costruzione di un mondo labirintico in cui si resta invischiati come in una ragnatela. Anche per questo motivo gran parte della seconda stagione di Twin Peaks è da considerare apocrifa, in quanto il prodotto, tolto temporaneamente dalle mani di Lynch, diventa un’infinita soap opera piena di sottotrame leggere. Esattamente come accade a ogni successo seriale degli ultimi anni, anche all’epoca si cercò di sfruttare il successo, diluendo trama e contenuti per un tempo infinito. A risollevare la seconda stagione fu solo l’incredibile finale, in cui Lynch torna alla regia, spazza via tutto il ciarpame e ritrascina lo spettatore nella follia. In quell’ultimo episodio credo che risieda la chiave di Twin Peaks e del suo fascino longevo, che con la terza lisergica stagione sarà chiaro a tutti. Lynch non vuole creare una serie tv ma un intero universo, che ha bisogno di tempo e spazio per sedimentare nelle nostre menti. Nell’ultima stagione il mondo di Twin Peaks deflagra in mille storie, si aprono infiniti cassetti e non se ne chiude neanche uno, ma ne rimane intatta l’eco, per sempre, come l’urlo finale di Laura Palmer.
MT: Mi piace molto l’immagine del virus sguinzagliato nel palinsesto televisivo. Twin Peaks, tra l’altro, mi permette di sfiorare un tema a cui, da persona che lavora con le storie e per le storie, tengo molto: quello della libertà creativa nei confronti delle aspettative del pubblico. Quando nella primavera del 1992, poco meno di un anno dopo la chiusura della serie, venne presentato al Festival di Cannes Fuoco cammina con me, molti ne furono delusi, critica e semplici spettatori indistintamente. Fin da quando si era sparsa la voce che Lynch si era messo al lavoro su un prequel di Twin Peaks, tutti – anche giustamente, sia chiaro – si attendevano che quel film fosse effettivamente un prequel, che quindi fornisse almeno qualche risposta alle infinite strade lasciate aperte al termine della seconda stagione e che, soprattutto, ricalcasse toni e atmosfere della serie. Fuoco cammina con me, invece, è per molti versi più vicino a Velluto blu che a Twin Peaks – ma qui il tema del male viene portato a conseguenze ancora più estreme: non ci sono Laura Dern e promesse di salvezza, e al posto dell’happy end c’è una delle sequenze più orrorifiche di tutta la produzione lynchiana.
L’intensità di Fuoco cammina con me, se si escludono i venti, venticinque minuti iniziali è sempre altissima, a tratti insostenibile. Niente a che vedere, insomma, con il corteo di personaggi stralunati e con i momenti di alleggerimento ironico di Twin Peaks, momenti che hanno contribuito tantissimo al suo successo e che in molti volevano ritrovare nel film. Quanto alla risposta alle questioni lasciate aperte dalla serie, be’, qualcosa c’è: lo spettatore, seguendo gli ultimi giorni di vita di Laura Palmer da vicinissimo, scopre come è stato effettuato l’omicidio e perché (l’identità del killer, invece, la sapevamo già). Allo stesso tempo, però, Lynch apre innumerevoli altri interrogativi che, all’epoca dell’uscita, furono salutati come inutili complicazioni, manierismi. E che invece per Lynch erano tasselli fondanti del suo mondo narrativo: tutti noi l’abbiamo capito solo venticinque anni più tardi, quando con Twin Peaks – Il ritorno siamo finalmente giunti alla consapevolezza che il focus della storia che aveva in mente non era la cittadina di Twin Peaks e i suoi torbidi misteri, mentre la loggia nera, Bob e i demoni erano sapienti coup-de-théâtre; era tutto il contrario. C’è stato un momento preciso in cui ne abbiamo preso consapevolezza: l’incredibile episodio 8 dell’ultima stagione, vera e propria cosmogonia dell’universo Twin Peaks e forse anche dell’intero impianto narrativo lynchiano.
Bombe atomiche
MC: Come dimenticare quella visione. Per me – e penso anche per te – c’è un prima e un dopo l’episodio 8 nella serialità televisiva. Ricordi quando andò in onda nel 2017? L’urgenza di parlarne era talmente grande che ne scrivemmo un pezzo di getto, in forma di dialogo. Come del resto stiamo facendo adesso. È stato come aver assistito a un fenomeno naturale fuori scala, qualcosa di spaventoso nel senso romantico del termine. E quello che mi fece impazzire fu la scelta di Lynch di inserire questa esplosione atomica in un momento imprecisato della stagione, senza aver dato alcun preavviso o anticipazione nell’episodio precedente. Una qualunque serie odierna avrebbe preparato lo spettatore con mille espedienti; sono le stesse piattaforme, del resto, che esigono un ben pianificato momento what the fuck, nell’ottica di monetizzare l’attenzione fino all’ultimo centesimo. Invece Lynch ci insegna che il sublime giunge in un momento qualsiasi, ci educa alla pazienza e all’osservazione di ogni dettaglio. L’episodio 8 stesso inizia senza particolari avvisaglie, in qualche modo è solo l’ingresso dei Nine Inch Nails e il loro brano She’s Gone Away (chiaro riferimento a Laura Palmer) a introdurci al culto misterico. Tutto quello che accade successivamente è una sorta di Libro della Genesi in cui Lynch espone la sua mitopoiesi. Lo sguardo si allarga a dismisura, il piano della narrazione si fa mistico, senza però che Lynch perda un centimetro del controllo sulla narrazione. Un vero miracolo. È solo in questo episodio che Lynch decide di inserire una data specifica, quindi di collocare i fatti in un determinato momento storico. Il primo test atomico è per il regista la nascita del male, ovvero la fine dell’equilibrio dell’uomo con la natura. Con la sequenza del fungo atomico in un bianco e nero fosforescente, ha saputo sintetizzare l’orrore di quella scoperta mortale, come Christopher Nolan non è riuscito a fare nemmeno in tre ore di film.
MT: Aggiungo solo una cosa: sarebbe stato semplicissimo per Lynch costruire Twin Peaks – Il ritorno premendo l’acceleratore sulla nostalgia, quel sentimento che molti considerano come il vero segno distintivo della nostra epoca e che infatti tanto il cinema quanto le piattaforme stavano sfruttando a fondo, in una continua proliferazione di remake, reboot, o prodotti originali ambientati in un passato immediatamente riconoscibile (vedi alla voce Stranger Things). Gli ingredienti c’erano tutti: un’estetica profondamente anni Novanta, un universo narrativo che ha fatto epoca, l’alone del mito vivente che ammantava lo stesso Lynch… Invece, di nuovo, con la terza stagione di Twin Peaks abbiamo assistito a un’enorme affermazione di libertà creativa. Ma se con Inland Empire questa libertà si era fatta persino eccessiva, e aveva portato a un’opera visivamente splendida ma prolissa e con grandi rischi di incomunicabilità (so che io e te non siamo del tutto d’accordo su questo), con Twin Peaks – Il ritorno, Lynch è anarchico al cento per cento senza però mai dimenticare le aspettative del pubblico. Ci fa sprofondare in un universo assurdo e per certi versi folle, in cui tutte le regole vengono di volta in volta disattese, ma lo fa accompagnandoci per mano come un fratello maggiore. È anche per questo che considero Twin Peaks – Il ritorno il testamento di David Lynch. Non per forza la sua opera migliore (per me rimane Mulholland Drive), ma di certo quella in cui la simbiosi tra l’artista e i suoi adepti è stata più profonda e felice. D’altra parte, Laura Palmer all’inizio degli anni Novanta aveva sussurrato all’agente Cooper: “Ci vediamo tra venticinque anni”, e venticinque anni dopo, effettivamente, si sono rivisti. In quanti altri casi è accaduta una così profonda compenetrazione tra tempo interno e tempo esterno, tra opera e vita?
The Art Life
MC: Penso sia davvero un caso unico. L’unico parallelismo che mi viene in mente è quello con Fellini – di cui Lynch tra l’altro era grande fan. Il ritorno ciclico di una serie di elementi visivi, la capacità di riutilizzo infinito del medesimo immaginario lungo tutta una filmografia, senza mai sembrare ridondante; ecco, forse il regista italiano è l’unico ad avvicinarsi a una simile unità artistica. Per entrambi è stato coniato un aggettivo ad hoc, indice dell’estrema riconoscibilità del loro stile. Ma di certo il rigore con cui Lynch ha saputo tenere fede a sé stesso e alla sua creatività in tutti questi anni non ha eguali. Già all’interno del suo primo lungometraggio, Eraserhead, si intravedono temi portanti che rivedremo in Twin Peaks, come la lotta tra il bene e il male (l’uomo sfigurato e la donna nel termosifone sono forze sovrannaturali che si contendono il destino del protagonista) e la compresenza di più dimensioni. Nel successivo The Elephant Man – il suo lavoro dall’impianto più tradizionale insieme a Una Storia Vera – si concede nel finale un respiro più ampio, quasi cosmico, citando un commovente verso del poeta Alfred Lord Tennyson: “Mai, mai, niente morirà mai”. Esattamente come il mondo di Lynch, inesauribile e profondamente vitale.
MT: E così abbiamo anche toccato i primi due film di Lynch. A questo punto, credo di avere giusto un’ultimissima domanda per te. Io ho già rivelato qual è la mia opera preferita; e la tua qual è, Massimo?
MC: La folgorazione per Lynch è arrivata anche per me con quel capolavoro che è Mulholland Drive. Difficile dire ora quale sia il mio preferito, ogni suo film contiene almeno una sequenza memorabile. Ma se devo stare al gioco, confesso che al momento sono particolarmente affezionato alla sua opera più divertente e cafona, quel Cuore Selvaggio con Nicholas Cage, Laura Dern e il Willem Defoe più cattivo e disturbante mai visto sullo schermo. È qui del resto che si trova la sequenza più inaspettata di sempre: l’apparizione della strega buona Glinda in una bolla luminosa, con il volto di Laura Palmer: “Don’t turn away from love, Sailor”.
L’immagine di copertina è del nostro Massimo Cotugno