È per movimenti circolari che procede la meditazione. Si parte dall’io, lo si prova a negare o superare, ma poi sempre all’io in qualche modo si torna, arricchiti nella vita quotidiana dalla relativizzazione dell’esperienza del sé. Immaginate di applicare questa ciclicità alla Terra tutta, più che all’ego individuale, e avrete un’idea di massima di cos’è Orbital di Samantha Harvey: libro vincitore del Booker Prize 2024, tradotto in italiano da Gioia Guerzoni per NNE. Una prosa poetica che dalla Terra parte e alla Terra torna, ruotandole intorno al ritmo di sedici orbite compiute da due astronaute, due astronauti e due cosmonauti che, riuniti nella stessa stazione spaziale internazionale, non smettono di interrogarsi sul pianeta che hanno di fronte – e, quindi, sui propri destini. Anche in lontananza, anche dallo spazio, la Terra è sempre presente a sé stessa, attraverso sei cervelli e dodici occhi che la mano sapiente dell’autrice inglese rende reciprocamente interconnessi.
Le distinzioni lessicali da guerra fredda (astronauti vs. cosmonauti), attualizzate dalla guerra nemmeno più così fredda in corso negli ultimi anni, vengono infatti mantenute ma al tempo stesso sovvertite. Nella compagnia forzata imposta dalla missione spaziale – compagnia che è in fondo una solitudine irriducibile – viene a crearsi una «famiglia per aria» (p. 25) in cui la condivisione è, più che auspicata a livello etico-razionale, praticamente esperita:
Tutto quello che abbiamo lo riutilizziamo e lo condividiamo. Non possiamo dividerci, questa è la verità. E non succederà perché non può essere. Beviamo la nostra urina riciclata. Respiriamo la stessa aria riciclata (p. 80).
Nella versione originale, le ultime due frasi sono marcate da un each other battente che evidenzia con efficacia la reciprocità di questa condizione: «We drink each other’s recycled urine. We breath each other’s recycled air». Ma in fondo questo riciclo non caratterizza la vita umana anche sul livello del mare? Non siamo tutti sostenuti da un continuo scambio organico, immersi nell’atmosfera come pesci nell’acqua, e come i pesci di Foster Wallace troppo spesso ignari di esserlo? Il libro di Samantha Harvey, come fa l’arte di qualità, invita a riattivare questa consapevolezza, sintetizzando in uno spazio e in un tempo limitati alcuni aspetti della vita umana tutta, che dalla sintesi risultano enfatizzati. La precarietà della navicella diventa così epitome della caducità delle macchine corporee. Il movimento a vuoto intorno alla Terra, senza una meta specifica che non sia la prosecuzione del movimento stesso, è allegoria della traiettoria umana, per la quale non conta, o forse non c’è, una destinazione singola, all’infuori delle minuscole destinazioni quotidiane che sole le danno senso.
E allora si comprende come mai i personaggi in orbita abbiano la sensazione ricorrente di compiere azioni banali, pur abitando l’eccezione per eccellenza: il motivo è che qualsiasi occupazione o attività è fatta di momenti più piccoli che, scorporati, possono risultare noiosi e ripetitivi. Allo stesso modo, potrebbe sembrare banale suonare uno strumento per ore, allenarsi in una palestra a giorni alterni, leggere ogni sera, cucinare ogni giorno. Potrebbe sembrarlo persino fare ricerca nello spazio. Ma è nello stimolo iniziale, nell’entusiasmo del come che assume senso il cosa. E si badi che in questa visione, apparentemente banale a sua volta, risiede un sovvertimento radicale della retorica del risultato, della competizione, della vittoria. Gli stessi protagonisti del libro sanno che le proprie esperienze in orbita non sono che «un ammasso di dati, fondamentalmente. Un mezzo e non un fine» (p. 120). Non c’è scopo finale a dar senso alle esistenze dei singoli, nello spazio come sulla Terra, forse perché non esiste ontologicamente uno scopo finale in sé. Esiste invece qualcosa come l’entusiasmo, la passione, la scelta degli individui, che assume senso in una condivisione dei traguardi che trascenda la dimensione dell’uno. È per questo che, nonostante la logistica di una stazione spaziale divisa tra Russia da un lato e Stati Uniti, Regno Unito, Italia e Giappone dall’altro, i personaggi del libro finiscono per contraddire gli «editti» (p. 79) che vorrebbero il cibo, i bagni, e le cyclette ben separati tra i due gruppi. Il loro stesso osservare il pianeta che fiancheggiano illumina l’impossibilità di riconoscere i confini politici da cui la Terra è attanagliata, e che sulla Terra sembrano ineludibili.
In una discussione su Dio, la questione del come che dà senso al cosa prende forma attraverso una divergenza di opinioni che si fa progressiva identità:
Ogni tanto Nell vorrebbe chiedere a Shaun come fa a essere un astronauta e credere in Dio, un Dio creazionista, ma sa già quale sarebbe la sua risposta. Le chiederebbe come fa a essere un’astronauta e non credere in Dio. E sarebbero a un punto morto. Lei indicherebbe le finestre di sinistra e di dritta, dove l’oscurità è infinita e feroce, dove i sistemi solari e le galassie sono violentemente dispersi, dove il campo visivo è così profondo e multidimensionale che si può quasi vedere la curvatura dello spaziotempo. Guarda, direbbe. Cosa può essere stato se non una forza sfrenata, disattenta e bellissima?
E Shaun le indicherebbe le stesse finestre dove l’oscurità è infinita e feroce e dove gli stessi sistemi solari e le galassie sono violentemente dispersi e lo stesso campo visivo è così profondo e multidimensionale che si può quasi vedere la curvatura dello spaziotempo e direbbe: cosa può essere stato se non una forza sfrenata, attenta e bellissima? (p. 58)
Dietro a entrambe le voci sembra di percepire, calma e conciliante, quella dell’autrice: il suo elegante riserbo, il modo raffinato con cui invita a superare la differenza apparentemente inconciliabile tra le due posizioni, e riconoscere una forma di attenzione, di cura, tanto in un mondo senza Dio quanto in uno percepito come etero-diretto. Una cura, vale a dire, di cui ciascuno di noi può essere agente, e di cui un certo tipo di arte si fa portatrice in modo particolare.
Se la mente umana è un meccanismo prodotto dalla natura (o da Dio?) per riflettere sé e su di sé, il pensiero da questa mente generato è andato nel tempo complicandosi al punto da permettere una visione d’insieme della natura stessa, divina o meno che la si riconosca – visione di cui Orbital rappresenta un esempio tra i più riusciti. E, come si legge in un passaggio del libro, è proprio grazie alla ciclicità che può darsi la complicazione, in un moto ricorsivo e più raffinato ad ogni giro:
Pensa un pensiero nuovo, si dicono a volte. I pensieri che si hanno in orbita sono così grandiosi e così vecchi. Pensane uno nuovo, completamente nuovo, mai pensato prima.
Ma non esistono pensieri nuovi, sono solo pensieri vecchi che nascono in momenti nuovi, e in quei momenti arriva il pensiero: senza la Terra siamo finiti. Non potremmo sopravvivere un secondo senza la sua grazia, siamo tutti marinai su una nave in un mare scuro, profondo, impenetrabile (p. 16).
«Repetition is a form of change», diceva Brian Eno – verità applicabile all’evoluzione dell’arte e del pensiero in generale, e tanto più vera nel caso di un’opera informata di ciclicità come quella di Harvey.
Nell’unione bilanciata tra macro e micro, cosmo e navicella, spazio incommensurabile e claustrofobico, Orbital offre una soluzione elegante al problema posto da tanta critica ecologica – e dai detrattori della stessa: ossia l’apparente impossibilità di pensare il cambiamento climatico su scala globale. Se troppo spesso ci si è arresi di fronte alla presunta imponderabilità di fenomeni complessi attinenti al mondo tutto, Harvey è qui a ricordare che una soluzione possibile è, come sempre, nel pensiero dialettico ben ponderato. È vero: il clima che cambia è un “iper-oggetto” che scappa da tutte le parti, per usare la definizione di Timothy Morton. Ma è a sua volta un “iper-oggetto” anche la mente umana, che non può fermarsi dal pensare la complessità in cui è calata, e di cui è espressione.
In un libro dall’atmosfera sospesa, in cui le riflessioni poetico-filosofiche dei personaggi galleggiano tra le pagine come i loro corpi fanno negli ambienti della stazione spaziale, il moto circolare delle orbite informa il procedere dei pensieri stessi. Si potrebbe quindi leggere Orbital come un manifesto della e sulla dialettica – quella sana e produttiva, che non trova alcuna conclusione definitiva ma trasforma ogni sintesi in una nuova tesi. Una dialettica che coinvolge conoscenza e umiltà, velocità e stasi, distanza e vicinanza, crescita e decomposizione, alto e basso e, soprattutto, centro e periferia:
Non è periferica [la Terra] e non è il centro; non è tutto e non è niente, ma sembra molto più di qualcosa. […] Questa cosa ospita noi umani, tutti presi a lucidare le lenti sempre più grandi dei nostri telescopi, che ci ricordano quanto siamo sempre più piccoli. E noi restiamo lì a bocca aperta. E con il tempo arriviamo a capire che non solo siamo ai margini dell’universo, ma che è un universo di margini, che non c’è un centro, solo un ammasso vertiginoso di cose danzanti (pp. 38–39).
Se l’universo non ha un centro, tanto più vera sarà questa prospettiva se applicata alla Terra. Ed ecco quindi che anche Est e Ovest possono mescolarsi, nei riferimenti sottili o meno a Sputnik («Galleggiano davanti a un film russo su due cosmonauti che vengono posseduti dagli alieni mentre rientrano sulla Terra»; p. 137), Las Meninas (dipinto a cui sono dedicate pagine di grande intensità) e Space Oddity («a tin can in a vacuum», nell’edizione originale). Ma anche probabilmente alle Note del guanciale di Sei Shōnagon, classico della letteratura giapponese in cui ricorrono liste di preferenze personali di ogni tipo: come l’autrice e cortigiana del periodo Heian, l’astronauta giapponese Chie concentra le proprie percezioni in elenchi di «cose irritanti», «cose rassicuranti» (p. 44), «cose sorprendenti» (p. 73), «cose snervanti» (p. 121), «cose prevedibili», o meglio attese con impazienza (p. 147).
In cima alla lista, tra le cose rassicuranti, prima delle «tazze con i manici robusti», degli «alberi» e delle «scalinate ampie», c’è proprio «la Terra là fuori» (p. 44). Se il concetto di giorno è relativizzato, in quella «day-less freak zone» in cui i tramonti e le albe si succedono a distanza ravvicinata, quel che rimane stabile è la sfera schiacciata su cui si muovono tifoni, si creano nuvole e si accendono luci quando si fa buio – unico segnale percepibile dallo spazio della presenza di una forma di vita complessa. La Terra è rassicurante nella sua leopardiana «vuota indifferenza» (p. 86), nel suo continuare a girare nonostante tutto, nonostante tutti: «Se esistono chissà quanti sistemi solari come il nostro, con chissà quanti pianeti, almeno uno di questi sarà sicuramente abitato, e la compagnia è la migliore consolazione per la nostra banalità» (p. 39). Eppure una distinzione va fatta, sembra dire Harvey: che si accetti pure la banalità come rassicurazione, ma che non ci si lasci assuefare dal miracolo di un tramonto del Sole sull’Artico. Che si tenga a mente, insomma, che l’essere umano è un «animale che non si limita a essere testimone, ma è innamorato di quello che vede» (p. 46).
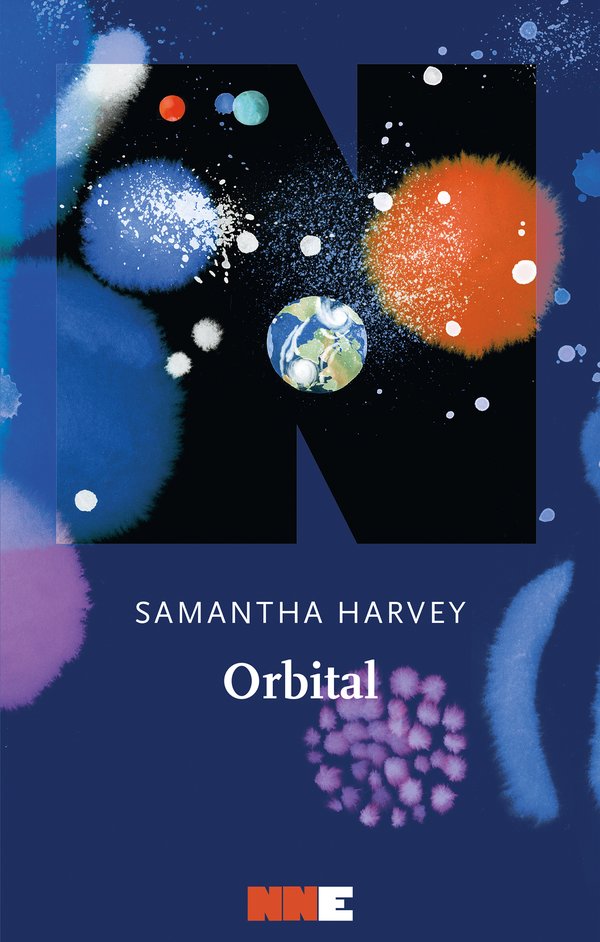
Samantha Harvey, Orbital, traduzione di Gioia Guerzoni, Milano, NNE 2025, € 18, 176 pp.