Vi è qualcosa nella mano dell’artista capace di rappresentare il reale come una creatura esotica, vergine, luminosa e illuminante agli occhi del mondo; la maestria risiede nel rendere il consueto degno ancora una volta di generare stupore, quasi fosse un segreto rimasto a lungo inconfessato: si potrebbe intendere quindi l’opera d’arte come un’iniziazione alla realtà, come il risveglio del desiderio – del bisogno – di scoprire, di possedere, di appropriarsi della luce. Se si dà per vero quanto sosteneva Picasso, ovvero che «l’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni», allora Pier Paolo Di Mino è un grande artista del nostro tempo. Lo splendore. L’infanzia di Hans – uscito per Laurana lo scorso 5 aprile nella collana Fremen e impreziosito dalle illustrazioni in copertina di Veronica Leffe – è la sua opera d’arte:
«C’è una vita più vera di quella che viviamo nel chiuso di noi stessi, di ciò che vogliamo, del mio e del tuo. C’è una vita che, tremenda e meravigliosa, piena di splendore, noi abbiamo il dovere di difendere.» (p. 186)
Tremendo e meraviglioso è il primo capitolo – il primo di un ciclo che prevede quattro, sei, sette volumi: rimane uno degli affascinanti misteri attorno al progetto di Di Mino – dedicato all’infanzia di Hans Dorè: nato dal grembo di Rosa nel 1911 nei pressi di Berlino, il giovane porta sulle spalle la responsabilità di essere lo tzadik, il «vero re» destinato a salvare il mondo dall’ingranaggio della modernità, dalla «macchina sorda e cieca che stritola e consuma le loro carni, e che si chiama necessità» (p. 298), riconnettendo l’umanità al divino che la abita.
A quell’infanzia che dà il sottotitolo a Lo splendore, però, Di Mino concede una manciata di pagine nel primo e nell’ultimo capitolo del libro che, di pagine, ne ha quasi settecento; a dare forma alla narrazione dell’opera, infatti, è il racconto delle vite che hanno preceduto la nascita del fanciullo. A partire dall’esistenza della candida Clea, levatrice del bambino, ci si avventura a ritroso nell’affollata genealogia di Hans. Ciascun personaggio, con il proprio intervento minimo o ingente, si rivela indispensabile per la sorte del «vero re» e del futuro che da lui dipende: Hermine, guaritrice in contatto con entità celesti che vaga tra i mercati della Germania di metà Ottocento credendo che «il meglio della vita è inventare e ascoltare storie» (p. 109); Gustav, marito di Clea, uomo folle e diabolico, magnaccia e assassino, vecchio soldato, segnato dall’amore omosessuale per Gérard de Nerval e dal dialogo delirante con Sara, moglie del biblico Abramo; Joseph Idel, figlio di Clea e patrigno di Hans, macellaio e socialista vero, convinto che «soffrire voleva dire anche una cosa simile a sognare» (p. 34); e poi Albertine e Franz, Hubel e Ginzburg, il prete Kircher. Nella loro diversità sono tutte figure necessarie, accomunate dalla comparsa nelle loro vite delle pagine, imperscrutabili seppur onnipotenti, del Libro azzurro:
«Questo libro […] non esiste e non lo ha scritto nessuno. […] La maggior parte delle persone non vede altro. A me non è mai capitato di aprirlo senza vederci una cosa diversa. C’è tutto il mondo. Ecco, le nostre vite sono una storia, una storia fatta di parole. Invece in questo libro io vedo immagini; immagini che sono simboli, e ci fanno capire le parole che compongono la nostra vita. Questo libro è lo specchio del libro che viviamo e le cui parole seguiamo passo dopo passo.» (pp 541-542)
Ora, in questo viluppo di personaggi gremito ma fluido, dinamico come l’entrelacement ariostesco, sorge naturale porsi una domanda: cosa rende Lo splendore capace di scuotere «dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni»? Cosa fa di questo romanzo – anche se in questo caso “romanzo” sembra imporre i limiti dell’etichetta – un prodotto letterario spiritualmente “splendido”?
Per rispondere, ancora una volta si fa riferimento all’animo dell’artista: ciò che distingue il talento dalla tecnica è la capacità di vedere. D’altronde, come lo stesso autore ricorda a più riprese, «sacro è vedere» (p. 454). Di fronte alla penna di Di Mino la pienezza della realtà – materiale, esperienziale, morale – sembra mostrarsi nella sua autenticità; pare raccogliersi per condensarsi non tanto in una risposta, in una soluzione, quanto nella meraviglia perturbante di una domanda.
«[…] farci senza sosta le domande. Domande l’una appresso all’altra, ognuna che sbuca dall’altra. Quel labirinto. Quella ragna. A costo di impazzire. […] È a forza di farti le domande, come fa Hans, che finisci per pensare che tutto si riduce a quell’unica domanda triste e paurosa: a che serve la vita? Può sembrare tremendo il fatto di pensare senza sosta alle domande. Lo è. Però è importante. È come imparare la grammatica a scuola. Anzi, è di più. Con questa grammatica, che si impara con tanto dolore, si può cominciare a parlare concretamente della vita. Ti si sviluppa l’animo superiore.» (p. 49).
In queste pagine che spolverano una tradizione letteraria imponente – da Proust a Hesse, da Joyce a Cervantes, con un forte richiamo ai testi biblici – c’è semplicemente tutto: il comico e la perdita, la ragione e il sentimento, la maternità e lo stupro, il denaro e la saggezza, il cielo e la terra, la parola e la guerra, il potere e la devozione. Lo splendore – con i suoi registri differenti, con i suoi narratori che cambiano e si alternano, con questa sua scrittura che tanto sembra imitare la molteplicità del mondo – pone l’uomo di fronte all’umano, non con presunzione, ma con la genuinità di un bambino ancora incontaminato dalle «sciocchezze che ci diciamo e raccontiamo, [da]lle storie orribili e vergognose che ci inventiamo e che usiamo per fare, del paradiso in cui ci ha messo Dio, un inferno» (p. 231). Il romanzo si cala nel tempo per superarlo: se da un lato la vicenda è ambientata nell’Ottocento, dall’altro Di Mino trascende i secoli, ricollegando ciascuna storia alla radice più antica dell’esistenza umana: «una rete, una grande trama sottile e nascosta, fortissima, che lega tutto» (p. 505); l’autore riesce a parlare di tutte le epoche perché ciascuna è stata colonizzata del bisogno accentratore e capitalistico dell’uomo:
«La civiltà è un vizio. Il vizio che ci abbrutisce e stordisce, che ci ottunde e anestetizza, così da renderci ciechi davanti al fatto che siamo solo carne da triturare nell’inarrestabile processo industriale della macchina della necessità. La Bibbia dice che Dio ha fatto la civiltà sterminando gli uomini belli e felici. La civiltà nasce dalla distruzione totale, che coincide con lo sterminio della bellezza. La bellezza è un pieno, e, quando la civiltà vince, vince il vuoto. Dio ci ha creato dal vuoto. Veniamo dal vuoto. Torniamo nel vuoto. Ergo siamo vuoto. La nostra vita è vuota. L’oppio, appunto, è il vuoto. Ci educa a non pensare, e ad agire in maniera efficiente e pratica e macchinale. Cioè ci educa a essere vuoto. Delle vuotità votate al vuoto.» (p. 474)
I personaggi di Di Mino dialogano con il vero lettore ideale: qualsiasi persona in quanto essere umano. Ecco allora che assieme a Clea si riscopre quella fede che «è come un gatto che cammina di notte e va verso il giorno. E il gatto è furbo. La fede serve a riconoscere i segni, a collegare tutto e vedere il significato della vita» (p. 96); con Gustav si comprende come il gravame dell’esistenza pieghi ciò che è buono a ciò che è bene, come l’etica perda di sostanza se vessata dalla sofferenza: «Il tuo dolore è come qualcuno che ti parla per darti un buon consiglio, ma tu non lo capisci. Il tuo dolore dice: sei stanco di accontentarti. Il tuo dolore dice: è giunto il momento di fare di più per ottenere di più» (p. 439). Insieme a Hermine si svela il racconto – inventato o ascoltato chissà – della morte: «[…] dopo che la morte ti entra nella vita, sei diventato grande, e certe cose non le puoi più credere vere. Cominci a capire la vita, anzi, ti viene il fiuto per la vita, ma succede perché ti viene il naso per la morte» (p. 118). Insomma, in queste pagine c’è la vita tutta: la povertà e la sensibilità, la pretesa e la malattia, chi muore e chi uccide, la voglia di casa, i gelosi e i martiri, la gente che non capisce o che non è pronta a capire, le premesse e i fini, le trappole per i sognatori e l’utilità di Dio, l’intelligenza delle persone tristi e la verità dei sentimenti. Di Mino paragona l’esistenza alla voce di una donna, meravigliosa e capace di riportare splendore in ogni cosa; una voce che chiede solo di essere ascoltata; e attraverso la sua prosa – che in sé raccoglie il canto popolare, la poesia, la preghiera – proprio di fronte a quella vita ci si sente riposizionati: perché se è vero che «attraversiamo il mondo senza vederlo» (p. 113), lo è altrettanto che, grazie alla parola, scopriamo che quel mondo «ti insegna tutto quello che c’è da sapere» (p. 113).
Schopenhauer sosteneva che la filosofia è un’arte, non una scienza; è qui, nei risvolti filosofici del testo, che Di Mino si conferma ancora una volta un artista. Le sue pagine potrebbero sembrare «fisime spirituali e ipocondrie filosofiche» (p. 530), ma se effettivamente c’è della filosofia ne Lo splendore non è quella, come si è detto, tarpante della risposta, ma quella rivoluzionaria della domanda, d’altronde – e questo lo sosteneva Kundera – «la stupidità deriva dall’avere una risposta per ogni cosa. La saggezza deriva dall’avere, per ogni cosa, una domanda». La vera filosofia – come sottolinea l’autore – è in grado di confonderti il cuore; abbandona l’intento di offrire una soluzione certa nella speranza di innestare in qualsiasi considerazione del reale una dimensione di dubbio, di incertezza. L’arte delle parole Di Mino il dubbio nel lettore lo innesta eccome: tra il conforto di una risata e il sollievo del pianto, l’animo viene sconquassato, invitato a valutare l’equivoco del mondo: un luogo ambiguo e indefinibile, eppure pieno di luce.
Lo splendore assolve il compito della letteratura così come la intendeva Pavese: «una difesa contro le offese della vita». Descrivendo, raccontando, vedendo quelle offese, l’autore presenta con nuova luce la realtà nella quale il lettore è sempre esistito: una realtà spolverata, di nuovo stupefacente, ancora bramabile. Hans e i personaggi che l’hanno preceduto rispondono alla necessità di infinito dell’uomo, al bisogno di ciascuno di «riv[olere] le cose vere, le cose belle» (p. 69). Ed è proprio questo il primo romanzo di Pier Paolo Di Mino: una cosa bella; un oggetto estraneo alle consuetudini del mercato editoriale; un testo in grado di affinare nel lettore «il fiuto e lo sguardo sottile» (p. 184) nei confronti della vita, per ricordare a ciascuno di poter essere artista per sé stesso: «Camminare lentamente e guardare, osservare, sperando di vedere. Gli uomini non dovrebbero fare altro: guardare senza toccare» (p. 661); camminare nella realtà, accorgersi che «la vita è una cosa bella, anzi bellissima» (p. 47), e tornare a vedere come tutto sia pieno di splendore.
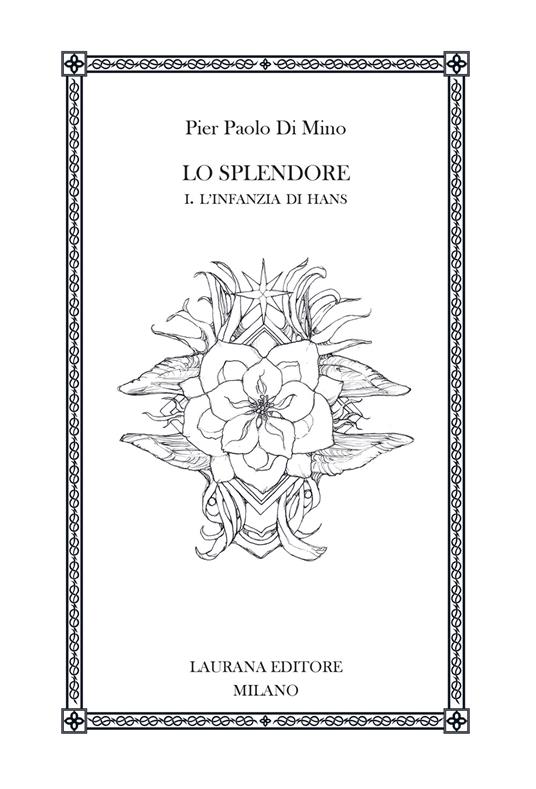
Pier Paolo Di Mino, Lo splendore. L’infanzia di Hans, Laurana, Milano, 2024, 22€, pp. 680.