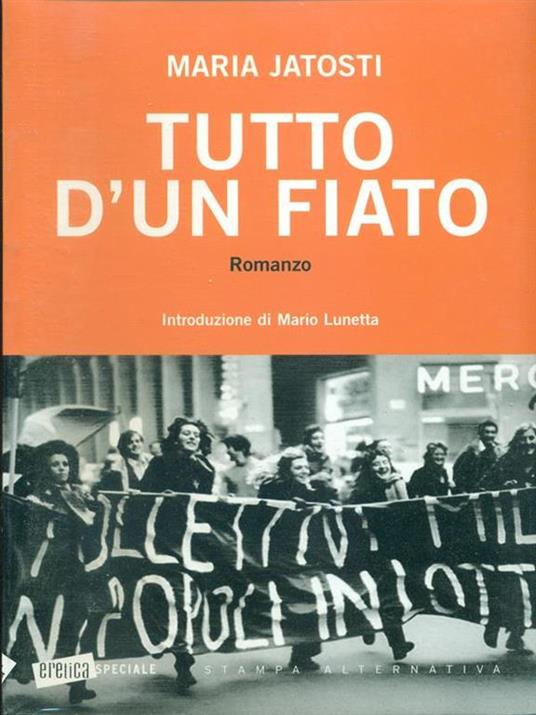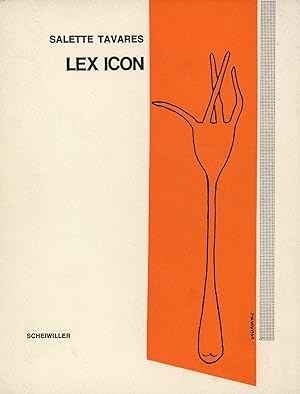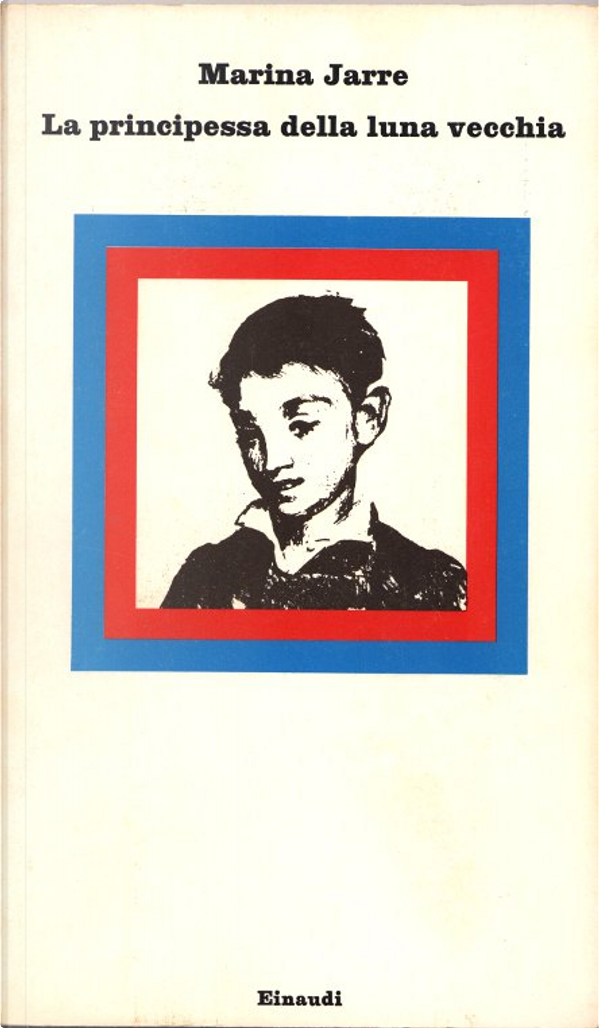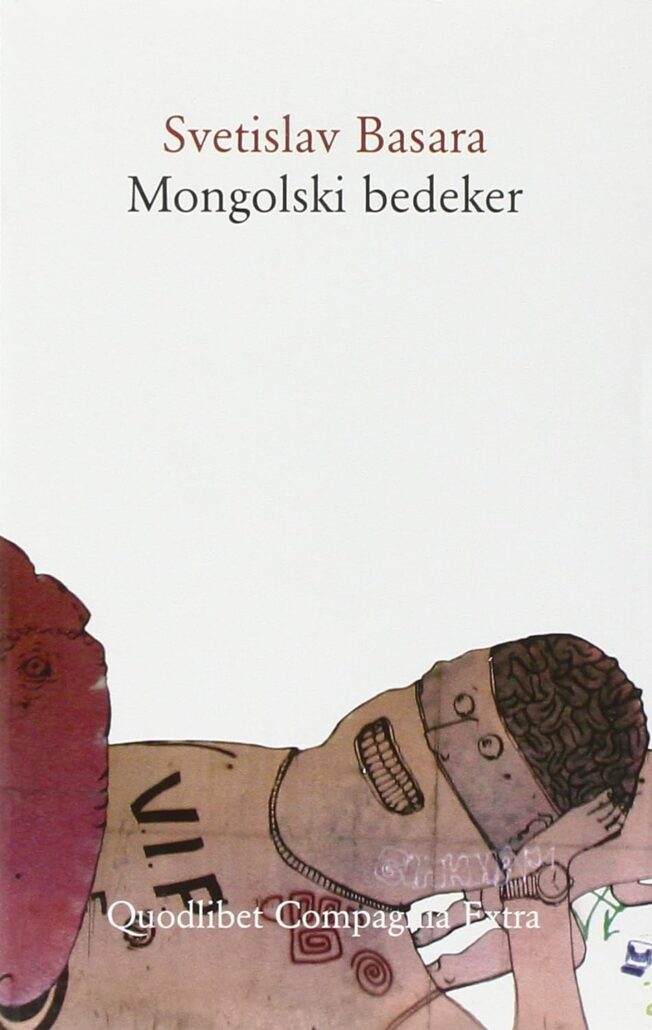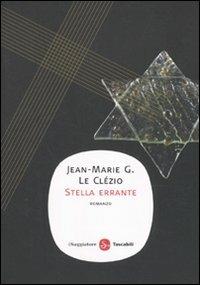Aria di primavera, aria di cassetti aperti e cambi di stagione. E, perché no, tempo di riorganizzare anche qualche scaffale. Prendendo respiro tra una scatola e l’altra, e liberandosi almeno per un po’ dai ritmi rutilanti delle novità editoriali, ecco alcuni libri da recuperare: titoli che hanno atteso anni sui vostri scaffali in attesa che li notaste, o che forse sarete curiosi di andare a cercare altrove, ora che si è liberato un po’ di spazio nella libreria appena spolverata. La Balena, anche in primavera, consiglia.
Maria Jatosti, Tutto d’un fiato (Editori Riuniti 1977; Stampa Alternativa 2012) [Anna Di Bernardo]
Tutto d’un fiato di Maria Jatosti è un libro autobiografico scritto d’un fiato che si fa leggere dimenticando quasi di respirare. «Un grande pezzo di vita» è la dedica dell’autrice scritta sulla mia copia, nella versione riedita da Stampa Alternativa nel 2012. Maria Jatosti è stata una donna coraggiosa che ha intrecciato la sua vita privata, fatta di relazioni, sentimenti vividi, lavoro e viaggi, alla storia italiana della seconda metà del Novecento, fra le speranze e le contraddizioni politiche che il Paese stava attraversando. Per un tratto del suo percorso è stata la compagna di Luciano Bianciardi, anarchico, talentuoso scrittore, uomo lungimirante nel prevedere, al pari di Pier Paolo Pasolini, le conseguenze del boom economico e dell’egemonia mediatica, «il veleno di allora», che avrebbe addomesticato gli animi degli Italiani. Il nome di Bianciardi non compare mai direttamente nel libro, mentre sono presenti altri nomi di personaggi letterari ben noti. Maria Jatosti osserva umilmente quel mondo di letterati ma ne emerge con decisione, con uno stile narrativo coinvolgente fatto di flussi e riflussi che scorrono fra gli avvenimenti vissuti e i ricordi che li precedono, così come scorrono i fiumi dei suoi percorsi: il Tevere, il Ticino, la Moscova, il Liffey, il Tamigi. La sua è una vita dalla parte dei più deboli, degli operai, contro le guerre, antifascista, colorata dall’amore per suo figlio Marcello. Una vita di cui una parte significativa è affidata alle parole, parlate e scritte. Quelle parole giocate così tanto insieme a «lui» e che a poco a poco scoloriranno, sbiadite dall’abuso dell’alcol dello scrittore grossetano.
Salette Tavares, Lex Icon (1971; traduzione italiana di A. Saletti, Scheiwiller 1977) [Marcello Sessa]
Quando alla metà del Novecento l’Europa era una spiaggia bagnata da nouvelles vagues culturali, in Portogallo si preparavano gli inneschi per le sperimentazioni espressive tra le più audaci del momento. Così Salette Tavares (scrittrice, artista, pensatrice), negli anni Cinquanta e grazie a una borsa di studio della Fundação Gulbenkian ottenuta una volta tradotte le Pensées di Blaise Pascal, ha viaggiato e studiato in Francia e in Italia, dove parecchi innamoramenti l’hanno smossa: l’estetica fenomenologica di Mikel Dufrenne e di Étienne Souriau, gli strali teorici di Gillo Dorfles e l’arte contemporanea. Rientrata in patria ha cominciato a elaborare un particolare tipo di scrittura “visuale”, che risente di tutto quanto aveva assorbito; ha messo a giorno le istanze della “corrispondenza delle le arti”, del concretismo ortodosso, della poesia visiva e persino della semiotica: le ha convocate – talvolta – sul supporto più frusto (la pagina bianca) e con gli strumenti più dépassés (i versi lineari). Le poesie che ha raccolto, per esempio, in Lex icon (1971), sono equiparabili a quelli che proprio Souriau ha chiamato “arabeschi”: composizioni che disturbano l’idea di melodia, chiara e intelligibile, poiché svincolate dalla rappresentazione della loro kantiana finalità formale. Tavares concede al carattere tipografico grazie inusitate; esso è indice di cose, grafo per lo sguardo, medium di significati plurimi, neuma di una partitura che si snoda oltre spartito: come «un’Alfa Romeo coupé decappottabile, di cui è molto fiera» lanciata nelle curve di Lisbona liberata dai Garofani, su cui Dorfles, nei suoi diari, fedelmente ricorda l’autrice.
Jamaica Kincaid, Un posto piccolo (1988; traduzione italiana di F. Cavagnoli, Adelphi 2000) [Claudia Dellacasa]
Antigua è un posto piccolo, lungo dodici miglia e largo nove. Un posto piccolo è un libro breve, di qualche decina di pagine. Eppure incontrando l’uno attraverso l’altro, il posto attraverso il libro, si fa esperienza in modo profondo e duraturo di cosa sia il colonialismo, quello britannico nelle isole caraibiche ma non solo, di cosa voglia dire per un luogo essere cannibalizzato, per una cultura essere deprezzata e, per una persona, crescere con la rabbia di aver capito tutto questo e non potere riscrivere la storia che a tutto questo ha portato. Chi legge si sente interpellato da Kincaid, dal «tu» battente che dalla prima riga in poi caratterizza questa requisitoria feroce e senza mezzi termini, dalla visione lucida di un sistema, quello imperialista su cui il capitalismo occidentale è fondato, in cui si è tutti coinvolti, volenti o nolenti. Ciascuna di noi potrebbe essere stata almeno una volta, o ha magari sognato di essere, la turista pronta a ignorare la realtà del paese in cui trascorre le proprie vacanze, il passato complicato di un paesaggio da cartolina a cui si è disposti a concedere solo un eterno presente posticcio. Soprattutto, ciascuna di noi usufruisce quotidianamente di un benessere dato per scontato, forse posticcio anche quello, eppure fondato su ineguaglianze sociali, economiche e ecologiche su scala locale e globale. Kincaid ci inchioda a queste consapevolezze, con una prosa affilata e un’implacabilità argomentativa che impediscono qualsiasi naiveté politica, tanto nelle scelte quotidiane (legate al viaggiare e al consumare) quanto in una visione complessiva del mondo di oggi alla luce di quello di ieri.
Marina Jarre, La principessa della luna vecchia (Einaudi 1977) [Stella Poli]
Marina Jarre è bravissima, ché non si capisce perché non la leggiamo tutti, ne parliamo sempre o la studiamo davvero. Mi ricorda, e secondo me c’entra con, un’altra scrittrice di purissimo talento: Natalia Ginzburg. Condividono Torino, l’Einaudi, il gusto per le focalizzazioni interne e ribassate – in questo caso Paolo, un ragazzino di undici anni –; la sintassi breve, piena di guizzi; le ambientazioni familiari, con trame di eventi apparentemente trascurabili, che, però, affrescano il momento storico con una icasticità che ti sembra di toccare. Marina Jarre ha una voce che si riconosce e si modula: è molto attenta alla spontaneità del parlato, alle inflessioni vagamente piemontesi, alle parole dei grandi orecchiate e glossate a spanne. Molta levità, molta maestria.
Svetislav Basara, Mongolski bedeker (1992; traduzione italiana di A. Parmeggiani, Quodlibet 2009) [Guido Casamichiela]
Mongolski Bedeker di Svetislav Basara doveva uscire nel 1992 a Sarajevo, ma Sarajevo nel 1992 era, appunto, Sarajevo nel 1992. Deve essere per questo, o forse no, non lo so, che Mongolski Bedeker è un libro pieno di ma. All’inizio c’è un pope trasparente e ci si può passare attraverso, ma non è trasparente sempre: dipende. Poi c’è una guida della Mongolia da scrivere, commissionata da un amico morto, ma non si tratta proprio di una guida, e chissà se l’amico morto è proprio morto. Dopo c’è uno psicanalista di nome Andreotti, ma non è uno psicanalista e non si chiama Andreotti. Alla fine c’è una bimba che vive dentro una finestra, ma la bimba non c’è, c’è solo la finestra. Leggete Mongolski Bedeker, leggetelo senza se. Ma con un sacco di ma.
Silvio d’Arzo, Fine di Mirco (Via del vento 2006) [Giulia Sarli]
Nel 1940 l’Italia entra in guerra, Ezio Comparoni ha vent’anni (non ne vivrà molti di più) e pubblica con lo pseudonimo di Silvio d’Arzo, in mesi diversi, due racconti in cui realismo e fantastico si intrecciano. Sono storie di angeli caduti che hanno perso per sempre l’altezza del cielo e scoprono la vita degli uomini attraverso gli elementi che più la rappresentano: gli oggetti quotidiani. Una storia così viene pubblicato sulla rivista «Quadrivio» il 4 febbraio 1940. È il racconto divertito del suicidio del professore di lettere Lidemo Gori, che sopravvive poiché, come un angelo dai capelli rossi rivela all’uomo dai vestiti pesanti d’acqua di fiume, a causa delle guerre la Morte è morta di fatica. Fine di Mirco esce su «Meridiano di Roma» il 23 giugno 1940. Mirco è un angelo che scende sulla terra perché vuole assistere a un concerto di ciechi ma un uomo lo chiama dentro a una stanza sporca in cui è radunato un gruppo di anarchici. Alle loro parole astratte, in cerca di rivoluzione, si oppongono la concretezza della candela, dalla luce ondeggiante, e le parole intime che Mirco ha sentito precedentemente per strada. Nel cappello del professor Gori che «galleggiava a fatica» sulla superficie del fiume, nella candela che «stava in fretta perdendo la sua linea snella e decisa» è la vita degli uomini, una cosa piccola e senza importanza, eppure così preziosa e calda, come una caldarrosta in tasca: «Create una notte lunga, senz’aurora, e metteteci un uomo solo, in riva a un mare vuoto del volo dei gabbiani: un uomo solo e senza tasche. Lo udrete piangere sconsolato». Il cielo di d’Arzo è vuoto e la luna ha forma di falce. Gli angeli diventano goffi e sono costretti a misurarsi con l’alito pesante di grappa degli uomini, con le loro facce comunissime e dai nomi ordinari, che d’Arzo scolpisce con una scrittura millimetrica e senza scampo.
Franco Fortini, Ventiquattro voci per un dizionario di lettere (Il saggiatore 1968) [Massimiliano Cappello]
Barthes diceva che la teoria è una specie di armatura. Non potendo andare incontro a tutti i testi, occorre fabbricarsene una per poi perfezionarla nella pratica a partire dagli scarti, le difformità tra la realtà e il modello. Che questo ottimismo della ragione conducesse dritto dritto al performance management, Barthes di certo lo ignorava. Che fosse proprio il pretendersi una scienza (falsificabile quanto si vuole ma sempre ripetibile) il punto cieco di ogni teoria, questo avrebbe dovuto saperlo. Contro questa filosofia della storia della letteratura, le Ventiquattro voci di Fortini ne propongono una filologia. La prima col suo metodo intende dirci “come funziona”, la seconda si limita a esporre “come sembra aver funzionato fino ad ora”. Fortini allude alla forma-abbecedario, luogo minimo per incontrarsi e per comprendersi. Non ha la pretesa di esaurirla perché intende “fare aria” attorno a chi legga o rilegga. A questa iterazione allude anche la “voce”. Il mondo è una foresta di simboli, certo. Li si può estaticamente contemplare nelle loro manifestazioni accidentali, sistematizzarli in forma di spettacolo; o forse adoperarli. Diranno: libro mai più ristampato ma facilmente reperibile (e ad un prezzo contenuto) nel mercato dell’usato. Risponderò: il problema non è la reperibilità ma la comprensibilità dell’operazione. Anche se domani uscisse la ristampa, resterebbe un libro impubblicabile oggigiorno. Cominciamo a chiederci perché. Poi un giorno parleremo del giardino dentro il quale siamo confinati a delibare frutti da narcosi come questo libro. Non ne usciamo, credo, fabbricandoci armature.
Georges Simenon, Le finestre di fronte (1933; traduzione italiana di P. Zallio Messori, Adelphi 1985) [Federica Arnoldi]
Georges Simenon scrisse Le finestre di fronte in seguito a un lungo soggiorno a più tappe in Unione Sovietica, come segnala la nota biografica inclusa nell’edizione Penguin del romanzo (The People Opposite). Era il 1933: sappiamo che da questa esperienza l’autore belga ricavò molte pagine (e fotografie), apparse in forma di reportage per la rivista francese Voilà e poi raccolte nel volume Europa 33. In effetti, Simenon non fu l’unico a vestire i panni del reporter nelle terre dell’ex impero zarista: prima di lui, negli anni Venti, Walter Benjamin e Joseph Roth si spinsero a Est per raccontarne le sorti dopo la Rivoluzione. Inoltre, è di recente pubblicazione in Italia il saggio La nuova Russia, in cui I. J. Singer raccolse nel 1928 le sue corrispondenze. Dalla Polonia fino alla Turchia, dopo avere viaggiato attraverso la vasta geografia delle repubbliche federate, Simenon sostò a Odessa e a Batum, sulla costa orientale del Mar Nero, durante gli anni dell’involuzione dispotica e repressiva della nuova realtà sovietica. Il romanzo Le finestre di fronte è ambientato proprio a Batum, che agli occhi di Adil bey, il
protagonista, appare una città reticente e fantasmatica. Il vuoto regna lungo le vie del porto che l’uomo percorre con tutti i sensi all’erta, assediato dal timore dello sguardo altrui, sempre indagatore; è il nuovo console turco, che sostituisce il precedente, morto in circostanze non sufficientemente chiarite. Per difendersi dalla diffusa ostilità nei suoi confronti, Adil bey sviluppa presto il senso della solitudine: «Non era stato difficile. Ci si arrivava da sé. […] Era una nube protettiva nella quale si camminava, il volto chiuso». Ma la sua incolumità e i valori cui si aggrappa con ostinazione cercando indizi sui
meccanismi di una società impermeabile alla sua lettura («Oserebbe negare che quella gente
muore di fame?») sono messi a repentaglio da una donna. Sonia è il concentrato umano delle
cose che non si lasciano decifrare: «Sonia era appunto l’incarnazione stessa della città. Fredda e misteriosa come lei. Accettava le sue carezze, così come la folla gli permetteva di passeggiare, la sera, dalla statua di Lenin alla raffineria». Tutto è fame, freddo e diffidenza. La trama amorosa si nutre del paradigma indiziario: l’innamoramento di Adil bey coincide con il deteriorarsi delle sue condizioni psicofisiche mentre il sospetto nei confronti dell’amante intorbida lo sguardo che intanto si affina,
febbrile. L’intensità e il ritmo del narrato aumentano quando Adil bey – il forestiero, l’ospite ingrato – transita dal presentimento della delazione all’assillo della gelosia, con la sua logica
proprietaria, che soccombe al cospetto di un credo assoluto:
«Lei non mi ama, Sonia».
«Dipende da quel che chiama amore».
L’epilogo è tragico, come in ogni scenario in cui le disgrazie collettive risuonano negli atti dei singoli, quando tra storia individuale e storia generale si verifica un’inesorabile amplificazione.
Jean-Marie Gustave Le Clézio, Stella errante (1992; traduzione italiana di E. Assetta, Il Saggiatore 2010) [Elio Baldi]
Stella errante di Jean-Marie G. Le Clézio – scrittore francese-mauriziano, premio Nobel 2008 – è una storia nella Storia, un libro del 1992 sugli anni Quaranta, ma attualissimo. Dalla prospettiva di Esther, dai suoi occhi di ragazza di tredici anni, scopriamo cosa significa essere ebrei nel 1943, nella campagna intorno a Nizza occupata dagli Italiani, e leggiamo del viaggio dopo la seconda guerra mondiale verso la terra promessa (ma non di pace). In Palestina ci sarà un incontro, solo un attimo, con Nejma, ragazza palestinese che poi Esther non vedrà più, ma che le rimarrà impressa, e viceversa. I loro destini e i loro esili si incontrano brevemente per poi essere separati da una guerra che non è più finita. Ma l’incontro tra le due offre immagini di speranza, così come lo sguardo di Esther che si immedesima nelle nuvole, negli uccelli, in tutta la natura che si muove seguendo un ritmo libero, un’altra logica. È soprattutto l’acqua a determinare il flusso del libro e ad accompagnare i viaggi di Esther: tra fiumi e mare, fontane e pozzi, l’acqua scorre per tutto il libro, viaggiando senza perdersi, immensa e inconoscibile come Dio, offrendo una musica di libertà. È il suono rassicurante del più antico ricordo di Esther, che le parla anche di futuro. E riverbera in tutto il libro, nel ritmo delle preghiere degli esuli, nella musica della lingua maestosa, poetica, ondosa, onomatopeica di Le Clézio. Un libro di dolorosa bellezza, da leggere con ostinata speranza.